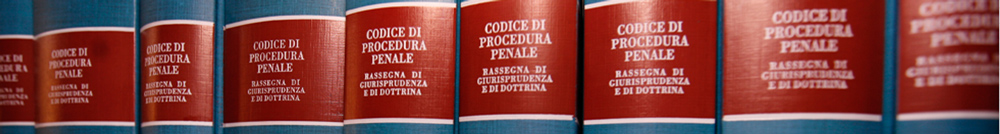Banca Dati
Truffa o appropriazione indebita? Tra i due litiganti, il terzo (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato) gode
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4404/16; depositata il 3 febbraio)
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’INPS: il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Il caso. La Suprema Corte (sentenza n. 4404/2016, depositata il 3 febbraio) era chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila che lo aveva giudicato colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 640, commi 1 e 2, c.p.p., per aver, attraverso artifici e raggiri, posto indebitamente a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS le somme asseritamente corrisposte ad alcuni dipendenti a titolo di indennità di malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, inducendo in errore l’Istituto previdenziale circa l’effettivo ammontare delle somme dovute e procurandosi ingiusto profitto con pari danno dell’ente.
Il ricorrente assumeva come nella propria condotta non fosse possibile ravvisare gli estremi di quella prevista e punita dalla norma incriminatrice, posto che egli aveva correttamente rappresentato la propria posizione creditoria e debitoria nei confronti dell’Istituto evidenziando nella denuncia contributiva l’esistenza del proprio debito nei confronti dei lavoratori per quanto riguardava le somme da corrispondere per indennità di malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni.
L’imputato sarebbe dunque incorso in mero errore integrando con la propria condotta, al più, evasione contributiva ai sensi dell’art. 37, L. n. 689/81.
Il Procuratore generale chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la Corte. La Corte ricostruisce la fattispecie: partendo da una ricostruzione storica circa la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall’imputato, storicamente sussunta nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 640 del c.p. e non in quella meno grave descritta dall’art. 37, legge n. 689/81, effettua alcune riflessioni che paiono essere di certo interesse.
La vecchia soluzione … La soluzione storicamente riservata alla questione giuridica, ovvero quella di inquadrare la condotta quale integrante il reato di truffa, lasciava, e lascia posto che essa non è definitivamente eradicata dal panorama giurisprudenziale, molti dubbi.
Non era infatti semplice identificare quali fossero gli artifizio e raggiri posti in essere dal datore di lavoro (che in realtà aveva correttamente comunicato all’Istituto la reale situazione) e, tantomeno era semplice identificare il danno arrecato all’ente medesimo posto che i “danneggiati” dalla condotta non potevano che essere i lavoratori (invece esclusi da qualsiasi forma di tutela).
In assenza di due elementi costitutivi del reato la dichiarazioni di colpevolezza appariva essere più una affermazione volta a tutelare un principio attinente alla correttezza nei rapporti tra ente e datori di lavoro che il corretto esito del procedimento di sussunzione.
La sentenza 18762 del 15/01/2013. Partendo da queste riflessioni la Corte con la pronuncia richiamata dichiarava come nella condotta descritta non potesse ravvisarsi il reato di truffa ma, al più, quello di appropriazione indebita.
La situazione segnalata all’ente infatti è perfettamente corrispondente a quella reale ed è idonea a procurare al datore di lavoro un ingiusto profitto ma inidonea a determinare alcun danno in capo all’ente medesimo poiché il lavoratore per ottenere il versamento delle somme spettantigli potrebbe rivolgersi solo al datore di lavoro e non all’INPS.
Dunque si verserebbe in un caso pacifico di appropriazione indebita posto che il datore di lavoro tratterrebbe, appropriandosene, somme spettanti al proprio dipendente.
La soluzione proposta: la Seconda Sezione Penale della Corte compie un’altra scelta. Nessuna delle due soluzioni prospettate può essere condivisa.
Pacifico che nella condotta descritta non possa essere ravvisata quella prevista e punita dall’articolo 640 del c.p., stante l’assenza di artifici e raggiri e di danno in capo all’ente, non ritiene nemmeno applicabile, senza fornirne motivazione, neppure la soluzione prospettata dalla stessa sezione (in altro Collegio ?) ovvero quella di inquadrare la condotta nella fattispecie di appropriazione indebita, rinvenendo la norma incrimiantrice in quell’articolo 316 ter che, come è noto, costituisce norme speciale rispetto all’art. 640 bis del c.p..
La Corte richiama la qualificazione, che essa ha fornito, della norma in esame quale integrante fattispecie di pericolo e non di danno ricordando come detto reato si distingua «da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sia perché la condotta non riveste natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l’assenza della induzione in errore».
A sostegno della tesi vengono portate tre pronunce di grande portata: l’una della Corte Costituzionale (ordinanza 95/2004) e due delle SS.UU. (16568/2007 e 235962/2007) con le quali viene da un canto (Corte Costituzionale) affermata la tutela aggiuntiva e complementare dell’articolo 316 ter rispetto a quella offerta dall’articolo 640 bis c.p., e dall’altro (SS.UU) come l’introduzione della norma (316 ter c.p.) abbia risposto all’intento di estendere la punibilità a condotte decettive (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell’ambito operativo della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dimodoché, dice la Corte, «fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa vanno inquadrate nella fattispecie dell’articolo 316 ter le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore con la conseguente compressione dell’articolo 316 ter c.p. a situazioni del tutto marginali come quella del mero silenzio antidoveroso di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale».
La pronuncia delle SS.UU. 7537/2010. A sostegno definitivo del ragionamento giuridico la Corte richiama la più recente pronuncia delle SS.UU. con la quale veniva affermato il principio ai sensi del quale «l’art. 316 ter c.p. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio anti doveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente» concludendo, del tutto in linea logica con il presupposto, come la norma sia rivolta specificamente «a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati» sanzionando «la percezione di per sé indebita delle erogazioni senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali».
Deve ritenersi che il delitto di cui all’art. 316 ter c.p. prescinda sia dall’esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa sia dall’esistenza di artifici e raggiri sia dall’induzione in errore della persona offesa.
Dunque sia una condotta del tutto differente rispetto a quella richiesta dall’articolo 640 c.p.
(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)