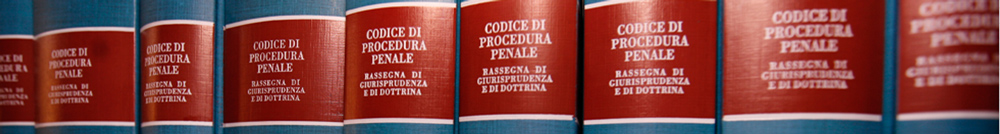Imprese ed Aziende
Princìpi del giusto processo e potere del Giudice di dichiarare d’ ufficio il fallimento quando accerti lo stato di decozione. Secondo la Corte Costituzionale non c’ è contrasto
Corte Costituzionale Sentenza 30 giugno – 15 luglio 2003 240/2003 Sentenza. Presidente Chieppa – Relatore Vaccarella Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con n. 4 ordinanze del 18 (n. 2 ordinanze), del 29 e del 27 maggio 2002 della Corte d’appello di Venezia e del 5 ottobre 2002 del Tribunale di Saluzzo, rispettivamente iscritte ai nn. 348, 349, 368, 372 e 548 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33, 34, 35, prima serie speciale, dell’anno 2002 e nella edizione straordinaria, prima serie speciale, del 27 dicembre 2002. Visti gli atti di costituzione della Valdefin s.p.a., Lifegroup s.p.a., Researchlife s.c.p.a., Dermalife s.p.a. e del Fallimento Valdefin s.p.a., Fallimento Lifegroup s.p.a., Fallimento Researchlife s.c.p.a. e Fallimento Dermalife s.p.a.; udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2003 e nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella; uditi gli avv.ti Elena Donzi per la Valdefin s.p.a., Lifegroup s.p.a., Researchlife s.c.p.a., Dermalife s.p.a. e Nicola Picardi per il fallimento Valdefin s.p.a., Fallimento Lifegroup s.p.a., Fallimento Researchlife s.c.p.a. e Fallimento Dermalife s.p.a. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di quattro giudizi di appello, promossi dalle fallite società Valdefin s.p.a., Lifegroup s.p.a., Researchlife s.c.p.a. e Dermalife s.p.a. nei confronti dei curatori dei rispettivi fallimenti, avverso le sentenze del Tribunale di Padova, tutte in data 29 aprile 1999, con le quali erano state rigettate le opposizioni alle dichiarazioni di fallimento, la Corte d’appello di Venezia, con distinte ordinanze, recanti identica motivazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui consente la dichiarazione d’ufficio del fallimento dell’imprenditore, in violazione del principio di terzietà del giudice. 1.1.- In punto di fatto, riferisce la Corte rimettente che il fallimento delle quattro società appellanti era stato dichiarato d’ufficio, con distinte sentenze in data 19 luglio 1996, a seguito di ispezione giudiziale dell’amministrazione delle medesime società, disposta dal Tribunale di Padova ai sensi dell’art. 2409 del codice civile con decreto del 28 giugno 1996, dei cui risultati il giudice delegato all’istruzione della procedura aveva riferito al presidente della sezione, il quale, a sua volta, lo aveva nominato giudice delegato all’audizione dei legali rappresentanti, avviando, così, il procedimento officioso. Nei rispettivi atti di appello – riferisce ancora la rimettente – le fallite hanno eccepito l’illegittimità costituzionale degli articoli 6 e 8 del richiamato regio decreto n. 267 del 1942 (di seguito, “legge fallimentare”) in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; in sede di discussione della causa, poi, hanno evocato anche i principi dettati dall’art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2(Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione). 1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte veneziana osserva che il principio della “terzietà” del giudice, costituzionalmente sancito dal nuovo art. 111 Cost., richiede che il giudice non solo agisca come terzo, ma appaia anche tale, “poiché la mancanza di tale condizione esteriore è sufficiente a compromettere la credibilità della sua funzione di garante della corretta applicazione del diritto”, e che detto principio non può prescindere dalla distinzione tra il soggetto che propone una domanda giudiziale e quello che sulla stessa è chiamato a pronunciarsi. Discende da ciò – ad avviso della medesima Corte territoriale – l’inderogabilità del principio della domanda e la non compatibilità, con la garanzia costituzionale, dei procedimenti ad iniziativa dell’organo giudicante. In particolare essa rileva che l’art. 6 legge fall., nel prevedere che il fallimento possa essere dichiarato d’ufficio – quando il giudice competente alla pronuncia, nell’esercizio della sua attività o per rapporto di altro giudice (a norma dell’art. 8 legge fall.), acquisisca la conoscenza dello stato di insolvenza di un imprenditore – consente l’avvio del procedimento prefallimentare ad iniziativa dello stesso organo giudicante, sulla base di una delibazione che non può essere puramente formale, ma che implica necessariamente una valutazione sommaria di merito dei presupposti legittimanti l’iniziativa medesima, di modo che si dà avvio ad un giudizio che non appare rispettoso del principio di terzietà. Né – prosegue la Corte rimettente – la specialità della procedura fallimentare, giustificata dalle connotazioni pubblicistiche e dalle esigenze d’urgenza che le sono proprie, può assumere rilevanza in relazione al rispetto dell’indicato principio tutelato dalla Carta fondamentale: le esigenze sottese all’iniziativa officiosa potrebbero trovare sufficiente tutela nell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento affidata al pubblico ministero dallo stesso art. 6 legge fall., alla quale deve riconoscersi portata generale e non limitata alle sole ipotesi considerate dal successivo art. 7 legge fall. 1.3.- Quanto alla rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva che essa discende da ciò, che anche in grado di appello si verte sulla legittimità dell’iniziativa d’ufficio che ha portato alla dichiarazione di fallimento delle società appellanti, esclusa la quale l’appello dovrebbe essere accolto. 1.4.- Si sono ritualmente costituite le società appellanti, le quali con identici atti di costituzione, deducono, a sostegno dell’eccezione di incostituzionalità, che: a) le norme sul fallimento d’ufficio trascurano le garanzie di estraneità del giudice al giudizio, violando i principi del giusto processo, recepiti anche dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; b) l’iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento, benché riconducibile alla previsione dell’art. 2907 cod. civ., di fatto appare non rispettosa del diritto alla difesa, garantito dall’art. 24 Cost., giacché a seguito di essa non si viene a formare un contraddittorio vero e proprio, in mancanza del sostanziale controinteressato, che è il ceto creditorio; c) il procedimento officioso non si svolge nelle “condizioni di parità”, volute dall’art. 111 Cost., poiché il giudice procedente, a differenza dell’imprenditore, riveste una posizione di autorità e di potere; d) l’organo giudicante, nelle due fasi in cui si articola il procedimento (quella preliminare e quella conseguente all’iniziativa), svolge una doppia cognizione sullo stesso oggetto, costituito dall’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, sulla base del medesimo materiale probatorio, senza che la parte abbia alcuna possibilità di interferire attivamente nell’ambito di una dialettica processuale; e) l’opposizione alla dichiarazione di fallimento non fornisce una adeguata tutela successiva, poiché la sentenza dichiarativa è munita di forza esecutiva, che non viene meno se non con il passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di revoca. Concludono pertanto le appellanti per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 legge fall., nonché dell’art. 8 legge fall., essendo questa norma strettamente connessa alla prima, a fronte dei principi espressi negli artt. 3, 24 e 101 Cost. e ribaditi nell’art. 111 Cost. 1.5.- Si sono, altresì, ritualmente costituiti i curatori dei fallimenti, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata. 1.6.- In prossimità dell’udienza, le curatele dei fallimenti hanno depositato memorie di identico contenuto, illustrando le ragioni per le quali hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza della questione di legittimità costituzionale de qua. Osservano, in particolare, a sostegno dell’inammissibilità, che: a) i fallimenti delle società Lifegroup s.p.a. e Dermalife s.p.a., come si evince dalla motivazione delle rispettive sentenze, sono stati dichiarati su istanze di più creditori e non già di ufficio, sicché la questione relativamente a detti fallimenti è irrilevante; b) i procedimenti per la dichiarazione dei fallimenti de quibus sono stati instaurati a seguito di segnalazione ex art. 8 legge fall. (che, per i fallimenti Lifegroup s.p.a. e Dermalife s.p.a., si è aggiunta alle istanze dei creditori), proveniente da un giudice diverso dal tribunale che ha provveduto, e quindi da un soggetto “terzo”; sicché non potrebbe dirsi violato il principio di terzietà; c) l’art. 6 legge fall., oggetto della questione, non dovrebbe essere applicato nei giudizi di appello pendenti dinanzi alla Corte rimettente, in quanto la sua applicazione è già avvenuta ad opera delle sentenze dichiarative dei fallimenti, emesse dal Tribunale di Padova in data 19 luglio 1996: la nullità delle anzidette sentenze, conseguente alla dedotta illegittimità costituzionale, avrebbe dovuto essere fatta valere con l’opposizione ex art. 18 legge fall.; non essendo ciò avvenuto, la rilevabilità del vizio è ormai definitivamente preclusa, sicché nessuna influenza può avere l’eventuale pronuncia di incostituzionalità sui giudizi di appello a quibus. Quanto al merito della questione, le curatele osservano che le deroghe al principio della domanda, consentite dall’art. 2907 cod. civ., non importano di per sé lesione dei principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1965, n. 17. Al riguardo, in dottrina si è affermato che l’iniziativa del processo è una sorta di variabile indipendente che il legislatore, volta a volta, risolve, conferendone il potere a determinati soggetti o addirittura all’ufficio. D’altro canto, il nuovo art. 111 Cost. non ha innovato quanto ai principi di terzietà e imparzialità del giudice, giacché essi venivano ricavati, già prima della legge cost. n. 2 del 1999, dall’esame consequenziale degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. Ciò posto, l’art. 6 legge fall., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non viola affatto i principi di terzietà e imparzialità del giudice, ora affermati (anche) dall’art. 111 Cost., avendo la Corte di cassazione chiarito che “il potere di pronuncia di ufficio previsto dall’art. 6 legge fall., non consente al tribunale la dichiarazione di fallimento d’ufficio in base ad una qualsiasi conoscenza ricevuta di uno stato di insolvenza”; e, se è vero che le ipotesi di iniziativa d’ufficio non possono restringersi ai soli casi espressamente previsti dalla legge fallimentare (artt. 137, 138, 147, 162, 163, 173, 179, 181, 188, 192, 193), tuttavia è da ritenere che il tribunale in tanto possa assumere un’iniziativa officiosa in quanto “acquisisca la conoscenza di un’insolvenza imprenditoriale nell’esercizio della sua ordinaria attività”, ovvero attraverso il “rapporto di un altro giudice per situazioni emerse in altro procedimento giurisdizionale” (Cass. 9 marzo 1996, n. 1876). 2.- Nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento, promosso nei confronti della società Effebi di Fusco Antonello e C. s.a.s., a seguito di rapporto ai sensi dell’art. 8 legge fall., il Tribunale di Saluzzo, con ordinanza del 5 ottobre 2002, solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., degli artt. 6 e 8 legge fall., nelle parti in cui prevedono, il primo, che il fallimento possa essere dichiarato d’ufficio e, il secondo, che il giudice debba riferire dell’insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso detto tribunale, così violando i principi del “giusto processo”, e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dalla richiamata norma costituzionale. 2.1.- Il Tribunale rimettente espone, in punto di fatto, che un giudice dello stesso ufficio giudiziario, investito di una domanda per decreto ingiuntivo a carico della Effebi di Fusco Antonello e C. s.a.s., ravvisava la sussistenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza della debitrice e ne riferiva al presidente, ai sensi del citato art. 8 legge fall. Nominato il giudice relatore per l’audizione dei fallendi e l’istruttoria di rito, il Tribunale, prima che si procedesse a tali incombenti, con ordinanza del 16 marzo 2001, sollevava questione di legittimità costituzionale nei termini di cui innanzi. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 411 del 10 luglio 2002 (depositata il 26 luglio 2002), dichiarava inammissibile la questione. Preso atto di ciò, il giudice relatore procedeva alla convocazione del socio accomandatario Antonello Fusco e, su decreto collegiale, all’assunzione di informazioni; all’esito, riferiva al collegio. Il Tribunale, quindi, pronunciava l’ordinanza in epigrafe, con la quale sollevava nuovamente identica questione di legittimità costituzionale e disponeva la sospensione del procedimento prefallimentare. 2.2.- Osserva il giudice rimettente che il principio ne procedat iudex ex officio, affermato in via generale dall’art. 2907 cod. civ. e dagli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile, trova una delle sue più rilevanti eccezioni nella legge fallimentare, laddove l’art. 6 prevede che il fallimento dell’imprenditore commerciale in stato di insolvenza possa essere dichiarato anche per iniziativa autonoma dello stesso tribunale territorialmente competente, in carenza di esercizio della cosiddetta “azione fallimentare” da parte di soggetti a tanto legittimati (ossia da parte di uno o più creditori, dello stesso debitore o del pubblico ministero), diversi dall’organo giudiziario chiamato a decidere. Osserva, ancora, che il potere di iniziativa officiosa del tribunale è dotato dalla legge fallimentare di due (non esclusivi) canali di attivazione: il primo è costituito dall’obbligo ex art. 8 legge fall. del giudice civile di riferire circa lo stato di insolvenza di un imprenditore, emerso nel corso di un giudizio in cui questi sia parte; il secondo dall’obbligo ex art. 13 legge fall. di trasmissione al presidente del tribunale degli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento. Osserva, altresì, che andrebbero tenute distinte dalla fattispecie prevista dall’art. 6 legge fall., in quanto caratterizzate da una situazione di mera doverosità, e perciò non integranti un vero e proprio esercizio officioso dell’”azione fallimentare”, le ipotesi di “automatica” dichiarazione di fallimento, previste nella patologia del concordato preventivo (artt. 162, secondo comma, 163, secondo comma, 173, 179, 181, secondo comma, 186, terzo comma, legge fall.) e dell’amministrazione controllata (artt. 192, terzo comma, 193, secondo comma, legge fall.). Accanto a queste andrebbero collocate le ipotesi di dichiarazione di fallimento di grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria ex art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), e di dichiarazione di stato di insolvenza di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ex art. 195, settimo comma, legge fall. e di imprese soggette ad amministrazione straordinaria ex art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999. 2.3.- Ad avviso del rimettente, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il tribunale, a norma dell’art. 6 legge fall., non può dichiarare d’ufficio il fallimento in base alla conoscenza di uno stato di insolvenza in qualsiasi modo ricevuta, ma – com’è desumibile dall’art. 8 legge fall. – in tutte le ipotesi in cui esso tribunale acquisisca la conoscenza dell’insolvenza di un imprenditore nell’esercizio della sua ordinaria attività giurisdizionale, ovvero grazie al rapporto di un altro giudice per situazioni emerse in un diverso procedimento giurisdizionale (Cass. 9 marzo 1996, n. 1876), non può essere condiviso, perché, da un lato, finisce col privare di ratio la norma dell’art. 13 legge fall., la quale, invece, è preordinata all’esercizio officioso dell’”azione fallimentare” in assoluta carenza sia di domanda di parte sia di previa attività giurisdizionale, e, dall’altro, non tiene conto che la segnalazione del giudice civile ex art. 8 legge fall. in sé non è diversa da qualunque altra notizia di insolvenza emersa aliunde. Sostiene, pertanto, che l’art. 6 legge fall. va interpretato nel senso che l’iniziativa officiosa è attivabile ogni qual volta il tribunale apprenda una notitia decoctionis in qualunque modo, non quindi esclusivamente attraverso il canale informativo dell’art. 8 legge fall., com’è – a suo avviso – costante indirizzo della giurisprudenza di merito. 2.4.- Così delineato il quadro normativo di riferimento, il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione, in quanto i principi del “giusto processo”, introdotti nell’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 – già rintracciabili nella Carta costituzionale attraverso una lettura combinata di altre norme (artt. 24, 25, 97, 101 e 106 Cost.) –, hanno fatto sì che ad “una presenza diffusa e non concettualmente espressa” dei principi di terzietà e imparzialità del giudice si sostituisse “l’attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri fondanti il “giusto processo””; sicché la violazione dell’imparzialità e della terzietà del giudice assurge de iure condito a vizio di incostituzionalità non recuperabile altrimenti. Secondo il rimettente, pertanto, l’iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento, prevista dall’art. 6 legge fall., confligge con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, “di cui il canone nulla iurisdictio sine actione costituisce l’indefettibile corollario logico”: il concetto di terzietà e imparzialità del giudice è connaturato ad una dialettica processuale tra una parte che dice e una che contraddice, rispetto alle quali il giudice si trova in posizione di equidistanza, e viene leso quando la stessa autorità che deve decidere si è autonomamente attivata contro la parte cui il provvedimento decisorio è destinato. I principi di terzietà e imparzialità – prosegue il giudice rimettente – “subiscono un’inevitabile compressione laddove il giudice si comporti sostanzialmente come attore, rischiando perciò di condividere pregiudizialmente la prospettazione attribuita ab intra al caso da sé posto al proprio vaglio”. Per di più – egli aggiunge – il giudice non solo deve essere, ma deve apparire terzo ed imparziale, e non può ammettersi che l’imprenditore chiamato a difendersi davanti al tribunale che lo deve giudicare possa anche soltanto dubitare della terzietà e della imparzialità del tribunale medesimo. Il giudice rimettente osserva, poi, che il paradigma del “giusto processo” ex art. 111, secondo comma, Cost. risulta insidiato anche sotto il profilo del contraddittorio, giacché, dovendo il giudice essere “terzo”, non è più ipotizzabile un processo giurisdizionale senza (almeno) due parti contrapposte: ove manchi il contraddittorio fra parti contrapposte, come avviene nel caso del procedimento prefallimentare aperto d’ufficio ex artt. 6 e 8 legge fall., in cui di fronte al debitore non vi è un legittimo contraddittore, il convincimento del giudice non può dirsi immune da “pre”-giudizi, “proprio perché matura in una logica autoreferenziale sottratta alla ginnastica dialettica del contraddittorio coessenziale alla dinamica del “giusto processo””. Né – prosegue ancora il giudice rimettente – si può superare il problema, ascrivendo il procedimento prefallimentare alla cosiddetta “giurisdizione volontaria” o qualificandolo come “processo senza parti”, dal momento che la dichiarazione di fallimento comporta una notevole capitis deminutio dell’imprenditore, la quale comprime valori di rilievo costituzionale; sicché non può ammettersi che ad essa si pervenga attraverso un’attività giurisdizionale non modellata sui principi del “giusto processo”, ancorché sussista un interesse pubblico alla sollecita liquidazione coattiva dell’impresa insolvente e alla sua eliminazione dal mercato. 2.5.- La prospettata censura dell’art. 6 legge fall. – ad avviso del giudice rimettente – rende consequenziale il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 8 legge fall., nella parte in cui dispone che il giudice civile debba riferire dello stato di insolvenza al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso di esso. Se a tale tribunale non può riconoscersi il potere di iniziativa officiosa, sembra più conforme al paradigma costituzionale del “giusto processo” ritenere che la relazione del giudice civile debba essere rivolta non al tribunale, ma al pubblico ministero, essendo questo l’organo istituzionalmente preposto all’esercizio dell’azione civile nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 75, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nonché all’esercizio dell’azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico, a norma dell’art. 73, secondo comma, dello stesso ord. giud. 2.6.- Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, essendo stata espletata l’istruttoria, la pronuncia sull’insolvenza, segnalata ex art. 8 legge fall., è condizionata alla soluzione del prospettato dubbio di costituzionalità. Considerato in diritto 1.- I giudizi devono essere riuniti per la loro evidente connessione. La Corte d’appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale del solo art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), laddove il Tribunale di Saluzzo dubita della legittimità costituzionale anche dell’art. 8 dello stesso regio decreto (di seguito, “legge fallimentare”), entrambi in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Il dubbio investe l’art. 6 legge fall., nella parte in cui prevede che il fallimento possa essere dichiarato d’ufficio dal tribunale, e l’art. 8 legge fall., in quanto prevede che il giudice debba riferire dell’insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso detto tribunale, così derogando al principio della domanda, costituente “indefettibile corollario logico” dei principi di terzietà e imparzialità del giudice. 2.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni proposte dalla difesa delle curatele dei fallimenti, volte a far dichiarare inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia. Tali eccezioni sono infondate. Quella secondo la quale i fallimenti delle società Lifegroup s.p.a. e Dermalife s.p.a. sarebbero stati dichiarati anche su istanza di creditori – e, pertanto, non d’ufficio – non considera che i procedimenti autonomamente promossi dai creditori non risultano formalmente riuniti a quelli promossi d’ufficio e sfociati nelle sentenze dichiarative di fallimento. E’ vero che nelle due sentenze dichiarative si fa cenno alle istanze dei creditori, ma del tutto irritualmente, come confermano le circostanze che gli atti di opposizione a tali sentenze sono stati notificati soltanto ai curatori, che in tali giudizi di opposizione non è stata disposta l’altrimenti doverosa (ex art. 18, terzo comma, legge fall.) integrazione del contraddittorio nei confronti dei “creditori richiedenti” e che, infine, le sentenze di rigetto delle opposizioni non sono state emesse (anche) nei confronti di tali creditori. Ne consegue che anche i fallimenti della Lifegroup s.p.a. e della Dermalife s.p.a. devono ritenersi dichiarati d’ufficio. Anche l’eccezione, secondo la quale la questione della nullità delle sentenze dichiarative di fallimento avrebbe dovuto essere fatta valere con l’opposizione ex art. 18 legge fall. e, pertanto, sarebbe preclusa in sede di appello sub specie di pretesa illegittimità costituzionale, deve essere respinta, (se non altro) perché dagli atti risulta che l’illegittimità della dichiarazione officiosa fu dedotta dalle società fallite con l’opposizione alla sentenza dichiarativa (anche – ma ciò è irrilevante – denunciando il contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 Cost., non essendo ancora intervenuta la legge cost. n. 2 del 1999). 3.- Le questioni di legittimità costituzionale poste dai giudici rimettenti non sono fondate. 3.1.- Evidentemente consapevoli che questa Corte ha in passato più volte statuito che, di per sé, eccezioni alla “regola ne procedat iudex ex officio non importano lesione del principio della imparzialità del giudice” (sentenze n. 17 del 1965; n. 123 del 1970; n. 148 del 1996) e, anzi, ha espressamente riconosciuto la legittimità costituzionale di iniziative officiose (sentenza n. 133 del 1993) e, talvolta, le ha ripristinate (sentenze n. 41 del 1985 e n. 46 del 1995), sancendone la compatibilità con il valore del “giusto processo”, entrambi i giudici rimettenti muovono dalla premessa che il nuovo art. 111 Cost., avendo attribuito “autonoma dignità costituzionale ai caratteri fondanti il giusto processo” (in precedenza allo “stato diffuso” in altre norme costituzionali), avrebbe reso assoluti i valori della terzietà e della imparzialità, e, pertanto, rilevante la loro violazione pur se siano rispettate le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa. 3.2.- Questa Corte – che, anteriormente alla legge cost. n. 2 del 1999, aveva ripetutamente fatto riferimento al principio di imparzialità-terzietà come connaturale alla funzione giurisdizionale (sentenze n. 93 del 1965; n. 41 del 1985; n. 148 del 1996; n. 351 del 1997; n. 363 del 1998) – ha, poi, chiarito che, quanto alla tutela di tale principio, il novellato art. 111 Cost. non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione (ordinanze n. 75 e n. 168 del 2002); sicché meramente nominalistico appare l’argomento che, in senso contrario, vorrebbe dedursi dalla locuzione “giudice terzo e imparziale”, quasi che essa sia espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale e non già la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l’ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla res iudicanda. 4.- Certamente contraria – ma altrettanto certamente già prima della legge cost. n. 2 del 1999 – al principio di imparzialità-terzietà è la fusione, in un unico soggetto, delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda, ma ciò non implica la costituzionalizzazione del processual-civilistico principio della domanda e il bando di qualsiasi iniziativa officiosa. E, in effetti, le ordinanze di rimessione rivelano chiaramente come il “principio della domanda” sia, da esse stesse, assunto esclusivamente nella accezione (ben diversa da quella, processual-civilistica appunto, che ha come suo corollario il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) per cui soltanto l’impulso iniziale al procedere deve provenire da un soggetto diverso da quello chiamato a giudicare. 4.1.- La circostanza che, ad espresso avviso del Tribunale di Saluzzo (e, implicitamente, anche della Corte veneziana), non siano sospettabili di illegittimità costituzionale le numerose ipotesi in cui la legge fallimentare parla di dichiarazione d’ufficio del fallimento in relazione al concordato preventivo (artt. 162, 163, 173, 179, 181, 186 legge fall.) e all’amministrazione controllata (artt. 188, 192 e 193 l. fall.) è significativa del modo in cui è inteso il “principio della domanda”: il tribunale, che, respingendo la domanda di ammissione all’amministrazione controllata o al concordato preventivo, dichiara d’ufficio il fallimento, certamente pronuncia extra petita, e, però, lo farebbe legittimamente perché investito di una situazione (comprensiva del presupposto oggettivo del fallimento: l’insolvenza, ma dedotta o come temporanea difficoltà di adempiere o come più proficuamente risolvibile con il concordato) prospettatagli dall’imprenditore; sicché vi sarebbe pur sempre ab externo l’impulso all’esercizio di poteri che il tribunale, tuttavia, non è tenuto a mantenere nell’alveo segnato dalla domanda di parte. E quel medesimo impulso iniziale dell’imprenditore giustifica, in assenza di qualsiasi domanda ulteriore, la dichiarabilità d’ufficio del fallimento in pendenza della procedura ora a titolo lato sensu “sanzionatorio” (artt. 173 e 186 legge fall.), ora prendendo atto del dissenso del ceto creditorio (art. 179 legge fall.), ora perfino andando di contrario avviso rispetto ai creditori (art. 181 legge fall.). Il “principio della domanda”, al quale fanno riferimento i rimettenti, e che sarebbe costituzionalizzato dal novellato art. 111 Cost., dunque, si identifica con un qualsiasi atto di impulso, proveniente da soggetto diverso dal giudice, che sottoponga al di lui giudizio una situazione fattuale potenzialmente riconducibile (anche se dall’istante non ricondotta) ai presupposti del fallimento: se l’imprenditore che propone il concordato preventivo esplicita lo stato d’insolvenza in cui versa, altrettanto farebbe, pur se qualificandolo come temporanea difficoltà di adempiere, l’imprenditore che chiede di essere ammesso all’amministrazione controllata, sicché le due ipotesi hanno in comune l’estraneità dell’impulso iniziale rispetto al giudice e si differenziano soltanto per la diversa qualificazione giuridica che l’istante dà (nell’istanza di ammissione all’amministrazione controllata) ad una situazione di fatto che il giudice è libero di valutare e qualificare come insolvenza. 4.2.- Così delimitato il significato del “principio della domanda”, al quale alludono – ritenendolo “costituzionalizzato” dall’art. 111 Cost. – i giudici rimettenti, è evidente che si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità) la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente: dal creditore sedicente o non legittimato o rinunciante, ovvero dal pubblico ministero. 4.3.- E’ opinione dominante in giurisprudenza e in dottrina che l’art. 8 legge fall. comprenda, oltre a quella in cui altro giudice riferisca dell’insolvenza al tribunale (v. 4.4.), l’ipotesi in cui lo stato d’insolvenza di un imprenditore emerga davanti al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento; sicché in questa ipotesi (diversa dalla vicenda che ha originato la questione sollevata dal Tribunale di Saluzzo, ma – almeno apparentemente – coincidente con quanto denunciato dalla Corte d’appello di Venezia) si pone il problema della identità del giudice che assume l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento con il giudice che su tale iniziativa è chiamato a pronunciarsi. Questa Corte ha più volte osservato che “il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento” (sentenza n. 387 del 1999), sicché l’identità del giudice può coniugarsi con “la sua veste giurisdizionale e quindi super partes”, senza far sì che il giudice agisca, e appaia, come l’attore del procedimento sul quale giudica (sentenza n. 148 del 1996). Il costante orientamento di questa Corte, in altri termini, è nel senso che anche l’iniziativa officiosa – prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell’officiosità dell’iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti. Tale fondamentale requisito del giudice sarebbe certamente compromesso ove al tribunale fallimentare fosse consentito, come pure in passato si è ritenuto, di promuovere il procedimento prefallimentare sulla base di una notitia decoctionis comunque acquisita, ma non può dirsi compromesso ove la conoscenza di una situazione di fatto in ipotesi riconducibile allo stato di insolvenza derivi (non già da quella che, attesa l’informalità della fonte, ben può definirsi scienza privata del giudice, bensì) da una fonte qualificata, perché formalmente acquisita nel corso di un procedimento, del quale il giudice sia, come tale, investito: come conferma la ben diversa formulazione degli artt. 6 e 8 legge fall. rispetto alla corrispondente norma (art. 688) del codice di commercio (che autorizzava il tribunale a dichiarare d’ufficio il fallimento “se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti”). In tale ipotesi, e solo in tale ipotesi, il giudice investito di un procedimento, del quale sia parte (o al quale, comunque, partecipi) l’imprenditore, può legittimamente acquisire la conoscenza di una situazione di fatto, delibata positivamente la quale deve avviare la procedura prefallimentare e giudicare, dopo aver consentito all’imprenditore il pieno esercizio del diritto di difesa in relazione ai fatti delibati, della fondatezza della notitia decoctionis. Infatti il tribunale, acquisita, nelle forme di legge, la notizia di una situazione di fatto nella quale si profilano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. e delibatane la consistenza, è tenuto ad aprire il procedimento per accertare la sussistenza degli anzidetti presupposti, senza avere alcuna discrezionalità al riguardo, essendogli del tutto preclusa dalla legge ogni valutazione di opportunità: in simile ipotesi, quindi, l’iniziativa officiosa è “doverosa”, non meno che nelle specifiche ipotesi (sub 4.1.) di dichiarazione di fallimento d’ufficio previste dalla legge fallimentare. Le prevalenti finalità pubblicistiche, che caratterizzano la procedura fallimentare (sentenze n. 141 e n. 142 del 1970, n. 110 del 1972, n. 148 del 1996), impongono al tribunale di attivarsi anche in assenza di un’iniziativa di parte, dando così attuazione alla volontà della legge, che ha già valutato, preventivamente e una volta per tutte, l’interesse pubblico sotteso; di tal che non può dubitarsi che il tribunale, procedendo d’ufficio, “agisca non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e quindi super partes” (sentenza n. 148 del 1996). Ed è solo all’esito della successiva attività istruttoria, da espletarsi nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio, che può pervenirsi all’accertamento dei presupposti del fallimento: è da escludere, dunque, che l’imprenditore, convocato in camera di consiglio, possa trovarsi di fronte ad un giudice che abbia già maturato il suo convincimento (il “convincimento di un giudice-attore”, per usare ancora un’espressione della sentenza n. 148 del 1996), questo dovendo formarsi dopo, non già prima, dell’atto di iniziativa officiosa. L’esigenza che il tribunale sia formalmente investito di un procedimento dal quale emerga lo stato di insolvenza giustifica pienamente – oltre alla dichiarazione d’ufficio connessa a procedure concorsuali minori (retro 4.1.) – la estensione d’ufficio del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 legge fall.), mentre la medesima conclusione non può essere tratta a proposito dell’art. 13 legge fall.: tale norma, infatti, si limita a prevedere che il presidente del tribunale – come tale non investito di alcuna “ordinaria attività giurisdizionale” – riceva l’elenco dei protesti levati nei quindici giorni precedenti, e, pertanto, si limita a far acquisire un elemento istruttorio, utilizzabile (dal collegio) ove sia legittimamente iniziato il procedimento, disponendo l’audizione del fallendo (ordinanza n. 411 del 2002). Analogamente, non può dirsi legittimamente investito di un procedimento il singolo magistrato componente di un collegio, se al collegio soltanto la legge riconosce la qualità di giudice e se il collegio soltanto, quindi, può legittimamente acquisire e legittimamente delibare la notitia decoctionis (nel caso di cui alle ordinanze di rimessione nn. 348, 349, 368 e 372 del 2002, fornita da un ispettore nominato ex art. 2409, secondo comma, cod. civ.): non può certamente riconoscersi – ove la legge non riservi al singolo componente del collegio (ad es., al giudice istruttore) una sua propria funzione – né al relatore né al presidente del collegio, uti singuli, la qualità di giudice, sicché soltanto al collegio spetta il potere di disporre l’audizione del fallendo, in tal modo determinando l’inizio del procedimento. E’ del tutto ovvio, peraltro, che l’eventuale iniziativa adottata da singoli magistrati, e non già dal giudice (id est, dal collegio), non pone questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 legge fall., bensì questioni di legittimità del procedimento devolute al giudice di merito. 4.4.- A maggior ragione si sottrae alla censura d’incostituzionalità l’ipotesi (esplicitamente disciplinata dall’art. 8 legge fall.) in cui un giudice civile – diverso dal tribunale competente per la dichiarazione di fallimento – riferisca a quest’ultimo dell’insolvenza emersa nel corso di un giudizio civile davanti a lui pendente e del quale sia parte l’imprenditore insolvente. Non è revocabile in dubbio, infatti, che in questa ipotesi si è in presenza di una notitia decoctionis non soltanto “formalizzata”, ma acquisita ab externo, sicché è escluso in radice che il tribunale, essendo chiamato ad accertare con pienezza di poteri l’esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice – investito come tale di un procedimento giurisdizionale – si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente, la veste di attore. 5.- In conclusione, gli artt. 6 e 8 legge fall., correttamente interpretati, non confliggono con la denunciata norma della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il potere officioso sopra descritto ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell’insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero. per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli articoli 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate, in riferimento entrambe all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente dalla Corte d’appello di Venezia e dal Tribunale di Saluzzo con le ordinanze in epigrafe.