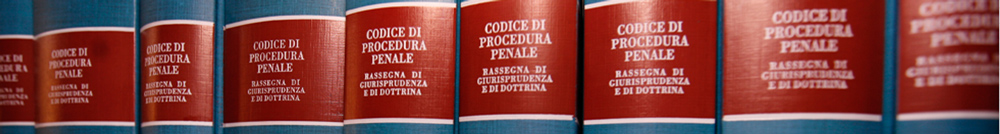Ambiente
Per la nozione di rifiuto investita la Corte Costituzionale
Per la nozione di “rifiuto”
investita la Corte Costituzionale
Cassazione – Sezione terza penale
– ordinanza 14 dicembre 2005-16 gennaio 2006, n. 1414
Presidente De Maio – Relatore
Onorato
Pm Passacantando – ricorrente
Rubino ed altro
Motivi della decisione
– Va anzitutto precisato che la
fattispecie de qua non è sussumibile nella disciplina di cui al D.Lgs 508/1992 (che ha attuato la direttiva 90/667/Cee in
materia di norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione
sul mercato di rifiuti di origine animale) e al regolamento Ce 1774/2002
(recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano), che ha espressamente abrogato la predetta
direttiva Cee 90/667.
Infatti
la condotta contestata agli imputati consisteva nel trasporto e nello
smaltimento del siero di latte derivante dal processo produttivo di un
caseificio, mentre entrambe le normative succitate prevedono norme di polizia
sanitaria e veterinaria per il trasporto, la trasformazione, l’uso o
l’eliminazione di rifiuti (articolo 1 D.Lgs 508/1992). È chiaro che il latte
cessa di essere un sottoprodotto di origine animale
quando viene impiegato come materia prima nella produzione casearia, e che il
siero di latte che residua da questa produzione va qualificato come rifiuto
speciale ex articolo 7 del D.Lgs 22/1997 senza che possa (più) definirsi di
origine animale.
Manca quindi qualsiasi
presupposto ex articolo 8 D.Lgs 22/1997 per escludere
dal regime generale dei rifiuti il siero di latte derivante dalla produzione
casearia, non soltanto perché la polizia sanitaria e veterinaria, oggetto del
D.Lgs 2219/92 e del regolamento Ce 1774/2002, è eterogenea, e non speciale,
rispetto alla disciplina ambientale della gestione di rifiuti (come ritiene Cassazione,
sezione terza, 8520/2002, Leuci), quanto piuttosto perché l’oggetto della
disciplina (il citato siero di latte) non rientra in nessuna delle categorie
che il predetto articolo 8 esclude dalla disciplina generale dei rifiuti (e in
particolare non rientra nella categoria delle carogne o dei rifiuti di origine
animale).
Va pertanto disatteso il primo
motivo di ricorso (n. 2.1).
[Omissis]
5.1 – In ordine
alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata ha colto
nel segno laddove ha ritenuto che il siero di latte residuato dal processo
produttivo del caseificio di Umberto Rubino rientrava nella categoria dei
rifiuti speciali, di cui all’articolo 6 e 7 D.Lgs 22/1997, e che la cessione e
il trasporto del siero, senza alcuna autorizzazione dal predetto caseificio
all’azienda zootecnica di Vito Rubino, integrava il reato di cui all’articolo
51 dello stesso decreto legislativo (in senso conforme, Cassazione, Sezione
terza, 33295/2004, Cioffi, rv. 229011).
La sentenza è incorsa invece in
errore giuridico laddove ha ritenuto che la norma interpretativa di cui all’articolo 14 del Dl 138/2002, convertito in legge
178/2002, in quanto restringe indebitamente la nozione comunitaria di rifiuto,
debba essere direttamente disapplicata (rectius: non applicata) dal giudice
nazionale.
5.2 – Che la norma dell’articolo
14, pur autoqualificandosi come interpretativa, modifichi in senso restrittivo
la nozione di rifiuto precisata dall’articolo 6 D.Lgs
22/1997, e quindi sia incompatibile con la nozione di rifiuto stabilita dalla
direttiva comunitaria 75/442/Cee, modificata dalla direttiva 91/156/Cee, di cui
la disposizione nazionale è sostanzialmente la riproduzione, è indubbio, ed è
riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza pressoché unanimi.
Invero, per l’articolo 6 D.Lgs 22/1997 e per l’articolo 6 e 7 della direttiva
75/442/Cee costituisce rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto che rientri in una
delle sedici categorie elencate in allegato di cui il detentore “si disfi” o
abbia deciso o abbia l’obbligo di “disfarsi”. L’elenco delle categorie, di cui
all’allegato A, è un elenco “aperto”, perché la prima categoria (Q1) comprende
tutti i residui di produzione o di consumo in appresso
non specificati, e la sedicesima (Q16) qualunque sostanza, materia o prodotto
che non rientro nelle altre categorie.
L’articolo 14 legge 178/2002,
invece, nel suo primo comma, identifica il concetto di “disfarsi”
con quello di smaltimento o di recupero, stabilendo che le parole “si disfi”
devono essere interpretate come qualsiasi comportamento attraverso il quale in
modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o
sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo cui gli allegati B
e C del D.Lgs 22/1997.
Attraverso questa
identificazione, però, la norma sedicente interpretativa restringe la
nozione comunitaria di rifiuto, escludendone ogni sostanza o materiale di cui
il detentore “si disfi” mediante semplice “abbandono”, posto che nella
direttiva comunitaria e nel D.Lgs 22/1997 l’abbandono è nettamente distinto
dallo smaltimento e a maggior ragione dal recupero (per il diritto nazionale,
v. articolo 14 D.Lgs 22/1997, su cui Cassazione, sezione terza, 21024/2004,
Eoli, rv. 229225-6; per il diritto comunitario v. articolo 4,
comma 2, direttiva 75/442/Cee, su cui Corte di giustizia, sezione
seconda, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, paragrafo 38, 39 e 40).
In sostanza, secondo il diritto
comunitario e il legislatore nazionale del 1997, ci si può disfare
di un rifiuto, con l’obb1igo di sottostare alla relativa disciplina non solo
avviandolo allo smaltimento o al recupero ma anche semplicemente
abbandonandolo; secondo il legislatore nazionale del 2002, invece, chi
abbandona una sostanza rientrante nelle anzidette categorie di rifiuti è esente
dalla disciplina imposta in materia per assicurare la tutela della salute
pubblica e della qualità ambientale.
Ma dove la norma dell’articolo 14
assume una portata ancora più socialmente innovativa è nel secondo comma, in
forza del quale non ricorrono le fattispecie della decisione di “disfarsi” e dell’obbligo di “disfarsi” ove si tratti di
sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo che “possono essere e
sono effettivamente e oggettivamente utilizzati nel medesimo o in analogo ciclo
produttivo o di consumo”: a) “senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente”; ovvero b) “dopo aver
subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione
di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del D.Lgs 22”.
Invero, secondo la definizione
comunitaria di rifiuto, letteralmente trasfusa nell’articolo 6 D.Lgs 22/1997, un residuo di produzione o di consumo di cui
il detentore abbia deciso o abbia l‘obbligo di “disfarsi” costituisce sempre
rifiuto. Per l’articolo 14, invece, questo residuo perde la qualità di rifiuto
se è o può essere oggettivamente utilizzato tal quale nel medesim0 o in analogo
ciclo di produzione o di consumo, o più esattamente se è riutilizzato senza
trattamento preventivo e senza pregiudizio per l’ambiente ovvero con
trattamenti preventivi che non comportano operazioni di recupero (per esempio
attraverso atti di prelievo, cernita, separazione, compattamento, frantumazione
merceologica o chimica dei materiali).
È quindi innegabile che anche
sotto questo profilo 1’articolo 14 restringe la nozione comunitaria di rifiuto,
giacché per il diritto comunitario la volontà o l’obbligo di “disfarsi” di un residuo di produzione o di consumo
costituisce quest’ultimo come rifiuto, mentre per la norma nazionale sedicente
interpretativa quel residuo diventa semplice materia prima ove ricorra la
condizione della sua attuale o potenziale riutilizzazione.
Concludendo,
l’articolo 14 ha introdotto una doppia deroga alla definizione comunitaria di
rifiuto, sia laddove ha identificato l’attività di “disfarsi” della sostanza
con quella di smaltimento o di recupero della medesima (escludendo così
l’attività di abbandono), sia laddove ha escluso la volontà o l’obbligo di
“disfarsi” di residui di produzione o di consumo quando questi sono o possono
essere riutilizzati tal quali senza trattamenti recuperatori e senza
pregiudizio per l’ambiente. In tal modo ha esonerato dal controllo
amministrativo e dalla disciplina sui rifiuti attività con cui il detentore si disfa di residui di produzione o di consumo creando pericolo
per l’ambiente.
Con ciò il legislatore italiano è
venuto meno ai suoi obblighi di leale cooperazione di cui all’articolo 10 (ex
5) del Trattato CE, pregiudicando gli obiettivi comunitari di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente e di protezione della salute umana di cui all’articolo 174 (ex
130 R) dello stesso Trattato.
6.1 – Tale è del resto la
convinzione della Commissione della Comunità europea la quale ha avviato contro
lo Stato italiano una procedura di infrazione ai sensi
dell’articolo 226 (ex 169) del Trattato in seguito all’approvazione
dell’articolo 14 del Dl 138/2002.
Ma tale è, soprattutto, la
decisione della Corte di Giustizia europea, che investita in via pregiudiziale
dal Tribunale di Terni della questione della compatibilità comunitaria
dell’articolo 14, con la sentenza della Sezione II dell’ 11
novembre 2004, causa C-457/2002, Niselli, sviluppando il filone
giurisprudenziale consacrato nelle precedenti sentenze Zanetti del 10 maggio
1995, C-422/1992, Tombesi del 25 giugno 1997, C-304/1994, e Palin Granit Oy
del 18 aprile 2002, C-9/00, ha cosi statuito:
a) la nozione di rifiuto dipende
dal significato del verbo “disfarsi”, il quale “deve
essere interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442, che, ai
sensi del suo terzo «considerando» è la tutela della salute umana e
dell’ambiente […]) ma anche alla luce dell’articolo 174 n. 2 CE, secondo il
quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato
livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e
dell’azione preventiva” (paragrafo 33).
Una sostanza o un materiale non
soggetto a obbligo di smaltimento o di recupero e di
cui il detentore “si disfi” mediante semplice abbandono è considerato rifiuto
ai sensi della direttiva 75/442 (paragrafo 38). E
poiché l’abbandono non può essere considerato una modalità di smaltimento del
rifiuto, ma è ben distinto dallo smaltimento (paragrafo 39), la definizione
comunitaria di rifiuto non può essere interpretata nel senso di ricomprendere
soltanto le sostanze e i materiali destinati o soggetti alle operazioni di
smaltimento o di (paragrafo 40).
b) per l’articolo 14 del Dl
138/2002 “affinché un residuo di produzione o di consumo sia sottratto alla
qualifica di rifiuto sarebbe sufficiente che esso sia o possa essere
riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di
trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di
recupero ai sensi dell’allegato II B della direttiva 75/442” (paragrafo 50). Ma “un’interpretazione del genere si risolve manifestamente
nel sottrarre alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo
che invece corrispondono alla definizione sancita dall’articolo 1, lettera a),
comma 1, della direttiva 75/442” (paragrafo 51). Pertanto, la nozione
comunitaria di rifiuto non può essere interpretata nel senso di escludere
l’insieme dei residui di produzione o di consumo che
possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo senza
trattamento preventivo o con trattamento non recuperatorio (paragrafo 53).
Tuttavia – secondo la sentenza
Niselli, che riprende sul punto la precedente sentenza Palin Granit Oy del 18
aprile 2002 – può esulare dalla nozione comunitaria di rifiuto un materiale
derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione
che non è principalmente destinato a produrlo, che il produttore riutilizza,
senza trasformazione preliminare, nel corso dello stesso processo produttivo:
in tal caso non si tratta di un residuo, bensì di un “sottoprodotto”, che non
ha la qualifica di rifiuto proprio perché il produttore non intende
“disfarsene”, ma vuole invece riutilizzarlo nel medesimo ciclo produttivo
(paragrafi 44-52).
Per distinguere il
“sottoprodotto” dal rifiuto è comunque necessario che
il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza
trasformazioni preliminari, cioè senza modificazioni del carattere chimico o
merceologico della sostanza (paragrafo 47).
Che il ciclo produttivo debba essere il medesimo risulta chiaramente dal paragrafo
52 della sentenza. Del resto, se il riutilizzo avvenisse in un diverso ciclo produttivo vorrebbe dire che il produttore ha inteso
“disfarsi” del residuo per commercializzarlo o comunque cederlo ai terzi per la
riutilizzazione.
6.2 – La sentenza Niselli è stata
emessa ai sensi dell’articolo 234 (ex 177) del Trattato Ce e quindi si è
limitata a interpretare la norma del diritto
comunitario che definisce la nozione di rifiuto; mentre solo procedendo ex
articolo 226 (ex 169), in esito alla procedura di infrazione attivata dalla
Commissione, avrebbe potuto direttamente interpretare la norma nazionale
denunciata come lesiva degli obblighi comunitari.
I diversi poteri della Corte di
giustizia nell’ambito delle diverse procedure sono chiaramente enunciati dalla
stessa Corte, che ha avuto modo di chiarire il principio secondo cui essa “non
può, ai sensi dell’articolo 177 (ora 234) del Trattato, statuire sulla validità
di una norma di diritto interno con riguardo al diritto comunitario, come le
sarebbe consentito fare nell’ambito di un ricorso ex articolo 169 (ora 226) del
Trattato Ce”; peraltro “essa è tuttavia competente a fornire al giudice
nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che
rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi su tale
compatibilità” (sentenza Tombesi citata del 25 giugno 1997, paragrafo 36).
7.1. Resta ora da esaminare quale
innegabile vulnus che l’articolo 14 del Dl 138/2002 ha recato al diritto
comunitario.
Al riguardo, la sentenza
impugnata e alcune pronunce di questa corte hanno sostenuto la necessità della
disapplicazione (rectius: non applicazione) della norma nazionale in forza
della prevalenza e immediata, applicabilità del diritto comunitario (Sezione
terza, 2125/03, Ferretti, rv. 223291; Sezione terza,
14762/02, Amadori, rv. 221573; Sezione terza, 17656/03, Gonzales e
altro, rv. 224716).
Un altro orientamento, che appare
prevalente, sostiene invece che l’articolo 14 è vincolante per il giudice italiano giacché la direttiva comunitaria sui rifiuti non è
autoapplicativa (self-executing) in quanto necessita di atto di recepimento da
parte dello Stato nazionale (Sezione terza, 4052/03, Passerotti, rv. 223532;
Sezione terza, 4051/03, Ronco, rv. 223604; Sezione
terza, 9057/03, Costa, rv. 224172; Sezione terza,
13114/03, Mortellaro, rv. 224721; Sezione terza, 32235/03,
Agogliati e altri, rv. 226156; Sezione terza, 38567/03, De Fronzo, rv.
226574).
7.2 – Le succitate sentenze
Ferretti e Amadori, stilate peraltro dallo stesso relatore, riconoscono che la
direttiva 75/442/Cee, come modificata dalla direttiva 91/156/Cee,
non ha efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, ma sostengono ugualmente
la diretta applicabilità della nozione comunitaria di rifiuto, in base al fatto
che essa è stata richiamata dal regolamento comunitario 259/93, che ha
indubbiamente carattere self-exsecuting.
Ma tale
singolare argomento, benché condiviso da qualche autore, non può accettarsi.
Invero, il regolamento Cee
259/93, “relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all’interno della Ce, nonché in entrata e in uscita
dal suo territorio”, all’articolo 2, lettera a), stabilisce che “ai sensi del
presente regolamento” si intendono per rifiuti “i rifiuti quali definiti
nell’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee.
Orbene, è sufficiente osservare
come la norma del regolamento, che come tale è direttamente applicabile
nell’ordinamento italiano, recepisca la nozione di
rifiuto definita dalla direttiva 75/442/Cee soltanto ai fini della specifica
materia disciplinata dal regolamento, ovverosia limitatamente alle spedizioni
di rifiuti che a scopo di sorveglianza devo essere previamente notificate e
munite di un documento di accompagnamento.
Questa nozione “regolamentare”
quindi non è direttamente applicabile né per l’attività di abbandono
né per tutte le attività di gestione dei rifiuti elencate nell’articolo 6,
lettera g), D.Lgs 22/1997, che sono ben diverse dall’attività di spedizione: e
cioè raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.
Anche una risalente sentenza
della Corte di Giustizia ha avuto modo di stabilire che la nozione
“regolamentate” di rifiuti, “che è stata istituita al fine dì garantire che i
sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti
rispettino criteri minimi, si applica direttamente anche alle spedizioni di
rifiuti all’interno di qualsiasi Stato membro”; ma non ha affatto esteso la
diretta applicabilità della nozione alle altre tradizionali attività di
gestione o all’attività di abbandono, comunque diverse
dalla spedizione (Corte di Giustizia, sezione sesta, 25 giugno 1997, Tombesi e
altri, v. massima e paragrafi 44. 45 e
46).
Non si può quindi parlare a tale
riguardo di una novazione della fonte del diritto
comunitario (da direttiva a regolamento) in senso generale e illimitato.
Inoltre, come è
stato opportunamente sottolineato in dottrina, l’argomento da una parte non è
stato mai considerato dalla stessa Corte lussemburghese, che, chiamata più
volte a interpretare in via pregiudiziale la nozione comunitaria di rifiuto, ha
sempre focalizzato il suo esame solo sulla direttiva 75/442, come modificata
dalla direttiva 91/156; dall’altra non è stato utilizzato neppure dalla
Commissione Ue nella menzionata procedura di infrazione aperta contro lo Stato
italiano, quanto meno per informare il nostro
Governo che il tentativo di restringere la nozione di rifiuto era del tutto
velleitario, attesa la immediata applicabilità nell’ordinamento nazionale del
regolamento 259/93/Cee.
In conclusione, si tratta di argomento che appare ormai abbandonato sia dalla dottrina
che dalla giurisprudenza, le quali non mettono più in discussione
l’inapplicabilità diretta della nozione comunitaria di rifiuto (al di fuori
della materia delle spedizioni disciplinata dal menzionato regolamento).
7.3 – L’orientamento
giurisprudenziale minoritario, pur dando per scontato il carattere non
autoapplicativo della direttiva 75/444/Ce, modificata dalla direttiva 91/156/Ce, giunge ugualmente a non applicare l’articolo 14 del D
138/02, in base all’argomento che, in ossequio al principio della prevalenza
del diritto comunitario, sia originario, sia derivato, il giudice nazionale
deve comunque dare applicazione alle sentenze della Corte di Giustizia europea,
che a più riprese hanno offerto una interpretazione della nozione comunitaria
di rifiuto contrastante con quella risultante dall’articolo 14: in particolare
devono dare attuazione alla citata sentenza Niselli, che espressamente ha
statuito la incompatibilità comunitaria di quest’ultima norma.
Ma anche questo
argomento, apparentemente convincente, non è accoglibile.
A rigore, la pronuncia della
Corte di Giustizia che precisa o integra il significato di una norma
comunitaria ha la stessa efficacia di quest’ultima, sicché la pronuncia è
direttamente ed immediatamente efficace nell’ordinamento nazionale se e in
quanto lo sia anche la norma interpretata.
In tal senso è l’insegnamento
costante della Corte costituzionale. Basti ricordare la sentenza 389/1989 in
cui la Consulta, trattando del principio di applicazione
diretta di norme comunitarie immediatamente efficaci nel diritto interno, ha
avuto modo di precisare che “quando questo principio viene riferito ad una
norma comunitaria avente «effetti diretti» […] non v ‘è dubbio che la
precisazione o l’integrazione del significato normativo compiute attraverso una
sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia abbiano la stessa immediata
efficacia delle disposizioni interpretate”.
Invero, nei casi in cui la Corte
lussemburghese ha interpretato il significato di una norma comunitaria
direttamente efficace in modo tale che una norma del diritto nazionale risulti incompatibile con essa, il giudice nazionale non
deve più applicare la norma interna per la definizione dalla controversia al
suo esame (senza poter sollevare questione di costituzionalità v. Corte
costituzionale, 94/1995).
Nei casi invece in cui La Corte
lussemburghese ha interpretato una norma comunitaria priva di
efficacia diretta in modo tale che una norma interna risulti
incompatibile con la prima, il giudice italiano non ha altra scelta che
applicare la norma interna o sollevare sulla stessa l’eccezione di
illegittimità costituzionale per violazione degli obblighi dello Stato italiano
di conformarsi al diritto comunitario, consacrati negli articoli 11 e 117
Costituzione (è implicitamente in tal senso anche la recente sentenza n.
85/2002 Corte Costituzionale).
7.4 – Più di recente, un’altra
pronuncia di legittimità, seguendo il principio indicato dalla Corte
costituzionale con sentenza 190/2000, ha correttamente sostenuto la necessità
per il giudice italiano di interpretare la normativa nazionale in termini tali
che essa non risulti in contrasto con la normativa
comunitaria (Cassazione, sezione terza, 746/05, Colli).
A questa stregua, ha ritenuto,
sulla scia della citata sentenza Niselli, che l’articolo 14 in questione non
contrasta con la nozione comunitaria di rifiuto solo laddove esclude
dall’ambito della relativa disciplina i c.d. sottoprodotti, cioè
quei residui di produzione (esclusi i residui di consumo) dei quali il
produttore non abbia intenzione di disfarsi e che siano riutilizzati in modo
certo, senza previa trasformazione, nell’ambito dello stesso processo
produttivo. I “sottoprodotti”, infatti, in quanto riutilizzati nello stesso ciclo
produttivo come materie prime, non presentano rischi per 1’ambiente sicché per essi non ha ragion d’essere applicare la disciplina dei
rifiuti.
La fattispecie dedotta nel
presente processo, però, esula da ogni possibile interpretazione adeguatrice,
giacché il siero di latte
residuato dalla produzione casearia veniva trasportato e ceduto a
un’altra azienda, esercente attività zootecnica, che lo destinava ad alimento
per gli animali. Alla luce del diritto comunitario come autoritativamente
interpretato dalla Corte di Giustizia europea, non poteva quindi classificarsi
come “sottoprodotto”, ma era invece un vero e proprio rifiuto di cui il
produttore si disfaceva perché fosse riutilizzato tal
quale in altro processo produttivo.
Per la norma nazionale di cui si
discute, invece, il siero di latte prodotto nel caseificio e riutilizzato in
diversa azienda zootecnica resta indiscutibilmente escluso dalla nozione di
rifiuto, e non vi può rientrare in forza di una interpretazione
adeguatrice. Esso resta perciò sottratto alla disciplina sui rifiuti, in palese
contrasto col diritto comunitario.
8 – L’unico rimedio possibile per
rimediare al vulnus perpetrato da una legge nazionale contro una direttiva
comunitaria non direttamente applicabile è, quindi, il ricorso al giudice delle
leggi.
Invero,
la norma in questione, escludendo dalla categoria dei rifiuti di produzione o
di consumo che siano semplicemente abbandonati dal produttore o dal detentore,
ovvero che siano riutilizzati in qualsiasi ciclo produttivo o di consumo senza
trattamento recuperatorio, si pone in insanabile contrasto con la nozione di
rifiuti stabilita dalla direttiva comunitaria 75/442/Ce, modificata dalla
direttiva 91/156/Ce e dalla decisione della Commissione 96/350/Ce.
Nel caso di specie, quindi, va sollevata
d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14 Dl 138/2002,
convertito in legge 178/2002, perché in contrasto:
a) con l’articolo 11
Costituzione, laddove questo stabilisce che lo Stato italiano deve osservare la
limitazione di sovranità derivante dalla sua partecipazione a
ordinamenti internazionali, quale quello della Comunità europea;
b) nonché,
ancor più esplicitamente, con il novellato articolo 117 Costituzione, che nel
suo primo comma impone allo Stato di esercitare la sua potestà legislativa nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
L’ipotizzato vulnus comunitario e
costituzionale appare tanto più grave in quanto, dopo che la Commissione di
Bruxelles aveva aperto la menzionata procedura di infrazione,
e poco dopo che la Corte di Giustizia europea aveva emanato la citata sentenza
Niselli, il legislatore nazionale, con la legge 308/2004 (delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione), ha ribadito la sua volontà
normativa al riguardo, stabilendo al comma 26 dell’articolo 1: “Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 14 del Dl 138/2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge 178/2002…”.
La non manifesta infondatezza
della questione risulta dalle considerazioni svolte in
precedenza, secondo le quali la norma denunciata è incompatibile (nei limiti
anzidetti) con il diritto comunitario e per conseguenza lede gli obblighi
costituzionali di adeguamento all’ordinamento comunitario stesso.
9.1 – Dalle considerazioni
precedenti risulta altresì evidente la rilevanza della
questione, atteso che il processo non può essere definito prescindendo
dall’applicabilità del denunciato articolo 14 e quindi dalla risoluzione della
relativa eccezione di illegittimità costituzionale.
Se la
norma resistesse al vaglio di costituzionalità, infatti, la sentenza impugnata
dovrebbe essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato, avendo l’articolo 14 sottratto alla disciplina dei rifiuti il
siero di latte riutilizzato senza trattamenti preventivi in altro ciclo
produttivo. Se invece la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima
e quindi inapplicabile al caso di specie, al giudice a quo si aprirebbe la
duplice possibilità di rigettare il ricorso, con la conferma della condanna
degli imputati, o di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per difetto
dell’elemento soggettivo della contravvenzione contestata, avendo gli imputati fatto
affidamento incolpevole sulla portata normativa di una disposizione (l’articolo
14) successivamente caducata dall’ordinamento. Nella
prima, ma – sia pure in misura minore – anche nella seconda ipotesi, la
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale
avrebbe un effetto in malam partem.
Emerge qui il noto problema del
sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore, cioè
delle norme che, per determinati soggetti o ipotesi, abrogano o modificano in
senso favorevole al reo precedenti disposizioni incriminatrici.
Tale appare indubbiamente la
norma dell’articolo 14, giacché essa si configura come disposizione extrapenale
integratrice della fattispecie penale di cui agli articoli 6 e 51 D.Lgs 22/1997, che, “restringendo” l’ampiezza dell’oggetto
materiale del reato (i rifiuti), finisce per derogare o abrogare parzialmente,
ovvero modificare in senso favorevole al reo, la precedente norma
incriminatrice.
9.2 – Com’è noto, muovendo dalla
considerazione che l’eventuale accoglimento dell’eccezione di
illegittimità costituzionale della norma penale più favorevole non
potrebbe influire sull’esito del giudizio a quo per il principio di
irretroattività di cui all’articolo 25, comma 2, Costituzione e all’articolo 2,
comma 1, Cp, si è tratta in passato la conclusione che le eccezioni di
incostituzionalità delle norme penali di favore sono “tipicamente” irrilevanti,
con la conseguenza che dette norme restano sottratte al controllo
costituzionale.
Peraltro, occorre al riguardo
precisare che nel caso di specie il fatto contestato è stato commesso sino al
14 novembre 2000, cioè sotto il vigore della norma
incriminatrice di cui agli articoli 6 e 51 D.Lgs 22/1997, sicuramente conformi
al diritto comunitario, e prima dell’entrata in vigore dell’articolo 14 Dl 138/2002,
che, escludendo alcune categorie di rifiuti, ha ridotto l’area del penalmente
illecito, in contrasto col diritto comunitario.
Orbene, è doveroso osservare che
in un caso siffatto, se la Corte dichiarasse costituzionalmente illegittima la
norma più favorevole di cui all’articolo 14, la
conferma della responsabilità degli imputati in base alla norma più sfavorevole
di cui ai suddetti articoli 6 e 51:
a) non violerebbe il principio di irretroattività di cui al secondo comma dell’articolo 25
Costituzione, posto che la norma dell’articolo 51 era entrata in vigore prima
del fatto contestato; b) non violerebbe neppure il principio di retroattività
dell’abolitio criminis di cui al secondo comma dell’articolo 2 Cp, giacché la
norma dell’articolo 14, entrata in vigore dopo il fatto, con l’effetto di
depenalizzarlo attraverso l’abrogazione parziale dell’articolo 6 D.Lgs 22/1997,
non potrebbe essere applicata proprio in quanto resa inefficace dalla pronuncia
di illegittimità costituzionale; in altri termini, la retroattività della norma
parzialmente depenalizzatrice non potrebbe operare per la caducazione della
norma stessa dall’ordinamento.
Questa conclusione è
indubbiamente in linea con la nota sentenza 51/1985 della Consulta, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’articolo 2 Cp,
nella parte in cui prevedeva la retroattività ai fatti pregressi della norma penale
favorevole contenuta in un decreto legge non convertito, per contrasto con
l’articolo 77, ultimo comma, Costituzione (secondo cui i decreti legge non
convertiti perdono efficacia sin dall’inizio). Esaminando il problema se il
principio di irretroattività della norma penale
sfavorevole fosse d’ostacolo al risultato normativo derivante dalla pronuncia
di illegittimità costituzionale, la Corte ha precisato che detto principio
sarebbe applicabile soltanto ai fatti “concomitanti”, commessi cioè sotto il vigore
del decreto legge non convertito, ma non per i fatti “pregressi”, commessi cioè
prima che il decreto legge entrasse in vigore.
Anche
nel presente processo, il fatto è “pregresso” e non già “concomitante” rispetto
al periodo di vigenza della norma penale di favore.
9.3 – Comunque,
il problema è ora risolto dalla sentenza 148/1983, che ha argomentato la
rilevanza e l’ammissibilità delle questioni di costituzionalità delle norme
penali di favore in base al duplice argomento secondo cui l’accoglimento della questione:
a) verrebbe comunque a incidere sulle formule di proscioglimento o sui
dispositivi della sentenza penale e si rifletterebbe sullo schema argomentativo
della relativa motivazione; b) avrebbe comunque un “effetto di sistema” la cui
valutazione spetta ai giudici comuni e non al giudice costituzionale. E ciò perché, senza vanificare la garanzia dell’articolo 25
Costituzione, anche le norme penali di favore devono sottostare al sindacato di
costituzionalità, “a pena di istituire zone franche del tutto impreviste dalla
Costituzione, all’interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe
incontrollabile”.
Questo approdo ermeneutico non è
scalfito dalle numerose statuizioni della Consulta che hanno
ribadito l’inammissibilità delle sentenze additive contra reum per rispetto
dell’articolo 25, comma 2, Costituzione, stante la strutturale diversità delle
due ipotesi.
Infatti, quando è dedotta la
questione di costituzionalità di una norma penale di favore, la sentenza di accoglimento ha carattere ablativo della deroga oggettiva
o soggettiva introdotta, con l’effetto di ripristinare la piena portata
normativa di una norma incriminatrice preesistente. Al contrario, la sentenza
additiva di accoglimento (che dichiara
incostituzionale la norma sospettata “nella parte in cui non prevede” ecc.) ha
l’effetto di creare ex novo una norma incriminatrice o di ampliare la portata
di una fattispecie penale preesistente, usurpando in entrambi i casi una
prerogativa spettante alla discrezionalità del legislatore.
(Diverso
sembra il caso della sentenza 440/1995, in cui, con un meccanismo di tipo
ablatorio, il giudice delle leggi, in forza del principio di uguaglianza, ha
esteso il reato di bestemmia della divinità anche a tutela delle religioni non
cattoliche, creando così una nuova figura di reato, che però non era
applicabile al fatto contestato nel processo a quo).
Per diversa ragione l’approdo
della sentenza 148/1983 non appare intaccato neppure dalla recente sentenza
161/2003 Corte Costituzionale, la quale ha escluso la possibilità di estendere
l’ambito di applicazione della norma incriminatrice di
cui all’articolo 2621 Cc (false comunicazioni sociali), come sostituito
dall’articolo 1 D.Lgs 61/2002, attraverso la rimozione delle soglie minime di
punibilità ivi previste. Qui infatti la Corte ha
escluso la possibilità di ampliare o aggravare la figura di reato già esistente
attraverso la demolizione delle soglie di punibilità, sul rilievo che queste
integrano i requisiti essenziali di tipicità del fatto ovvero condizioni di punibilità,
e cioè sono comunque “un elemento che ‘delimita’ l’area di intervento della
sanzione prevista dalla norma incriminatrice, e non già ‘sottrae’ determinati
fatti all’ambito di applicazione di altra norma, più generale”.
Tale essendo la
ratio decidenti, essa non può essere applicata ai casi – come quello
presente – in cui la norma denunciata per incostituzionalità è norma penale di
favore, la quale “sottrae” determinate ipotesi (nel caso specifico, la gestione
dei residui di produzione utilizzati in altri cicli produttivi) a una norma
incriminatrice generale (gli articoli 6 e 51 D.Lgs). In altri termini, facendo
cadere per incostituzionalità l’articolo 14 si ripristinerebbe la portata
originaria di una norma incriminatrice già presente nell’ordinamento, che
l’articolo 14 aveva parzialmente derogato; facendo cadere le soglie di
punibilità previste dall’articolo 2621 Cc, invece, si amplierebbe la portata
penale della stessa norma al di là dei limiti in cui
il legislatore l’aveva configurata.
9.4 – Analogo problema si è
presentato alla Corte di Giustizia europea, chiamata a
interpretare la nozione comunitaria di rifiuto dal giudice del processo
Niselli, posto che la sua ricostruzione ermeneutica poteva avere effetti tali
da entrare in rotta di collisione con il principio di legalità e
irretroattività dei reati e delle pene, che è ritenuto parte integrante anche
del diritto comunitario.
Al riguardo la
sentenza Niselli, premesso che “una direttiva non può avere l’effetto, di per
sé e indipendentemente da una norma giuridica di uno Stato membro adottata per
la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di
coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni”, preso atto che il
fatto contestato all’imputato era stato commesso sotto il vigore delle
disposizioni incriminatrici di cui al D.Lgs 22/1997, e prima dell’entrata in
vigore dell’articolo 14 Dl 138/2002, ha concluso che non vi era “motivo di
esaminare le conseguenze che potrebbero discendere dal principio di legalità
delle pene per l’applicazione della direttiva 75/442” (paragrafi 29 e 30).
Non occorre qui sottolineare l’analogia fattuale tra il caso Niselli e il
caso presente riguardo al rapporto tra tempus commissi delicti e successione di
leggi penali nel tempo.
Diverso è il caso affrontato più
di recente dalla stessa Corte europea, Grande Sezione, chiamata a risolvere in
via pregiudiziale la questione se il trattamento sanzionatorio più favorevole
previsto dai novellati articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false
comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) Cc fosse
o meno adeguato in relazione all’articolo 6 della prima direttiva comunitaria
sul diritto societario (sentenza 3 maggio 2005, Cause riunite C-387/2002,
C-391/2002 e C-403/2002, Berlusconi ed altri).
La sentenza ha osservato che il
principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite fa parte integrante
delle tradizioni costituzionali degli Stati membri e dei principi generali del
diritto comunitario (paragrafi 68 e 69); e ha concluso
che “la prima direttiva sul diritto societario non può essere invocata in
quanto tale dalle autorità di uno Stato membro, nei confronti di imputati
nell’ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come
effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro
adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità
penale degli imputati” (paragrafo 78 e dispositivo).
Basti rilevare in proposito che,
nel caso esaminato dalla Corte europea, né gli originari articoli 2621 e 2622
Cc, che prevedevano un trattamento sanzionatorio più severo, e sotto la vigenza
dei quali erano stati commessi i reati contestati, né
i nuovi 2621 e 2622 Cc, che hanno introdotto un trattamento più mite,
costituiscono attuazione di direttive comunitarie; sicché si comprende
l’affermazione secondo cui una direttiva comunitaria, per se stessa e senza la
mediazione di leggi nazionali di attuazione, non possa determinare o aggravare
una responsabilità penale nella soggetta materia. Mentre nel caso della
disciplina sui rifiuti, la direttiva comunitaria è stata trasposta
nell’ordinamento nazionale attraverso il D.Lgs
22/1997, che ha previsto in aggiunta un sistema sanzionatorio a presidio della
disciplina stessa, sicché né la previsione della responsabilità penale, né la
sua limitazione derivano direttamente dalla direttiva comunitaria, essendo,
invece, state introdotte, la prima dall’articolo 51 del D.Lgs 22/1997, e la
seconda dall’articolo 14 del Dl 138/2002. Nella presente vicenda processuale,
quindi, non può farsi ricorso al principio statuito nella suddetta sentenza
comunitaria del 3 maggio 2005, proprio perché presupposto di questo principio è
la mancanza di norme nazionali attuative della direttiva comunitaria.
9.5 – Per tutte queste ragioni
non sembra dubitabile la rilevanza della dedotta questione.
A conforto di questa tesi,
peraltro, militano le numerose sentenza di questa
Corte, che, proprio in materia di rifiuti, hanno dichiarato l’illegittimità
costituzionale di varie leggi regionali che avevano depenalizzato lo stoccaggio
provvisorio non espressamente autorizzato di rifiuti tossici e nocivi
(306/1992; 437/1992; 194/1993) o l’accumulo temporaneo di rifiuti tossici e
nocivi (sentenza 213/1991), o che avevano escluso dagli impianti di smaltimento
di rifiuti gli impianti di depurazione per conto terzi di rifiuti liquidi, così
esonerando la loro gestione dall’obbligo di autorizzazione (sentenza 173/1998).
Qui la caducazione delle norme
legislative regionali per contrasto con le fonti normative gerarchicamente
superiori, costituzionali e comunitarie, è
perfettamente sovrapponibile alla richiesta caducazione dell’articolo 14 Dl
138/2002; ed ha gli stessi effetti sul trattamento penale degli imputati
nell’ambito dei processi principali.
PQM
La Corte di Cassazione, terza
sezione penale, visti gli articoli 134 Costituzione e 23
legge 87/1953, solleva d’ufficio questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 14 Dl 138/2002, convertito in legge 178/2002, per violazione degli
articoli 11 e 117 della Costituzione, dichiarandola rilevante e non
manifestamente infondata;
sospende
il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale;
ordina
che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli
imputati e al loro difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;
dà
altresì mandato alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.