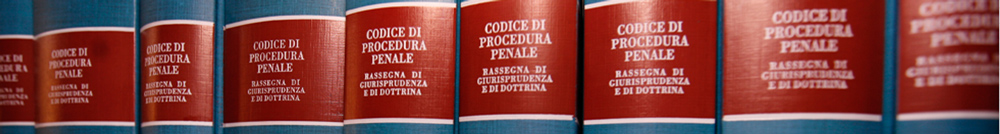Penale
La sentenza di proscioglimento del medico del “caso Welby”
La sentenza di proscioglimento
del medico del “caso Welby”.
Tribunale di Roma, Giudice per
l’Udienza Preliminare, 23 luglio- 17 ottobre 2007, n. 2049
G.u.p. Dr. Secchi
Svolgimento del processo
Previa richiesta di rinvio a
giudizio, formulata dal Pm ai sensi dell’art. 409 c.p.p. nei confronti di
Riccio Mario per i fatti di cui alla suindicata imputazione, veniva
fissata udienza il 6-7-07 per il rinvio a giudizio.
Nel corso di detta udienza, oltre
all’interrogatorio dell’imputato, al cui espletamento si procedeva
contestualmente, il Gup disponeva un’integrazione probatoria; in particolare venivano disposte l’audizione della persona offesa Schett
Wilhelmine e l’acquisizione del libro "Lasciatemi morire’’ di Piergiorgio
Welby, nonché della sua lettera al Presidente della Repubblica. Infine il
Giudice nell’odierna udienza, assunta la suindicata testimonianza, invitava le
parti a formulare le conclusioni, di cui al separato verbale, decidendo come da
dispositivo.
In merito al fatto storico,
oggetto del presente giudizio, risulta dagli atti che perveniva presso la Procura della Repubblica
di Roma la comunicazione, redatta il 21-12-06 dalla
stazione CC di Roma-Cinecittà, riguardante il decesso di Piergiorgio Welby,
avvenuto in data 20-12-06 per «arresto cardiorespiratorio secondario a grave
insufficienza respiratoria in portatore di distrofia scapolo-omerale
progressiva dal 1962».
Il Pm, senza aprire un
procedimento penale a carico di alcuno, disponeva una consulenza medico-legale
e tossicologica per accertare le cause della morte del predetto, nonché
acquisiva per il tramite della Pg le dichiarazioni del medico anestesista
operante, Riccio Mario, e di altra persona presente ai fatti, ovvero l’on.
Marco Cappato; veniva inoltre acquisita documentazione
sanitaria riguardante il decesso in possesso della vedova, Schett Wilhelmine.
Sulla base di tali atti il Pm
formulava richiesta di archiviazione nei confronti del Riccio, seppure a carico
di quest’ultimo non fosse mai stato formalmente iscritto alcun procedimento
penale presso il registro di cui all’art. 335, c.p.p..
Il Gip, previa richiesta al Pm di
iscrivere il Riccio al predetto registro, fissava ai sensi dell’art. 409 c.p.p., udienza camerale, nel corso della quale acquisiva le
spontanee dichiarazioni dell’indagato. La riserva di cui al verbale di udienza
del 28-5-07 veniva sciolta dal Gip con la reiezione
della richiesta di archiviazione del Pm, a cui veniva imposto di formulare
l’imputazione nei confronti del Riccio.
La richiesta di rinvio a giudizio
perveniva, pertanto, a questo Giudice che decideva come sopra meglio
specificato.
Motivi della decisione
I fatti all’origine del presente
procedimento, secondo quanto risulta dagli atti presenti nel fascicolo del Pm e
secondo quanto emergente dalle integrazioni probatorie disposte da questo Gup,
sono da ricostruirsi nel modo che segue.
A Piergiorgio Welby nel 1963,
all’età di 18 anni, veniva diagnosticata una distrofia
fascio-scapolo-omerale, una patologia che secondo la letteratura medica attuale
viene univocamente definita come «malattia degenerativa dei muscoli
scheletrici, progressiva ed ereditaria; lentamente progressiva che interessa,
in particolare, i muscoli della faccia e delle spalle. Le funzioni intellettive
sono normali. L’insufficienza respiratoria è presente nella maggior parte delle
forme distrofiche. Non vi sono terapie specifiche: il medico è costretto ad
assistere impotente alla progressione inesorabile della perdita di forze e
della atrofia» (cit. Adams e Victor, Principi di neurologia, ed, 2002). Tale
patologia viene descritta dai consulenti tecnici del
Pm nella relazione in atti come malattia a «progressione estremamente lenta con
periodi prolungati di stazionarietà anche se sono stati segnalati rari casi ad
evoluzione rapida»; nei confronti di tale malattia nella relazione tecnica,
inoltre, si afferma che «a tutt’oggi non esistono protocolli terapeutici
efficaci per cui la strategia è essenzialmente riabilitativa e
sintomatologica». In conclusione, dalla relazione tecnica si evince che la
distrofia è ad esito infausto e le terapie somministrabili risultano essere di
mero supporto fisico-riabilitativo e di transeunte contenimento dei sintomi,
imponendo tale patologia, per il resto, i tempi della sua progressione e le
modalità di manifestazione, senza possibilità di guarigione o di arresto di
queste ultime, e potendo la scienza medica solo fornire ai
malati terapie finalizzate, nel migliore dei casi, a rallentare
l’evoluzione della predetta patologia e a lenire le sue manifestazioni più
eclatanti.
Di come, poi, le fasi della
malattia e la sua inevitabile progressione si siano
manifestate in concreto nella vita di Piergiorgio Welby non vi può
essere, naturalmente, descrizione più puntuale e più autentica di quella
effettuata da chi ha vissuto tale esperienza sulla propria pelle. Infatti quest’ultimo con grande consapevolezza e lucidità
nel suo libro dal titolo emblematico “Lasciatemi morire”, pubblicato nel 2006,
racconta:
"La mia storia è simile a
tanti altri distrofici. Non è facile ricordare come tutto sia cominciato: forse
fu una caduta immotivata o un bicchiere troppo spesso sfuggito di mano. Ma
quello che non si può dimenticare è il giorno in cui il medico, dopo la biopsia
muscolare e l’elettromiografia, ti comunica la diagnosi: distrofia muscolare
progressiva. È una delle patologie più crudeli perché, mentre lascia intatte le
facoltà intellettive, costringe il malato a confrontarsi con tutti gli handicap
conosciuti, da claudicante a paraplegico, da paraplegico a tetraplegico, poi
arriva l’insufficienza respiratoria e la tracheotomia. Il cuore di solito non viene colpito e quello che i medici chiamano esito infausto
si ha per i decubiti o una polmonite. Per me la diagnosi arriva nel 1963. Il
solito pellegrinaggio alla ricerca di una cura approda alla sentenza di un
luminare: «non supererà i vent’anni». Lascio gli studi e tra il 1969 ed il 1971
giro l’Europa. Non muoio, ma la malattia si aggrava … negli anni ottanta vi è
un ulteriore aggravamento: non posso più camminare. Incontro Mina, nativa
dell’Alto Adige, durante un viaggio parrocchiale ed è colpo di fulmine. Mi
sposo ed aspetto la fine. Non arriva. Ma con l’aggravarsi della malattia
facciamo un patto: se avrò una crisi respiratoria non voglio che chiami
soccorso e mi faccia ricoverare. Non voglio accettare la tracheotomia, un atto
chirurgico cruento che mi renderebbe schiavo di un ventilatore polmonare.
Il 14 luglio 1997 altro
aggravamento: insufficienza respiratoria, l’ultimo stadio della distrofia.
Perdo i sensi, vado in coma. Mi risveglio nella rianimazione del Santo Spirito.
Mina non è riuscita ad accettare di perdermi, l’ambulanza ha trovato tutti i semafori verdi, nessuna fila al pronto soccorso, ho
subito l’intervento. Sono tracheostomizzato.
Oggi respiro con l’ausilio di un
ventilatore polmonare, mi nutro di un alimento artificiale (Pulmocare) e altri
elementi semiliquidi, parlo con l’ausilio di un computer e di un software. La
notte alle volte non riesco a creare quel vuoto mentale che mi permetta di ignorare il rumore del ventilatore polmonare e
allora quell’ansare rauco da bestia ferita a morte mi invade il cervello, mi
paralizza i neuroni, ne blocca la sinapsi, tramuta tutte le percezioni in
terrore. Non è paura di morire, sono già morto una volta ed è stato come
spegnere la luce, non è quindi il dover morire che mi tormenta in quei momenti ma è il dover vivere! Sono gli stessi i tetti e le
antenne che vedo incorniciati dalla finestra, sono gli stessi i dolori e le
disperazioni, gli attimi di smarrimento e i momenti, sempre più rari, in cui
una lettura mi rasserena e mi fa scordare quest’orrore quotidiano, queste
giornate fotocopia, questo nulla che si ripete con costanza diabolica spalmando
le ore, i giorni, i mesi, gli anni sulla traccia di una esistenza
più inutile di un buco di una scarpa ".
E in data 11-6-02 egli scriveva
nel libro: ’’Io non vorrei parlare dei miei guai, ma
ho la pressione a 180 su 130 per colpa del cortisone, mi hanno fatto un
endovena di Lassix, senza cortisone boccheggio come un pesce rosso, l’ulcera
della cannula mi tormenta, ho un orecchio chiuso perché senza la circolazione
d’aria nel naso…non posso muovermi, ho dolori alla schiena, un braccio
gonfio. Non posso parlare, comunico con un campanello … e so che il peggio
deve ancora venire"; e il 25-6-02: ’’Per evitare
che il Pulmocare risalga dallo stomaco al polmone dovrei mettere una sonda che
dal naso arrivi all’intestino superando lo stomaco: quelli del Centro
nutrizionale fanno tutto facile! Un altro tubo … io mi sto sfasciando come un
vecchio scafo. Un po’ di catrame nella stoppa … chiudi un buco e se ne riapre
un altro. Il fasciame non si tiene più e io soffro. Senza poter sperare in una
fine rapida”.
Nella sua audizione la moglie
fornisce ulteriori informazioni ad integrazione di quanto descritto al riguardo
dal marito nel libro ed in particolare riferisce che, subito dopo essersi
conosciuti, il futuro marito le disse tutto sul suo stato di salute,
comunicandole che era malato di distrofia progressiva, e che le spiegò:
«morirò di una morte orribile di soffocamento perché i muscoli piano piano si disfano e la
mia fine sarà quella di non potere più respirare». Ella racconta che, all’epoca
della loro conoscenza {l’ho conosciuto negli anni 70), il marito «ancora camminava
un pochino, con molta difficoltà: aveva una camminata particolare; anche i
movimenti delle braccia, non poteva muovere tante cose. Aveva però ancora la
possibilità di dipingere, di fotografare. Questo nel 1978, e poi andando avanti
fino a tutti gli anni ’70 e ’80, ancora riusciva a sfogliare i libri, parlava
normalmente, respirava normale, mangiava da solo»; poi «nel ’97 gli feci fare delle analisi ed erano tutte okay. Però»,
subito dopo, «ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie, mi accorsi che
respirava male quando stava sdraiato. Verso luglio
però ebbe un attacco fortissimo di insufficienza respiratoria, chiamai il
pronto intervento, il medico della Asl dice che serve il ricovero e mio marito
disse di no: “non mi voglio ricoverare”. Lo alzai poi
dal letto perché non poteva più starci, lo misi seduto e stette seduto tutto il
giorno fino al pomeriggio. Ho visto che incominciavano
a calare gli occhi, sembrava che dovesse svenire da un momento all’altro perché
respirava con molta fatica. Non arrivava più al cervello abbastanza ossigeno.
Io lo sostenni perché appoggiandosi respirava meglio. Quindi gli dissi andiamo
all’ospedale: ’’no’’. Alla fine lo dovevo sorreggere
per farlo respirare ancora ed ad un certo punto mi disse: ’’aiutami’’».
La signora Schett allora con il consenso del marito chiama il pronto soccorso e
«lo abbiamo portato giù con l’ascensore, perché stiamo al sesto piano, con una
carrozzina e dopo che lo avevano messo sulla lettiga io dissi: -mettetelo
seduto perché non respira-. Hanno attaccato l’ossigeno, ma l’ossigeno, la
bombola non serve a nulla se lui non può tirare su l’aria. Svenne, da casa fino
a villa Irma» e, arrivati in ospedale, «un medico poi uscì dopo. Non ricordo
quanto tempo dopo e mi disse: ’’suo marito è in coma,
non so se ce la fa". L’avevano intubato, la sera alle dieci
un’autoambulanza lo portò via al Santo Spirito», Riuscì a riprendere
conoscenza, i medici fecero vari tentativi per farlo respirare autonomamente,
ma inutilmente «così stette per 15 giorni… c’era da fare la scelta e i medici
parlarono con lui prima e gli prospettarono ancora un lasso di tempo se lui si fosse tracheotomizzato, un lasso di tempo ancora di poter
respirare e di poter avere ancora una vita abbastanza decente, insomma, per le
sue condizioni. Poi me lo dissero anche a me e mi dissero
che Piergiorgio aveva detto di sì, di farsi tracheotomizzare. Io volevo prima
parlare con lui, non volevo firmare senza il suo consenso, hanno detto la
stessa cosa davanti a lui … e lui fece sì e io firmai. Fatto l’intervento mio
marito lo vedevo che stava molto, molto male, tutto il suo fisico era andato
sottosopra. Dopo circa una settimana cominciò a stare un pochino meglio. Ebbe
tante difficoltà anche con i medicinali, degli antibiotici che dovettero dare,
era allergico. Poi, quando venne a casa, me lo fece pesare, era quasi come se
fosse arrabbiato con me, e lo capisco, perché non aveva più assolutamente un
movimento: alla lunga degenza gli avevano fatto poca e non adeguata alla sua
malattia fisioterapia. La prima cosa che feci gli dissi: senti io chiamo il
fisioterapista e lui fece di sì al fisioterapista, però serviva anche un
fisiatra e venne anche il dottor Sciarra, venne molto spesso perchè la macchina
aveva bisogno di aggiustamenti, lui aveva bisogno di cure perché all’inizio
aveva avuto di nuovo la febbre e insomma era un periodo di assestamento
piuttosto lungo. Un’infermiera della rianimazione che aveva preso le ferie
aveva promesso di aiutarmi e per una settimana a casa mia mi ha insegnato
tutto, mi ha insegnato come cambiare i filtri, come attaccarlo, come aspirarlo,
fin dove potevo scendere con il sondino con l’aspirazione, poi come girarlo,
come muoverlo sul letto, perché all’inizio era proprio un tronco morto, non
muoveva nulla. Successivamente si riprese di nuovo e si rimise di nuovo seduto
in carrozzina e poteva respirare senza respiratore» per periodi limitati
nell’arco della giornata «e questa era stata per lui una scoperta grandissima
ed era felice. Vedevo che per lui era quasi l’inizio di una nuova vita e
abbiamo cominciato anche di nuovo ad uscire e siamo usciti addirittura senza
respiratore. Lui si sentiva autonomo e libero di respirare, l’unica cosa che
lamentava sempre era che l’aria gli bruciava dentro la trachea
anche se aveva avanti un filtrino. Ha incominciato a scrivere e nel ’98
abbiamo comprato un computer. Su quel computer lui ben presto si fece mettere
anche Internet per poter navigare, per lui questa è stata una cosa bellissima,
poteva fare le sue ricerche, ha messo la parola eutanasia su Google. Fino al 2001 ad ottobre 2001 è uscito per l’ultima volta. Nel 2002, a cavallo del
2001/2002, ha avuto un altro peggioramento, quando gli è andata giù di nuovo la
muscolatura, in particolare, del collo, non poteva più inghiottire e io mi
accorsi che tante volte il cibo gli andava nel polmone perchécominciava a tossire quando mangiava. Abbiamo chiamato il dottor Sciarra
che ci disse che sarebbe stato utile mettere un
sondino. Piero disse che non lo voleva, ma poi però dopo un po’ di tempo all’inizio
di gennaio ebbe una polmonite. Io feci un corso all’Umberto I dal professore
Capello per la nutrizione enterale che poteva essere fatta a casa, il dottor
Sciarra mise il sondino e poi sono tornata a casa con la macchinetta dove avevo
imparato a inserire la sacca, caricare il Pulmocare che era la nutrizione che
riceveva, tramite sondino veniva data. All’inizio non
poteva più inghiottire e quindi abbiamo aspettato un po’, dopo circa sei mesi,
verso agosto di quell’anno, cominciò di nuovo a mangiare qualche cosina
normalmente. Lui mi diceva: “voglio mangiare io, dammi
qualche yogurt”. Successivamente si riprese di nuovo e si rimise seduto di
nuovo in carrozzina, ma dopo quel peggioramento non si poteva più staccare
dalla macchina, lui provava ancora a staccarsi dalla macchina, ma non ce la
fece a rimanere staccato. Dal 2002
in poi all’inizio riusciva ancora a scrivere con un
bastoncino in mano perché aveva ancora un po’ di mobilità con le braccia e
scriveva sulla tastiera con un bastoncino che aveva nella destra e la sinistra
muoveva. A un certo momento gli venne un’infiammazione, sembrava una tendinite,
venne anche il fisiatra, lo esaminò e disse è una tendinite, abbiamo fatto
delle applicazioni ma non c’era verso. Non poteva più
scrivere con il bastoncino perché gli si stancava il braccio, allora prese a
scrivere con un dito, virtuale, sulla tastiera, fino al giugno 2006. Riusciva a
parlare perché c’era un pochino di aria che passava vicina alle corde vocali ed
aveva ancora un pochettino di sforzo da poter fare, anche se un po’ di aria
usciva dallo stoma, perché c’è sempre quella piccola
fessura; fino al 2005, e li si cominciò a lamentare, dunque riusciva ancora a
parlare con grandissimo sforzo anche alla fine ancora, anche l’ultimo giorno
noi abbiamo parlato insieme. Nel 2005 incominciò a lamentarsi che sentiva oppressione sul letto in particolare quando stava
sdraiato: ’’mi fa male il cuore’’. Era sempre attaccato alla macchina.
All’inizio del 2006 sempre più spesso si lamentava di questa difficoltà respiratoria
e una volta poi mi disse: -non riesco più a scrivere tanto. Mi stanco troppo-.
A giugno poi ad un certo punto ha avuto una bronchite, anzi già nel 2005 erano
incominciate delle infezioni batteriche molto frequenti e io mi accorsi che
aveva del muco molto profondo, però non osai andare troppo giù, qualche volta
lui mi disse: ’’vai più giù, non importa succeda quel
che succecia”. La bronchite, ha avuto di nuovo una terapia antibiotica e dopo
quella malattia non si riprese più, mi diceva sempre: ’’sono
troppo stanco, non mi voglio più alzare dal letto, non ci riesco più ad
alzarmi”. Però quando arrivava verso le undici del mattino diceva: ’’senti Mina mi devo alzare, non posso sempre stare a
letto, perché mi sento male alla schiena’’. Allora chiamavo la vicina di casa o
qualche altra persona che mi aiutasse a sorreggerlo
per non farlo cascare all’indietro. Lo misi seduto, prima tirai giù le gambe,
lo misi seduto e poi lo scivolai sulla carrozzella ed era un movimento molto
semplice, lui pesava 70 chili Poi ci sbrigavamo sempre di portare la macchina
dall’altra parte perché vedevo che l’ossigeno gli scendeva parecchio
quando lo alzavamo, scendeva di circa 4, 5 punti e lui si lamentava che
non riusciva a respirare e quindi ci sbrigavamo e, attaccato di nuovo alla
macchina, computer aperto, lui faceva le solite cose con il suo dito, intanto
io facevo altre cose, però vedevo che incominciava lentamente a chinarsi da una
parte e dovevo metterlo sempre di nuovo diritto, seduto diritto. Non riusciva
più a tener la posizione eretta. Questo era luglio, c’è stato peggioramento in
continuazione, lui si lamentava sempre di più. Io vidi che perdeva sempre aria
dallo stoma. Non riusciva più a dormire di notte, perché si sentiva soffocare:
questa fuoriuscita di aria determinava una sensazione sempre maggiore di
soffocamento. Non riusciva più a respirare in maniera adeguata, non lo faceva
dormire di notte e di giorno non gli consentiva quel minimo di autonomia che
aveva avuto fino a quel momento».
Piergiorgio Welby sintetizza nel
suo libro quella sua condizione come di colui che ha «buco in pancia
(gastrostomia) per poterlo alimentare», «un foro nel collo (tracheostomia) per
permettergli di respirare», «un tubicino nell’uretra (caterere vescicolare) per
consentirgli di urinare», con «un’infermiera che gli svuota giornalmente
l’intestino», con somministrazione «di forti terapie antibiotiche per contenere
le infezioni causate dai tubi» ed alla presenza di «decubiti, piaghe dolorose
che corrodono la carne fino all’osso».
Infine egli descrive la sua
situazione psico-fisica dell’ultimo periodo e segnatamente del settembre 2006
nella lettera che invia al Presidente della Repubblica con la richiesta che
venga a lui consentito di porre fine alle sue sofferenze:
«La giornata inizia con l’allarme
del ventilatore polmonare mentre viene cambiato il
filtro umidificatore e il catheter mounth, trascorre con il sottofondo della
radio, tra frequenti aspirazioni delle secrezioni tracheali, monitoraggio dei
parametri ossimetrici, pulizie personali, medicazioni, bevute di pulmocare. Una
volta mi alzavo più tardi alle dieci e mi mettevo a scrivere sul pc. Ora la mia
patologia si è talmente aggravata da non consentirmi di compiere movimenti, il
mio equilibrio fisico è diventato molto precario, A mezzogiorno, con l’aiuto di
mia moglie e di un assistente mi alzo, ma sempre più spesso riesco a malapena a
star seduto senza aprire il computer perché sento una stanchezza mortale. Mi
costringo su una sedia per assumere almeno per un’ora una posizione diversa da
quella supina a letto. Tornato a letto, alle volte mi assopisco, ma mi
risveglio spaventato, sudato e più stanco di prima. Allora faccio accendere la
radio ma l’ascolto distrattamente. Non riesco a concentrarmi perché pensa
sempre come mettere fine a questa vita. Verso le sei faccio un altro sforzo a
mettermi seduto, con Valuto di mia moglie e mio nipote. Ogni giorno vado
peggio, sempre più debole e più stanco. Dopo circa un’ora mi accompagnano a
letto. Guardo la TV,
aspettando che arrivi l’ora della compressa di Tavor per addormentarmi e non
sentire più nulla e nella speranza di non svegliarmi la mattina».
È a quel punto del suo percorso
di vita, consapevole di averne ormai imboccato il tratto finale, che
l’attenzione, che egli aveva dedicato al tema dell’eutanasia
nell’ambito del suo impegno politico presso l’associazione radicale “Luca
Coscioni”, si concretizza in una precisa scelta personale al fine di poter
mettere termine alle sue sofferenze, prive della speranza in una positiva
soluzione, ed al fine di allontanare da sé lo spettro terrorizzante di una
morte terribile per soffocamento, di cui ormai avverte lucidamente la
prossimità, come è chiaramente evincibile dalle sue riflessioni riportate in
precedenza. Ne parla con la moglie, con i suoi amici dell’associazione, scrive,
infine, nel settembre la ricordata lettera al Presidente della Repubblica, che
ivi esprime la sua «profonda partecipazione emotiva all’appello» rivoltogli,
«profondamente toccato come persona e come
Presidente», poiché tale appello «può rappresentare un’occasione di non
frettolosa riflessione su situazioni e temi di particolare complessità sul
piano etico, che richiedono un confronto sensibile ed approfondito», auspicando
«che un tale confronto ci sia nelle sedi più idonee, perché il solo
atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o delusione
di ogni responsabile chiarimento».
Il caso fa molto discutere, si
apre un dibattito acceso nella società civile, ma ,
non vengono chiariti i termini giuridici della questione sotto il profilo della
i liceità di una tale richiesta: né a livello politico, né a livello
legislativo, né ad altro livello; ed è allora che Piergiorgio Welby presenta,
ai sensi dell’art. 700 c.p.c, un ricorso al Giudice, nel quale chiede di
ordinare ai medici che lo hanno in cura di interrompere la terapia di
assistenza respiratoria, che viene esercitata con il ventilatore polmonare,
ormai contro la sua volontà.
Racconta, infatti, la moglie che
già al momento del suo ultimo aggravamento «lui ha già cominciato a giugno a
mettere sul forum dell’associazione dei piccoli messaggi e ha messo anche che
la persona più cara che ho», la moglie stessa, <<non mi vuole aiutare a
concludere la vita. Già a giugno mi aveva chiesto di staccarlo dal respiratore.
Ho detto: -Piero ma tu ti ricordi quella volta nel ’97 che sei andato in coma,
un’altra volta vuoi vivere quella cosa terribile?-
Lui non mi rispose più.
Poi insistendo sempre di più e
sempre più spesso io una volta lo presi con energia e
una volta gli ho detto anche: -sei egoista-. In quel momento però vidi un viso
talmente triste, perché una cosa così non gliela avevo mai detta. Allora io
capii che era veramente diventata una cosa insopportabile per lui.
Mi sono arresa, mi sono arresa di
fronte a lui. Dentro di me mai, dentro di me mai. Alla volontà di lui».
Quindi la moglie cede alla
volontà del marito, ma gli dice che non può chiederle di farlo lei stessa:
«l’unica cosa che non mi puoi chiedere è che ti faccio morire».
«Allora lui prima l’aveva detto
al medico di famiglia: ’’io vogliol’eutanasia, che mi
venga staccata la macchina e che venga lasciato morire". E la dottoressa
diceva: “Piergiorgio io sono contraria all’eutanasia’’. Si rivolse allora al
pneumologo, dottor Sciarra, e glielo chiese: ’’mi si
potrebbe staccare la macchina, però facendomi una sedazione per non soffrire
poi il soffocamento, me lo potrebbe fare lei?’’ Il dottor Sciarra gli disse:
“io ti posso staccare la macchina, ma non posso fare una sedazione, non sono in
grado, quindi serve un anestesista”».
Allora Welby, lui direttamente
-secondo quanto descritto dalla moglie-, si rivolge all’associazione "Luca
Coscioni", di cui fa parte anche con la veste formale di Vicepresidente,
perché gli venga fornito il nominativo di un
anestesista, cui potersi rivolgere. Gli viene dato il
nome del dottor Giuseppe Casale. Con quest’ultimo prende contatti, si
incontrano più volte a casa sua, parlano della malattia ed, infine, gli chiede
-come racconta la moglie- «espressamente di avere un’anestesia terminale per
poter avere staccato il respiratore e poter morire senza soffrire. Il dottor
Casale disse direttamente lì che non avrebbe potuto farlo. Non lo avrebbe fatto
perché nel momento in cui avrebbe avuto difficoltà respiratorie di nuovo,
sarebbe stato necessario che lo avesse attaccato. Allora Piergiorgio si rivolse
alla magistratura, si rivolse al Giudice»
Quindi l’anestesista dott.
Casale, interpellato dal Welby, si era rifiutato di procedere al distacco dal
ventilatore polmonare ed alla contestuale sedazione del paziente, adducendo che
sulla base della sua volontà espressa avrebbe potuto staccarlo dalla macchina e
sedarlo, ma con l’incoscienza di quest’ultimo ed in presenza
del rischio di vita per il paziente sarebbe scattato l’obbligo per lui di
riattaccarlo al polmone artificiale.
Era allora, come in precedenza
accennato, che Piergiorgio Welby, nell’impossibilità di vedere riconosciuta la
sua volontà, presentava al Giudice civile la richiesta di emissione di un
provvedimento d’urgenza, che obbligasse i medici ad ottemperare al suo rifiuto
di proseguire la terapia di assistenza respiratoria.
Il Pm nell’atto di intervento nel
procedimento ex art. 700 c.p.c. si pronunciava in senso favorevole
all’accoglimento del predetto ricorso «sotto il profilo dell’esistenza del
diritto ad interrompere il trattamento terapeutico non voluto, con le modalità richieste», mentre qualificava inammissibile il ricorso con
riferimento «alla possibilità di ordinare ai medici di non ripristinare la
terapia, perché trattasi di una scelta discrezionale affidata al medico, anche
se di una scelta tecnicamente vincolata» per i giudici chiamati dal loro codice
deontologico ad osservare quanto indicato all’art. 37, che prevede che «in caso
di malattia a prognosi sicuramente infausta o prevenuta alla fase terminale, il
medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a
risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a
tutela, per quanto possibile, della qualità della vita».
Il Giudice, invece, con ordinanza
depositata in data 16.12-06 dichiarava il ricorso integralmente inammissibile,non pronunciandosi, pertanto sulla richiesta di distacco
dal ventilatore polmonare formulata da Piergiorgio Welby, in quanto, pur
riconoscendo l’esistenza di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito
di poter richiedere l’interruzione della terapia medica, lo riteneva privo di
tutela giuridica in assenza di specifica normativa di carattere secondario ed
in considerazione del fatto che, anzi, la legislazione positiva si orienta in
senso contrario rispondendo essa al principio della indisponibilità della vita
umana, alla luce di quanto disposto «dagli artt 5 c.c., che vieta gli atti di
disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente, 575,
576, 577, n. 3, 579 e 580, c.p., che puniscono, in particolare, l’omicidio del
consenziente e l’aiuto al suicidio».
Il Pm presentava presso il
Tribunale di Roma reclamo avverso la suindicata ordinanza del Giudice in quanto
la riteneva «affetta da una palese contraddizione» in quanto, qualora si
ammetta l’esistenza di un diritto a pretendere la cessazione ai
un trattamento terapeutico non voluto (come aveva fatto il Giudice nel
suo provvedimento) non si può poi concludere nel senso che « esiste un diritto
soggettivo perfetto insuscettibile di tutela. In altri termini un diritto
soggettivo esiste oìnon esiste; se esiste non potrà non essere tutelato,
incorrendo l’organo di giustizia in un inammissibile non liquet, con l’effetto
di lasciare senza risposta una pretesa giuridicamente riconosciuta»
Peraltro i tempi della giustizia
non potevano più rispondere alle urgenze della drammatica fase esistenziale che
il malato stava affrontando, nella quale le sofferenze fisiche e morali erano
divenute per lui non più sopportabili, come di seguito meglio descritto tramite
il racconto della moglie; infatti, egli ormai sapeva che in qualsiasi momento
poteva sopraggiungere la morte per soffocamento, con il suo carico di terribile
sofferenza, come egli aveva già concretamente sperimentato nel lontano
1997, quando era entrato in coma per insufficienza respiratoria. Pertanto,
quando, tramite l’associazione “Luca Coscioni”, gli fu offerta la possibilità
di un ulteriore contatto con un altro anestesista, il dottor Mario Riccio, che,
sensibile alle problematiche dei malati terminali, si era attivata presso la
predetta associazione, egli fece la medesima richiesta a quest’ultimo.
Dalla testimonianza della moglie,
in particolare, si possono così ricostruire gli ultimi momenti di vita di
Piergiorgio Welby:
«tramite l’associazione Luca
Concioni fu individuata questa persona che prese contatti per saperci
l’indirizzo e si presentò a casa. Era il 18-12-06, era
un lunedì pomeriggio. Io con il dottor Riccio non ebbi nessun contatto:
-buonasera, gradisce un caffè-. Basta. Parlò direttamente mio marito,
assolutamente solo lui. Io ero presente. Fugacemente ogni tanto andavo di là,
perché avevo preparato il caffè. Io sentivo che Piergiorgio rispondeva alle
domande del dottor Riccio, gli spiego la sua patologia, da quanto stava male,
che non riusciva più a respirare e che ormai era arrivato ad un punto che … e
lì spiegava che sentiva oppressione forte al petto, che aveva, questo l’ho
sentito espressamente, che voleva che si staccasse il respiratore e che gli
facesse la sedazione terminale per poter morire. Inoltre siccome già era stato
sollecitato sia da Marco Pannella sia da Marco Cappato e avevano chiesto di far
passare le feste, di aspettare ancora, di poter dare ancora dei tempi alla
politica. Dei tempi per potere decidere anche a favore di una legge per il
testamento biologico, poi d’altra parte ha avuto anche un contatto con il
professor Marino».
Queste persone «hanno insistito
per procrastinare. E invece Piergiorgio ha detto: “no,
basta”. Mi disse tante, tante volte: “basta”. Sì, non
ce la faceva più, tante volte mi diceva: “Mina, quanto sto male, quanto sto
male’’. Lui voleva assolutamente arrivare a concludere.
Era stato lui a scegliere il
giorno e l’ora. Disse: mercoledì, dopo i ’’pacchi’’’, quella trasmissione che
faceva Rai Uno, la sera. Noi veramente non abbiamo mai
visto televisione che io chiamo stupida, di divertimento, non l’abbiamo mai
guardata, ma erano sempre cose impegnative, programmi di discussione,
altrimenti \non la vedevamo mai la televisione e ascoltavamo la radio. Lui
negli ultimi mesi da giugno in poi guardava solo le cose stupide. Non guardava
nemmeno più il telegiornale. Non riusciva più a sostenere nulla.
Dopo quella trasmissione mi
disse: “spegni”. Ho spento il televisore. Poi lui
aveva chiesto chi doveva essere presente alla sua fine e aveva chiesto Marco
Cappato, Marco Pannella, Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti, che poi non
erano presenti all’azione medica, poi naturalmente sua sorella ed il nipote
Simone e naturalmente la mamma, ma la mamma fino all’ultimo momento non ha
saputo nulla, glielo dissi quella sera perché avevo paura di come la prendesse,
anzi è andata lei a farci coraggio, disse: ’’finalmente
lo hanno ascoltato”. Questa è stata la mamma che adesso farà 87 anni e mi domandò quella sera: ’’ma che è tutta questa gente questa
sera qui a casa?” Io le dissi : -oggi Piergiorgio se ne va-. Per un attimo mi
guardò e poi andò da lui e lo salutò»
Infine, la signora Schett nella
sua audizione arriva a descrivere gli ultimi momenti della vita del marito:
«Arrivò il dottor Riccio, gli
dovette trovare una vena, la femorale perché alle braccia non era più possibile
trovare nessuna vena. Eravamo dentro la stanza mia cognata, io. Marco Pannella
e Marco Cappato.
Lo abbiamo salutato e poi mi
disse : ’’Mina per favore questa sera non piangere”.
Glielo ho promesso.
Poi il dottor Riccio ha preparato
l’anestesia, erano due piccoli flaconcini e … io cercai soltanto di sorridergli
come se fosse una cosa per noi. Ero serena perché sapevo che per lui era il
momento più grande della sua vita, l’ultimo passo.
Perché lui diceva che la morte è
un punto nella vita, quindi io credo che lui abbia
creduto che la vita continui, il punto nella vita, non diceva che era la fine,
era un punto nella vita. Quindi doveva rimanere sereno e continuare ad essere
sereno».
Alla precisa domanda di questo
Giudice, se fino all’ultimo il marito abbia continuato
a volere la cessazione della terapia che lo teneva in vita, la moglie
rispondeva:
«Lui mi fece un sorriso e gli
chiesi, -Piero, sei sicuro?-
’’Sì’’,
mi fece.
-Allora dico sì anche io-, gli ho
fatto, – e questo è il mio ultimo sì-. Mi fece un sorriso, mi fece
l’occhiolino, che era il modo con il quale egli esprimeva il suo gradimento,
l’occhiolino e tirare un po’ la bocca. Poi mi disse: “’metti Vivaldi”. E non lo
trovai, non so come è successo, ma non trovai quel
disco e allora mi fece: “metti Bob Dylan”. Misi Bob Dylan non sapendo che
quella canzone era "Questa sera stiamo insieme".
Poi il dottor Riccio mise il
flaconcino e Piero piano piano si addormentò.
Sono rimasta presente fino
all’ultimo e rimasi presente, gli accarezzai la fronte, gli tenni la mano,
gliela strinsi per fargli sentire che ero lì vicina, lo accarezzai e poi mi
misi vicino a lui guancia a guancia, come tante volte avevamo fatto perché era
da anni che non potevamo più dormire nello stesso letto e la sera prima di
addormentarci, prima di andare io sul mio lettino vicino a lui mettevo la
guancia vicino a lui. Questa era la cosa che per lui era molto importante.
Si addormentò.
Mentre il dottore aveva inserito
la sedazione ha staccato, è stata una cosa quasi contemporanea. Io misi la mano
davanti alla cannula per sentire quanta aria uscisse,
ma non si sentiva quasi nulla.
Nel giro di poco è morto.
In assenza di sofferenza»
La descrizione fatta dalla moglie
degli ultimi momenti di Piergiorgio Welby conferma puntualmente la versione
dell’imputato Mario Riccio resa il 21-12-06 alla Pg, ripresa nelle spontanee
dichiarazioni fatte da quest’ultimo al Gip in sede di udienza ex art. 409 c.p.p., e poi integralmente confermata nell’interrogatorio
espletato avanti questo Gup e segnatamente:
«mercoledì sera verso le ore 21:30, mi sono recato presso la sua abitazione. Ricevuta
conferma delle sue volontà, ho proceduto ad incanulare la vena femorale destra
per poter infondere la sedazione. Mi sono allontanato dalla stanza per
permettere ai parenti il saluto in maniera riservata; quando il Welby me lo ha
chiesto sono rientrato ed in presenza della moglie,
della sorella, dell’on. Marco Pannella e dell’on. Marco Cappato, ho iniziato le
manovre di sedazione a mezzo di infusione di farmaci e contestualmente ho
interrotto la ventilazione meccanica. Il tutto è avvenuto in condizioni di
sedazione continua, fintanto che ho accertato il decesso avvenuto alle ore 23:40. Dall’inizio della sedazione ho staccato la macchina per
la ventilazione».
La morte di Piergiorgio Welby veniva constatata essere avvenuta alle 23:40 del 20-12-06
per «arresto cardio-respiratorio, secondario a grave insufficienza respiratoria»,
come certificato dal dottor Riccio e dal medico di famiglia, dott.ssa Wilma
Trotta, nell’immediatezza dei fatti.
Inoltre, veniva
redatto dal dott. Riccio un diario clinico che descriveva in maniera minuziosa
le fasi dell’intervento prestato nei confronti del malato, in particolare, ivi
si dava atto che: «il sig. Piergiorgio Welby mi ha chiesto di interrompere la
terapia ventilatoria sotto sedazione. Egli infatti mi
ha confermato sia oggi che nei giorni precedenti la sua volontà in tal senso.
Rifiuta infatti la terapia ventilatoria meccanica alla
quale è sottoposto da circa 10 anni, essendo portatore ai distrofia muscolare
scapolo omerale dal 1962, Nonostante la sua quasi immobilità, può infatti
ancora comunicare con alcuni movimenti delle labbra e degli occhi In
particolare risponde efficacemente alle domande a risposta chiusa. È’ in grado
inoltre di pronunciare brevi frasi ben comprensibili se si avvicina il proprio
orecchio alla sua bocca. Pertanto ho potuto prendere piena conoscenza delle sue
volontà. A quanto di seguito descritto sono presenti Schett Wilhelmine, Carla
Welby, Marco Pannella, Marco Cappato. Pertanto come richiesto dal sig, Welby
procedo come di seguito riportato». In tale diario si descrive minuziosamente
le varie fasi dell’intervento nei termini già precedentemente riferiti in
sintesi e costituite essenzialmente nella somministrazione di sedativo «e nel
contempo nel distacco del ventilatore meccanico del paziente, procedendo ad un
monitoraggio delle principale funzioni vitali a
partire dalle ore 22:55 sino al momento del decesso, constatato alla ore 23:40,
sempre del 20-12-06». Tale verbale veniva, poi,
sottoscritto a conferma del suo contenuto dalle persone che erano state
presenti fino all’ultimo, ovvero dalla moglie, dalla sorella e dai due
parlamentari sopra citati.
D’altra parte l’on. Marco
Cappato, sentito dalla Pg sul punto, confermava anche oralmente quanto
affermato dall’imputato (v. verb. 21-12-06, Quest.
Roma).
Inoltre, l’accertamento
medico-legale e chimico disposto dal Pm sulla salma della vittima si concludeva
nel senso di fornire ulteriori riscontri alla ricostruzione dei fatti sopra
operata, in quanto:
● «l’esame necroscopico ha
permesso di constatare che la diffusione della distrofia muscolare sofferta dal
sig. Welby e l’entità della sostituzione da parte del tessuto fìbro-adiposo di
quello muscolare, estremamente marcata, il che giustifica la evidente
ipotrofia delle masse muscolari e permette di affermare che il soggetto era
affetto da una gravissima compromissione della sua funzione motoria volontaria
carico dei vari distretti corporei»;
● «èpossibile affermare che
l’irreversibile insufficienza respiratoria sia da attribuire unicamente
all’impossibilità dell’uomo di ventilare meccanicamente in maniera spontanea a
causa della gravissima distrofia muscolare da cui loìstesso era affetto»;
● «il decesso è stato
causato da un danno ipossico ischemico sistematico conseguente ad un gravissimi distress respiratorio con danno alveolare
diffuso, indice di una gravissima ed irreversibile insufficienza respiratoria»;
● le sostanze sedative
somministrate dal dottor. Riccio, ovvero il Propofol ed il Midazolan, non hanno
inibito la funzione respiratoria, poiché la quantità somministrata di Propofol
«può essere considerata inefficace a produrre depressione respiratoria» e per
quanto riguarda «il Midazolan a dosaggio ipnotico è senza effetto sulla
respirazione nel soggetto normale. Pertanto le concentrazioni dei farmaci
somministrati sono risultate tali da non poter loro attribuire un qualsivoglia
ruolo causale o concausale di rilevanza penale nel determinismo del decesso»;
in ogni caso la presenza di quest’ultimo farmaco, indicato dal dott. Riccio
come uno dei due sedativi somministrati al paziente, non veniva
neppure riscontrato nei tessuti di quest’ultimo a causa evidentemente della sua
esigua concentrazione;
● «è possibile affermare
che l’irreversibile insufficienza respiratoria sia da attribuire unicamente
all’impossibilità dell’uomo di ventilare meccanicamente in maniera spontanea a
causa della gravissima distrofia muscolare da cui lo stesso era affetto»;
● «l’insufficienza
respiratoria» conseguente al distacco dal polmone meccanico «si
à instaurata in un periodo di tempo non molto prolungato, quantificabile in
alcune decine di minuti».
Pertanto nella relazione tecnica
si dava atto dello stadio gravissimo a cui era giunta
la patologia sofferta dal defunto e delle cause del decesso, costituite
unicamente dalla grave insufficienza respiratoria, dovuta alla sua
impossibilità di respirazione autonoma quando si era proceduto al distacco del
ventilatore meccanico. Inoltre si escludeva che vi fossero state delle
complicanze conseguenti alla somministrazione da parte dell’anestesista dei
suindicati farmaci a scopo sedativo.
Alla luce di tali acquisizioni,
in data 5-3-07, il Pm richiedeva l’archiviazione, in
linea con l’orientamento assunto dalla Procura della Repubblica di Roma nella
procedura d’urgenza attivata presso il Giudice civile, ritenendo non rilevante
penalmente la condotta del Riccio, in quanto egli aveva agito solo in ossequio
della richiesta di interruzione della terapia formulata dal paziente, che a sua
volta aveva esercitato un suo diritto riconosciuto e tutelato pienamente
dall’ordinamento giuridico italiano.
Il Gip, cui perveniva la
suindicata richiesta, invece andava di contrario avviso e, fissata la relativa
camera di consiglio, concludeva, imponendo al Pm di formulare l’imputazione nei
confronti del Riccio per omicidio del consenziente.
Va detto innanzitutto che la
suindicata ricostruzione dei fatti appare fondata su dati probatori certi,
perché suffragati da diverse testimonianze incrociate, peraltro rese da persone
legate alla vittima e, pertanto, prive di un interesse personale a sostenere la
difesa dell’imputato.- Le testimonianze, in particolare quella assai utile
della moglie, appaiono dettagliate, esaustive, coerenti, logiche, prive di
condizionamenti fuorvianti e riscontrate non solo tra loro, ma anche dai dati
fattuali e dalla relazione medico-legale per la parte afferente l’epilogo della
vicenda in esame. L’accertamento tecnico disposto dal Pm, poi, appare
confermare punto per punto la relazione scritta dall’imputato Mario Riccio, in
cui descrive il suo intervento presso il paziente, nonché le dichiarazioni
rese, peraltro sempre con intrinseca coerenza, dal medesimo nelle diverse sedi.
Poi, fatto certamente assai
inusuale, entrano prepotentemente come contributo essenziale nella
ricostruzione dei fatti le affermazioni della stessa ritenuta vittima ovvero le
riflessioni di Piergiorgio Welby, precedentemente riportate, che, in ragione
del loro contenuto, chiariscono importanti punti della vicenda. Sulla
autenticità e totale riconducibilità di tali dichiarazioni al Welby è la moglie
a fornire ogni chiarimento nel corso dell’audizione davanti al Gup. Infatti, in
quella sede ella affermava che il marito aveva sempre scritto personalmente
tutto, «aveva una tastierina virtuale dove poteva muovere con il dito il
cursore», e che in particolare nel libro “Lasciatemi morire” erano stati raccolti
dall’editore alcuni degli interventi e delle riflessioni del marito che egli
aveva diffuso su siti propri e dell’associazione “Luca Coscioni”, nonché sul
forum intitolato “Eutanasia”, nel corso degli anni, dal 2002 fino al giugno
2006, ovvero fino a quando la malattia glielo aveva consentito. Quanto poi alla
lettera indirizzata al Presidente della Repubblica nel settembre 2006 la moglie
riferiva che egli non le comunicò precedentemente neppure l’intenzione di
scrivere a tale autorità «ha fatto sempre tutto da solo» e dopo avere scritto
«me lo comunicò: “ho scritto al Presidente”, lessi la
lettera e dissi: – Piero, questo adesso rende tutto pubblico, ti rendi conto di
cosa ti succede? Che qui non puoi più decidere da solo in qualsiasi maniera-.
Insomma ero molto perplessa», ma lui insistette e disse: ’’non mi interessa
più per me, mi interessa tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho fatto
non deve andare perso”. Io capii che lui mi parlava da uomo politico e non era
soltanto il mio Piergiorgio e che qui lo dovevo assecondare, dovevo stare a
quello che voleva lui, fino infondo e allora rio detto: -Piero, ci facciamo
coraggio-».
È pertanto chiaro che il
contenuto degli scritti del predetto sia attribuibile solo a quest’ultimo e sia
frutto, quindi, di sue personali e sofferte
riflessioni, nonché di decisioni prese In totale autonomia; comunque una
considerazione va fatta anche sulla "politicità" della condotta di
Piergiorgio Welby, che nell’occasione della redazione della lettera al
Presidente ed in altri analoghi momenti di esternazione, pm che da un’urgenza
di natura squisitamente politica, appare animato dalla necessità di dare un
senso alla propria sofferenza, altrimenti sorda e senza speranza, e di dare una
più alta finalizzazione ad una esperienza personale, altrimenti inutile, perché
naturalmente proiettata solo alla morte fisica dell’individuo. Sembra, infatti,
leggersi in una tale condotta una precisa volontà dell’uomo di mettere a]
servizio degli altri la personale esperienza affinché la propria sofferenza potesse almeno servire come occasione di riflessione per
stimolare gli organi competenti a dare soluzioni più rispettose dei diritti dei
malati e potesse quindi servire a recare sollievo a persone che si fossero
trovate nelle sue stesse condizioni. Con ciò improntando, pertanto, lai propria
condotta, pur nella durezza dei momenti vissuti, ad una visione di generosa
apertura agli altri «tutto quello che ho fatto non deve andare perso», come a
dire: tutto ciò deve pur servire a qualcun altro, solo così posso dare un senso
alla mia sofferenza che altrimenti mi schiaccerebbe con il
suo mutile peso.
Per quanto riguarda la pronuncia
emessa in sede civile dal Giudice presso il Tribunale di Roma va innanzi tutto
precisato che anche quella Ag, pur misurandosi con un oggetto decisionale
ovviamente diverso, si è dovuta confrontare con i medesimi principi
costituzionali e con i medesimi principi generali dell’ordinamento giuridico
che anche in questa sede devono essere considerati.
In particolare, il Giudice
civile, con ordinanza depositata in data 16-12-06,
dichiarava il ricorso ex art. 700 c.p.c. integralmente inammissibile (non
procunciandosi, pertanto, sulla richiesta di distacco dal ventilatore polmonare
formulata da Piergiorgio Welby) in quanto:
a) pur riconoscendo la
sussistenza nel nostro ordinamento giuridico del principio di rango
costituzionale all’«autodeterminazione individuale e consepevole» in materia di
trattamento sanitario, tale AG riteneva hce la sua attuazione pratica, in caso
di rifiuto o di interruzione di terapie di mantenimento in vita del paziente,
non fosse possibile in assenza di una normativa specifica, atteso che la
legislazione positiva si orienta, anzi, in senso contrario, rispondendo essa al
principio della indisponibilità della vita umana, alla luce di quanto disposto
«dagli artt, 5, c.c., che vieta gli atti di
disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente, 575,
576, 577, n. 3, 579 e 580, c.p.,., che puniscono, in particolare, l’omicidio
del consenziente e l’aiuto al suicidio»;
b) anche se si deve dare atto che
«il divieto di accanimento terapeutico è un principio solidamente basato sui
principi costituzionali di tutela della persona, esso tuttavia sul piano
dell’attuazione pratica lascia il posto all’interpretazione soggettiva ed alla
discrezionalità nella definizione di concetti, sì, di altissimo contenuto
morale e di civiltà, ma che sono indeterminati ed appartengono ad un campo non
ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall’intervento
del Giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il
ricorso all’analogia o ai principi generali dell’ordinamento»;
c) conseguentemente “il diritto
del ricorrente di richiedere l’interruzione della respirazione assistita deve
ritenersi sussistente, ma trattasi di un diritto non concretamente tutelato
dall’ordinamento giuridico, in altri termini in assenza di una previsione
normativa degli elementi concreti, di natura fattuale e scientifica, di una
delimitazione giuridica di ciò che va considerato “accanimento terapeutico”, va
esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da far valere
nel giudizio di merito con inammissibilità dell’azione cautelare” esercitata
dal Welby.
Tali conclusioni inducono a fare alcune
considerazioni: la prima è che quando si riconosce resistènza di un diritto di
rango costituzionale, quale quello air«autodeterminazione individuale e
consapevole» in materia di trattamento sanitario, non è, poi, consentito
lasciarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria di
specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta
dell’esistenza di disposizioni normative di fonte gerarchica inferiore a
contenuto contrario, quali «gli artt. 5 c.c., che
vieta gli atti di disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno
permanente, e 575, 576, 577, n. 3, 579 e 580, c.p., che puniscono, in
particolare, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio», nonché quali
gli artt. 35 e 37 del codice di deontologia medica. In
realtà, se si accogliesse una tale conclusione, potremmo incorrere in una
palese violazione dei principi che presiedono alla disciplina della gerarchia
delle fonti, in quanto non è consentito disattendere l’applicazione di una
norma costituzionale sulla scorta dell’esistenza di norme contrastanti di
valore formale inferiore, perché delle due è l’una: o si privilegia r
interpretazione che faccia salvo il principio costituzionale con immediata
applicazione di quest’ultimo, disattendendo l’interpretazione contraria della
norma, (sul punto la Corte
costituzionale si è più volte pronunciata negando la fondatezza della questione
di costituzionalità eventualmente sollevata nel caso specifico, perché il
Giudice tra interpretazioni diverse avrebbe dovuto privilegiare quella conforme
alla norma costituzionale immediatamente applicabile, potendo autonomamente
disattendere itnerpretazioni di segno diverso a quest’ultima; vedi al riguardo
ad esempio: sent. 6.7.01, n. 224; ord. 4.7.02, n. 315) oppure, in caso
di insuperabile conflitto, si deve sollevare questione di legittimità
costituzionale, ma certamente non si può lasciare inattuato un principio
costituzionale e senzatutela giuridica il diritto soggettivo che da esso discende. D’altra parte neppure il Giudice civile nella
sua motivazione ha mai ritenuto di poter invocare esplicitamente a sostegno
della propria decisione quella teoria, ormai desueta e superata da univoca
giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per la quale le disposizioni
costituzionali si suddividono in norme programmatiche, ovvero non
immediatamente applicabili senza normazione attuativa di tipo
secondario e sostanzialmente non cogenti, ed in norme procettive, ovvero
immediatamente applicabili. D’altra parte è impossibile sostenere una ineffettività del principio costituzionale di cui
all’art. 32, co. 2, Cost., alla cui immediata precettività, anzi, lo stesso
legislatore ordinario si vincolava, quando per costringere taluno, anche se
incapace di intendere e di volere, a sottoporsi ad un trattamento sanitario
riteneva di emanare una apposita legge (1. n. 180/78),
Se da un punto di vista formale appare del tutto arduo operare una comparazione
tra una previsione costituzionale ed una legge ordinaria, ciò appare ancora più
difficile se il confronto viene fatto con una norma contenuta in un codice di
deontologia professionale, soprattutto quando si arrivi ad affermare, poi, la
prevalenza di quest’ultima. Oltre al fatto che ciò non è sostenibile neppure da
un punto di vista sostanziale, poiché nelle stesso codice
di deontologia medica si dice una cosa ben diversa all’art. 37, che appare
direttamente applicabile alla fattispecie in esame: «in caso di malattia a
prognosi sicuramente infausta o pervenuta alla fase terminale, il medico deve
limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiane
inutili sofferenze», mentre quanto riferito all’art. 35- «anche su richiesta
del malato il medico non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a
provocarne la morte» – appare essere una affermazione di principio del tutto
generica, contemperata poi da previsioni riferite a casi particolari, come è
appunto il caso previsto dall’art. 37 dello stesso codice deontologico, codice
che altrimenti conterebbe al suo intemo elementi di insuperabile
contraddittorietà. In ogni caso l’azione di interruzione di una terapia non può
essere concettualmente assimilata all’espletamento di «un trattamento diretto a
provocare la morte» del paziente, poiché la prima costituisce mera cessazione
di una terapia precedentemente somministrata mentre il
secondo è l’attivazione ex novo di un intervento terapeutico finalizzato ai
decesso del paziente. Quanto poi all’ulteriore previsione contenuta nell’art. 37 e riguardante anche l’obbligo per il medico di «proseguire
nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile», essa è
esplicitamente riferita al «caso di compromissione dello stato di coscienza»
del paziente, che è ipotesi del tutto diversa rispetto al caso in esame, nel
quale Piergiorgio Welby è stato fino all’ultimo cosciente.
D’altronde, che non si possa arrivare a conclusioni diverse è autorevolmente
confermato dall’esito del procedimento instaurato dalla competente Commissione
discliplinare dell’Ordine dei Medici di Cremona che, in data 1-2-07 e con
riferimento ai fatti in esame, chiudeva l’istruttoria preliminare, escludendo
che a carico del dottor Riccio ci fossero i presupposti per aprire un
procedimento disciplinare e rilevnadone la piena conformità di condotta con le
norme di deontologia preposte all’esercizio della professione medica.
Inoltre, identificare il
contenuto del diritto air autodeterminazione informata del malato come diritto
a far cessare l’accanimento terapeutico appare un modo di procedere non
condivisibile, ciò proprio per le ragioni rappresentate dallo stesso Giudice
civile. Infatti, secondo tale AG, allo stato della legislazione, nessuno è in
grado di dare una definizione di accanimento terapeutico e descrivere in cosa consista. Pertanto individuare il contenuto di im diritto
soggettivo facendo riferimento ad im concetto giuridicamente inesistente, quale
è, allo stato, quello dell’accanimento terapeutico, e facendo riferimento a
quella che anche nella realtà è un’esperienza variegata e di difficile
definizione, appare essere un’operazione opinabile perché costruita su
parametri concettuali di riferimento non definiti ne
definibili (sarebbe come dire che il contenuto di un diritto consista in
qualcosa che non si è in grado di sapere cosa sia); inoltre, essa si rivelerebbe
un’operazione inconcludente, perché destinata a finire con un nulla di fatto,
disattendendo, conseguentemente, lo stesso precetto costituzionale e lasciando
senza tutela giuridica il diritto soggettivo da esso direttamente promanante.
Invece la previsione costituzionale appare godere di una sua precisa autonomia
concettuale, in quanto in essa non si rinviene alcun
riferimento letterale o interpretativo che possa rimandare al cosiddetto
“accanimento terapeutico” (esperienza, per giunta, del tutto estranea all’epoca
di redazione del testo costituzionale), non avendo il legislatore
costituzionale (direttamente o indirettamente) posto limiti all’esercizio del
riconosciuto diritto soggettivo che possano passare attraverso un tale
concetto. Pertanto, a parere di questo Giudice, l’esercizio del diritto di
autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, allo stato della
legislazione, non ha come presupposto necessario la sussistenza di una
situazione riponducibile ad una condizione qualificabile come accanimento
terapeutico.
Non va inoltre dimenticato che,
se è vero, come lo stesso Giudice civile ha indicato, che l’intervento del
medico a favore del paziente debba essere giuridicamente giustificato in
ragione dell’esistenza di uno stato di necessità, è altrettanto vero che nel
nostro ordinamento giuridico non è rinvenibile alcun obbligo giuridico per il
medico di intervenire prescindendo dalla volontà del paziente. Infatti lo stato di necessità, quale causa oggettiva di
esclusione del reato, non impone alcun obbligo di intervento ma si limita ad
escludere rilevanza penale della condotta del medico che intervenga a favore
della sopravvivenza del malato, anche senza avere acquisito il consenso di
quest’ultimo. Se ciò è vero nel caso di assenza di consenso, a maggior ragione
non esiste alcun obbligo giuridico per il medico di intervenire se il paziente
stesso abbia addirittura espresso il proprio dissenso
informato.
La decisione del Giudice penale,
invece, seguiva in data 7-6-07 alla richiesta di
archiviazione del PM, che con quella richiesta aveva motivatamente ribadito la
posizione della Procura sulla vicenda, con i medesimi argomenti sostenuti già
in sede civile.
Nell’ordinanza di rigètto della
richiesta di archiviazione, con contestuale imposizione dell’imputazione contro
Riccio Mario per il reato di omicidio del consenziente, il GIP individua nei
seguenti punti il suo percorso decisionale :
a) rincontestabile esistenza di
un principio alla libertà di cura sancito dall’art. 32 Cost. comporta
conseguentemente, secondo il GIP, che di esso «debba
essere data attuazione anche in assenza di una specifica normativa, con il solo
limite degli altri diritti costituzionalmente garantiti Tra essi deve essere
ovviamente compreso il diritto alla vita». Tra questi diritti non esiste un
rapporto di gerarchia o di incompatibilità sostanziale, ma devono essere
«armonizzati», senza che, però, «l’assenza di una disciplina normativa» comporti
«l’impossibilità di dare attuazione al diritto del paziente di rifiuto di cure,
quando da tale rifiuto ne derivi la morte». Secondo tale AG, pertanto, la
necessità di bilanciamento dei diversi principi in questo campo «comporta che
sia rimessa al Giudice l’interpretazione o meglio l’individuazione della regola
di interpretazione da adottare nel caso specifico»;
b) in ottemperanza al criterio
procedurale di valutazione caso per caso da parte del Giudice, il Gip procedeva
a tale operazione, ritenendo che “il diritto alla vita nella sua sacralità,
inviolabilità ed indisponibilità costituisca il limite per tutti gli altri
diritti, che, come quello affermato dall’art. 32, Cost.,
siano posti a tutela della dignità umana”. L’espressione di una prevalenza del
diritto alla vita, in ogni caso, si rinviene, secondo il Gip, nell’ordinamento
giuridico nella previsione dei reati di cui agli artt. 579 e 580, c.p., nonché nel divieto sancito dall’art. 5, c.c.;
c) nel caso di specie non vi è
stato alcun accanimento terapeutico, in quanto non era stata applicata alcuna
terapia in senso stretto, non essendo qualificabile come terapia
il mero sostegno vitale costituito dall’applicazione del ventilatore
meccanico;
d) il GIP afferma, poi,”la necessità di una disciplina normativa che preveda delle
regole alle quali attenersi in simili casi, fissando in particolare il momento
in cui la condotta del medico rientri nel divieto di accanimento terapeutico;
ma, in assenza di disciplina, il principio di cui all’art 32, Cost., non può
essere riconosciuta un estensione tale da superare il limite insuperabile del
diritto alla vita”, ed inoltre “il timore evocato dal Giudice civile sulla
possibilità che l’atutazione di un diritto, in assenza di una disciplina
normativa, sia rimessa alla totale discrezionalità di qualsiasi medico al quale
la richiesta venga fatta si è rivelato fondato” ed in particolare le “modalità
adottate per dare attuazione al diritto di interrompere la terapia di
ventilazione artificiale sono discutibili anche sotto il profilo etico”;
e) sussiste nel caso in esame,
secondo il Gip, il reato di cui all’art. 579 c.p., con
riferimento sia all’elemento oggettivo della condanna, sia all’elemento
soggettivo del dolo, e segnatamente sotto quest’ultimo profilo tale AG rileva
che era stato lo stesso Riccio, incurante della decisione del Giudice civile e
rispondendo più a motivazioni di carattere politico, a farsi avanti per
interrompere la terapia al Welby, senza essere il suo medico curante e sulla
base di un rapporto professionale “del tutto superficiale”.
Alla luce di quanto sopra
riportato, appare evidente come il Gip, che era andato oltre la posizione
sostenuta dal Giudice civile (affermando che, anche in assenza di normativa
specifica, al principio costituzionale della libertà di cura doveva essere data
immediata attuazione) abbia poi impresso al suo pensiero un’inversione di
direzione, concludendo, invece, che per poter dare concreta attuazione all’art.
32, co. 2, Cost., sia, comunque, “necessaria una
disciplina normativa che preveda delle regole alle quali attenersi in casi
simili”, in tal modo non distinguendo la propria posizione, nell’approdo
finale, da quella assunta dal Giudice civile, del quale, anzi, arrivava a
condividerne i timori in ordine al fatto che, in assenza di una normativa,
l’attuazione del diritto in questione “sia poi rimessa alla totale
discrezionalità di un qualsiasi medico”.
Oltre a rilevare una certa
discontinuità motivazionale che, date alcune premesse, deve essere superata
attraverso i conseguenti passi all’interno di un coerente percorso logico, in
realtà non è neppure condivisibile l’opinione secondo la quale il timore del
Giudice civile nel caso in esame si sia rivelato
fondato. Infatti, al medico spetta solamente dare attuazione alla richiesta del
malato, oppure disattenderla ove riscontrasse l’assenza delle condizioni di cui
si parlerà in seguito. Relativamente invece alla “discrezionalità, cioè la
scelta di rifiutare o di interrompere o meno la
terapia, essa spetta e deve essere esercitata (come è avvenuto nel caso in
esame secondo l’approfondita ricostruzione dei fatti sopra effettuata)
unicamente dal titolare del diritto e segnatamente dal paziente. È nnegabile
che in questo caso il medico si è limitato a controllare la sussistenza di una
richiesta consapevole ed informata in Piergiorgio Welby e, soltanto dopo, ha
proceduto ad interrompere la terapia, così come gli era stato richiesto. In
tutto ciò non risulta essere stata esercitata alcuna discrezionalità da parte
dell’imputato Riccio, essendosi egli limitato ad eseguire con scrupolo e
precisione la volontà del paziente, nonché tutte le sue indicazioni, anche
sotto il profilo delle modalità e dei tempi di attuazione. Infatti
se il medico avesse effettivamente riservato a sé un autonomo spazio decisionle
in assenza o addirittura in contrasto con la volontà del paziente, trattandosi
di un caso di interruzione di terapia salvavita, il GIP avrebbe dovuto chiedere
coerentemente l’imputazione coatta per omicidio volontario e non per omicidio
del consenziente, come in realtà faceva. In tal modo il GIP ha riconosciuto
che, in ogni caso, la condotta del medico non era stata mossa da una scelta
“discrezionale”, bensì essa si era strettamente attenuta alla volontà del
paziente.
Sulla conclusione, poi, che non sia
rinvenibile nel caso in esame un’ipotesi di accanimento terapeutico si può
essere d’accordo, ma per motivi diversi da quelli indicati dal Gip. Infatti il mantenimento della terapia di ventilazione
assistita, nonostante il dissenso del malato, non può essere giuridicamente
qualificato come accanimento terapeutico – qualunque contenuto si voglia
attribuire a questo concetto-, bensì come violazione di un diritto del
paziente, costituzionalmente garantito, che aveva espresso la sua volontà
consapevole ed informata di interruzione della terapia in atto" (
conformemente cass. 29.5.02, Volterrani, n. 26446, come meglio di seguito
indicato ). In verità l’assenza, nel caso in esame, di un’ipotesi riconducibile
alla nozione di accanimento terapeutico non sposta minimamente i termini della
questione, poiché non è l’esistenza dell’accanimento terapeutico a connotare di
legittimità la condotta del medico che lo faccia cessare; bensì è la volontà
espressa dal paziente di voler interrompere la terapia ad escludere la rilevanza
penale della condotta del medico che interrompa il trattamento.
Non può escludersi, inoltre, come
ha fatto invece il GIP, nei confronti della ventilazione assistita la natura di
terapia sol perché attinente «al sostegno di funzioni vitali», poiché altrimenti
anche un’operazione al cuore, pur complessissima, non potrebbe essere
qualificata come intervento terapeutico, in quanto anch’essa effettuata a
sostegno di una funzione vitale quale è indubbiamente quella svolta dal muscolo
cardiaco. Va, invece, certamente qualificata come terapia, o comunque come
trattamento sanitario, Fattività di ventilazione meccanica cui era stato sottoposto Piergiorgio Welby dopo un intervento
assai invasivo quale è un’operazione di tracheotomia. Trattasi infatti di induzione artificiale della respirazione tramite
l’azione di una macchina, alla quale Piergiorgio Welby doveva rimanere
costantemente attaccato, ed in ragione della quale egli doveva essere
quotidianamente sottoposto a terapie antibiotiche che scongiurassero l’insorgere
di infezioni dello stoma e del canale di inserimento, con contestuale
asportazione del muco generatosi per T induzione meccanica della respirazione.
Pertanto il predetto, chiedendo il distacco dal polmone artificiale, ha
effettivamente esercitato il suo diritto di interrompere un trattamento
sanitario, come individuato dalla norma costituzionale, non essendo
diversamente qualificabile l’induzione artificiale della respirazione per i
motivi sopra rappresentati.
Non è neppure rilevante, sotto il
profilo della configurabilità del reato! contestato
all’imputato, che il dottor Riccio fosse o non fosse l’abituale medico curante
di Piergiorgio Welby. Va infatti rilevato che, in ogni
caso, si era instaurato un preciso rapporto tra i due, finalizzato ad un intervento
a contenuto sanitario ben individuato | dal medico e dal paziente, ovvero il
distacco dal respiratore artificiale con la contestuale somministrazione di
sostanze sedative. Tali sostanze potevano essere somministrate (nella qualità,
nella misura, nella loro reciproca combinazione e nella loro interazione con la
malattia sofferta dal paziente) solo da uno specialista anestesista, come ebbe
ad indicare lo stesso medico curante del Welby, dottor Sciarra, quando, alla
richiesta del suo paziente di interrompere la ventilazione assistita, gli
rispose che avrebbe potuto certamente staccarlo dalla macchina, ma che, quanto
alla sedazione, lui non era in grado, essendo necessario al riguardo uno specialista anestesista. D’altra parte non è necessario
per T instaurazione di un rapporto di questo tipo che il medico sia quello che ha il paziente in cura da tempo, poiché si
può creare la necessità, ad esempio, di un consulto di uno specialista su un
singolo problema emergente. Ad esempio, può avvenire che un paziente si rivolga
ad un medico ortopedico, quando per disavventura si fratturi inaspettatamente
una gamba, oppure che, dopo essersi rotto una gamba, il paziente vada da un
diverso ortopedico rispetto a quello cui si era rivolto precedentemente solo
per avere, ad esempio, conferma della giustezza delle indicazioni di
quest’ultimo. Si può forse escludere in tali casi resistenza di un preciso
accordo terapeutico tra paziente e medico?
Pertanto l’esistenza del rapporto
tra medico e paziente prescinde dalla durata del rapporto stesso e
dall’esistenza di una cura in corso, sempre sia chiaro l’oggetto della
richiesta del paziente ed esso considsta in una prestazione di carattere
medico, come è avvenuto nel caso in esame. Né rilevante appare essere il
rapporto instaurato tra Piergiorgio Welby ed il dottor Riccio sia stato “un
rapporto professionale del tutto superficiale”, in quanto superficiale o meno
esso è comunque un rapporto professionale tra medico e paziente. La
superficialità del dottor Riccio, poi, è tutta da dimostrare, atteso lo
scrupolo con il quale l’anestesista ha proceduto, come dimostrano il verbale
del suo intervento e le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal Pm.
In tali conclusioni i consulenti danno atto che la somministrazione dei sedativi
è stata effettuata dal medico nella qualità e nella misura tali da non
interferire con la patologia sofferta dal paziente, non inducendo la morte di
quest’ultimo, ma solo consentendo l’efficace sedazione del malato, al fine di
scongiurare in quest’ultimo ogni sofferenza che il
distacco dalla macchina avrebbe causato con l’inevitabile instaurarsi della
sindrome da soffocamento.
Infine, non sembra individuabile
alcuna specifica indicazione normativa che possa
direttamente o indirettamente far ritenere che l’esercizio del diritto
soggettivo di rifiuto delle terapie mediche debba essere subordinato ad una
valutazione preventiva e caso per caso di un Giudice. Infatti, laddove il
legislatore ha voluto garantire l’esercizio corretto e consapevole di alcuni
diritti di problematica valutazione etico-sociale o nei casi di contrasto di
opposti interessi oppure quando ha inteso tutelare le e. d. figure
"deboli", egli ha sempre dovuto prevedere esplicitamente specifiche
scriminanti procedurali, rispetto alle quali è stato inserito il Giudice in
qualità di figura di garanzia, come ad esempio è avvenuto nei caso del diritto
di abortire riconosciuto alla minore.
Quale Giudice, quando e come
possa esercitare un tale compito in questa materia rimangono, infatti, tutte
domande senza risposta, che non consentono pertanto di seguire la strada
indicata dal GIP.
Appare necessario, prima di
andare oltre nell’affrontare ogni altra questione, chiarire che la dimensione
etica in senso stretto, ovvero se non richiamata direttamente o indirettamente
in concetti giuridici, non può far parte di questa disamina; pertanto concetti
come "sacralità" del diritto alla vita oppure valutazioni sotto il
profilo meramente etico della condotta dell’imputato non possono avere
cittadinanza nelle argomentazioni di questo Giudice, che deve \ rigorosamente
mantenere separate le proprie personalissime scelte etiche rispetto
/^all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Esula dal mondo giuridico ed
esula pertanto anche dalle argomentazioni di questo Giudice, ad esemtóo, il
concetto di "sacralità’’ del diritto alla vita. Quest’ultimo, infatti,
pojrà essere "inviolabile", "indisponibile", ma non
"sacro", qualità, questa, che rimanda al fatto che esso debba essere
letteralmente oggetto di ’Venerazione", di "adorazione" in
quanto partecipe della natura divina, e che attiene conseguentemente al mondo
della religione.
I percorsi logici seguiti dai
predetti Giudici, pur con le loro diversità, hanno evidenziato, a parere di
questo Gup, delle discontinuità motivazionali, che impongono conseguentemente,
proprio lì dove si sono evidenziate, di intraprendere un percorso diverso,
partendo, comunque, da un dato di fondamentale importanza e comune alla
riflessione di entrambi i Giudici e dei PM che sono intervenuti nella vicenda
in esame, costituito dal riconoscimento dell’esistenza di un diritto della
persona a rifiutare o interrompere le terapie mediche, discendente dal
principio enunciato dal secondo comma dell’art. 32, Cos.,
secondo il quale “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”.
L’affermazione della Carta
costituzionale del principio sancisce l’esclusione della coazione in tema di
trattamenti sanitari (e quindi della necessità del consenso del malato) ha come
necessaria consecuzione il riconoscimento anche della facoltà di rifiutare le
cure o di interromperle, che, a sua volta, non può voler significare
l’implicito riconoscimento di un diritto al suicidio, bensì soltanto
l’inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del
soggetto. Infatti la salute dei cittadini non può
essere oggetto di imposizione da parte dello Stato, tranne nei casi in cui
l’imposizione del trattamento sanitario è determinato per legge, come sostiene
anche la dottrina, in conseguenza della coincidenza tra la salvaguardia della
salute collettiva e della salute individuale, come avviene, ad esempio, nel
caso delle vaccinazioni obbligatorie.
Il diritto al rifiuto dei]
trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art.
2 Cost,, e si collega strettamente al principio di
libertà di autodeterminarsi riconosciuto all’individuo dall’art. 13 Cost.
Esso risulta inoltre confermato,
nella sua portata di diritto della persona, anche a livello intemazionale nella
convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, ratificata con
legge 28-3-01, n. 145, che all’art. 5 prevede che «un
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la
persona interessata abbia dato consenso libero ed informato. La persona
interessata può, m qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio
consenso». Di tale convenzione, seppure non sia ancora in vigore nel nostro
ordinamento per non essere stata perfezionata la relativa procedura
internazionale di notificazione della ratifica, non può non tenersi conto,
anche oggi, almeno come criterio di interpretazione per il Giudice. Ciò per due
ordini di motivi: il primo, perché è stata sottoscritta dall’Italia ed anche
ratificata con legge dello Stato; il secondo, perché essa enuncia principi
conformi alla nostra Costituzione, rappresentando una chiara esemplificazione
di quest’ultima.
La Corte Costituzionale
nei suoi interventi ha chiarito al riguardo la natura,
i contenuti e l’efficacia del diritto in argomento. In particolare:
– con sentenza n, 45/65 ha
affermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che «i
principi fondamentali di libertà», tra cui rientra a pieno titolo quello
sancito dall’art. 32, comma 2, Cost., debbono «essere immediatamente immessi
nell’ordinamento giuridico con efficacia erga omnes»;
– con sent. n.
161/85 ha ritenuto che l’intervento chirurgico di disposizione del proprio
corpo, se effettuato in conformità al diritto alla salute, enunciato dall’art.
32, Cost., intesa quest’ultima come equilibrio tra gli aspetti fisici e
psichici della persona, è consentito, prevalendo il suindicato articolo della
Costituzione sul divieto di cui all’art. 5 c.c.;
– con sent. n.
471/90 riconosce esplicitamente che la possibilità di disporre del proprio
corpo costituisce un necessario postulato “della libertà personale
inviolabile”, di cui parla la
Costituzione all’art. 13;
– con sent. n.
238/96, infine, ha escluso categoricamente che una persona possa essere
costretta a subire un intervento sanitario non voluto, in assenza di una norma
che esplicitamente lo imponga, affermando che esso costituisce “diritto
inviolabile rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo \
essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto
alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice
prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto della persona”.
La Corte Costituzionale
risponde, quindi, a tutti i questiti che l’interprete potrebbe porti nel caso
in esame, in quanto chiarisce che il diritto al rifiuto di trattamenti
terapeutici è un diritto inviolabile della persona, immediatamente precettivo
ed efficace nell’ambito del nostro ordinamento, non limitato dalla previsione
dell’art. 5 c.c., e soprattutto rientrante “ tra i
valori supremi” che l’ordinamento giuridico tutela a favore dell’individuo, non
diversamente dal diritto alla vita con il quale concorre “a costituire la
matrice prima di ogni altro diritto» della persona. Di conseguenza la Corte ha anche chiarito la scala
di priorità per T armonizzazione di un tale diritto con altri diritti, tra cui
anche quello alla vita, nei confronti del quale non ha e non deve avere,
nell’interpretazione del Giudice, una posizione subordinata.
In conclusione il quadro
normativo delineato dalla Corte Costituzionale nel corso degli anni non lascia
dubbi all’interprete, in quanto da esso discende con
chiarezza che l’individuo può rifiutare trattamenti medici e la sua volontà
consapevole deve essere] rispettata anche quando il rifiuto riguardi terapie
salvavita e tutto ciò vale don solo nel rapporto tra Stato e cittadini, ma
anche tra privati ovvero tra il paziente ed il uso medico, che dovrà attenersi
alla volontà del malato come regola generale.
Sulla stessa linea interpretativa
si impone anche la Corte
di Cassazione, che ha elaborato nel corso degli anni una giurisprudenza di
apertura alle predette problematiche, riconoscendo, ad esempio, nella sentenza
29.5.02, Volterrani, n. 26446 «che in una società ispirata al rispetto ed alla
tutela della persona umana, portatrice di un patrimonio culturale e spirituale
prezioso per l’intera collettività, non possa non darsi assoluta prevalenza al
valore sociale dell’individuo» e ritenendo che devono essere posti al centro
della tutela giuridica i suoi diritti fondamentali, tra cui anche quello
promanante dal secondo comma dell’art. 32, Cost. in ragione del quale la Corte afferma l’assoluta
«rilevanza della volontà del paziente quando si
manifesti in forma inequivocabilmente negativa e si concreti in un rifiuto del
trattamento terapeutico prospettatogli» ed in questo caso, pertanto, il medico
<<in presenza di una determinazione autentica e genuina non può che
fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il
pericolo di un aggravamento della stato di salute dell’infermo e, persino, la
sua morte.,,,giacché per il medico, di fronte ad un comportamento nel quale si
manifesta l’esercizio di un vero e proprio diritto, la sua astensione da
qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo diversamente
configurarsi a suo carico persino gli estremi di reato» ( conformi: Cass,
93.01, Barese, n. 585; \Cass. 223.01, n. 731 ). Nella medesima sentenza la Corte escludeva, invece, per
ogni intervento terapeutico la necessità dell’acquisizione del coosenso del
paziente, in quanto in caso di presenza della volontà positiva dell’infermo il
medico è tenuto ad ottemperare all’indicazione del paziente, mentre nel caso in
cui non sia stato espresso alcun consenso il medico sarà
legittimato a sottoporre il paziente al trattamento terapeutico che egli
giudicherà necessario per la salvaguardia della salute dello stesso.
In altra più recente sentenza la Corte di legittimità, (
Cass. 19.5,04, Verzè, n. 14638/04 ) invece estende la prevalenza assoluta della
volontà del titolare del diritto anche al caso di volontà positiva, che deve
sempre essere acquisita preventivamente dal medico, informando il paziente e
stimolandone le relative decisioni. In tale sentenza si
afferma il primato assoluto della volontà del paziente non solo in caso di
rifiuto o di interruzione della terapia, come avvenuto nella fattispecie in
esame, ma anche per qualsiasi intervento sanitario del medico, argomentando
che, indipendentemente dalla mancata esecuzione delle disposizioni della
Convenzione di Oviedo nel nostro ordinamento per incompletezza della relativa
procedura di ratificazione, tale principio discende inequivocabilmente
dall’art. 32, comma 2, della Costituzione ( conformi: Cass. 25.11.94, n. 10014;
Cass. ^4.9.97, n, 9374; Cass. 15,1.97, n. 364; Cass. 16.5.00, n. 6318).
Appare, quindi, evidente come,
alla luce del dettato chiarissimo dell’art. 32,. comma 2, della Costituzione, nonché alla luce
dell’interpretazione che di esso è stata data dalla giurisprudenza
costituzionale e di legittimità, non possano, in nessuna sede, essere I
disattesi il riconoscimento e la tutela del diritto air autodeterminazione
della persona in materia di trattamento sanitario, diritto che contempla
ovviamente anche il caso di rifiuto di nuova terapia e lo speculare caso di
interruzione della terapia già iniziata. Infatti il
diritto soggettivo riconosciuto dalla norma costituzionale nasce già perfetto,
non necessitando di alcuna disposizione attuativa di normazione secondaria,
sostanziandosi in una pretesa di astensione, ma anche di intervento se ciò che
viene richiesto è l’interruzione di una terapia, da parte di terzi qualificati
in ragione della loro professione. Per escludete invece un trattamento
sanitario che si sostanzi in un cotenimento fisico dell’individuo soccorrerà,
con conseguente duplice garanzia costituzionale, anche la disciplina assicurata
dall’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale
dell’individuo contro ogni forma di coazione fisica.
Tutto ciò certamente non potrà
essere vanificato dalla sistematica applicazione della scriminante di cui
all’art, 54, c.p.., che potrà essere operativa, ma
solo laddove non sia stata espressa alcuna volontà da parte del paziente oppure
nel caso in cui il consenso, il rifiuto o la richiesta di interruzione di una
terapia non siano stati esercitati liberamente ed alla presenza di una adeguata
informazione, o che non abbiano le qualità della personalità, attualità,
autenticità e della attinenza alla realtà.
In realtà in un tale scenario
giuridico, proprio perché c’è assenza di una legge specifica che regolamenti la
materia, eventualmente imponendo in alcuni casi il trattamento obbligatorio
all’individuo che lo rifiuti, il diniego di sottoporsi a cure o la loro
interruzione rappresenta una facoltà riconosciuta all’individuo che non può
essere negata o ostacolata, sempre che sia stato preventivamente accertato che
la volontà del soggetto sia stata espressa liberamente e con piena
informazione. Alla luce di ciò appare, quindi, essere un falso problema quello
attinente al bilanciamento del principio della libera autodeterminazione in
materia di trattamento terapeutico con gli altri principi di rango
costituzionale, come, ad esempio, quello alla vita od all’integrità fisica.
Pertanto, in caso di conflitto,
il sistematico depotenziamento del primo in ragione della prevalenza del
diritto alla vita non sarebbe giustificato da alcuna norma o principio neanche
di rango costituzionale. Ma, se tali diritti, quello alla vita e quello alla
autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, contribuiscono,
entrambi e ognuno per la sua parte, a costituire il nucleo fondamentale dei
diritti della persona che il nostro ordinamento riconosce e tutela, nel caso in
cui tra loro entrino in collisione (apparente, secondo questo Giudice), quale
dei due deve risultare prevalente, insomma verso quale soluzione porterebbe il
relativo bilanciamento?
Partendo dal diritto alla vita,
per essere già stato lungamente sviscerato quello all’autodeterminazione
terapeutica, va detto che, pur non essendo esplicitamente enunciato nella
Costituzione, nessuno è mai stato in grado di non ritenerlo alla base di qualsiasi
disposizione costituzionale in materia di diritti della persona. Ciò non solo
per una sua presunta derivazione giusnaturalistica, ma perché esso costituisce,
insieme al diritto di cui all’art. 32, comma 2, Cost,,
effettivamente il nucleo fondamentale cui si richiama ogni altro diritto
riconosciuto alla persona. Vengono comunemente
attribuiti al diritto alla vita i caratteri dell’inviolabilità e
dell’indisponibilità, ma il primo lo connota nel senso di limite verso Testerò,
il secondo come limite verso l’interno. Ovvero l’inviolabilità costituisce
quella tenace difesa che l’ordinamento pone all’aggressione del diritto che
possa provenire da persone diverse dallo stesse
titolare -vengono, pertanto, sanzionate tutte le forme di soppressione della
persona da parte di terzi nell’intera gamma contemplata negli articoli dal 575
al 580 del codice penale-; l’indisponibilità, invece, rappresenta quella difesa
avanzata che l’ordinamento appronta anche contro lo stesso titolare del bene
protetto.
Entrambi i caratteri hanno
comunque come limite invalicabile l’autonomo ed equipollente diritto di
autodeterminazione in materia di trattamento sanitario. In altre parole, se la
disposizione del proprio corpo, finanche a determinare la propria morte, viene effettuata nell’ambito dell’esercizio del diritto di
cui all’art. 32, comma 2, Cost., allora questa è consentita, proprio in
ossequio a quest’ultima previsione costituzionale che attribuisce tale facoltà
alla persona, salvo che non sia diversamente stabilito con legge ordinaria. In
sostanza l’esercizio di un tale diritto da parte del titolare ha, per espressa
e insuperabile previsione costituzionale, come suo unico limite quello
specificamente contemplato da una norma di legge. Pertanto, la norma
costituzionale, ponendo una stretta riserva di leege all’individuazione dei
limiti da apporre al libero dispiegarsi del diritto di autodeterminazione in
materia sanitaria, ha tracciato espressamente un’unica strada entro la quale
solo il legislatore ordinario potrà bilanciare i diritti ed i diversi interessi
in gioco, dettando le regole necessarie ed i confini al libero esercizio delle
facoltà riconosciute alla persona, come peraltro ha già coerentemente fatio nel
caso della previsione del ricovero obbligatorio nell’ipotesi di incapacità di
intendere e di volere, con una specifica previsione di legge.
Non rientra nella riserva di
legge di cui sopra, invece, la disposizione contenuta nell’art. 5 c.c., m quanto essa non disciplina i casi specifici di deroga
al libero dispiegarsi della volontà dell’individuo in tema di terapie, ma si
limita a prevedere un divieto di disposizione del proprio corpo di carattere
generale che, proprio in quanto tale, non può non essere disatteso. Ciò in
considerazione della sua estraneità ad una regolamentazione specifica della
materia relativa al trattamento sanitario, trattandosi di norma che, se
letteralmente intesa, porrebbe nel nulla la norma costituzionale, non solo
nella sua accezione positiva di necessità del consenso ad interventi
terapeutici invasivi. D’altra parte ciò appare essere in linea con quanto
indicato nella pronuncia della Corte costituzionale sopra riportata, dove si
afferma la prevalenza del principio previsto dall’art. 32 Cost. sulla
disposizione contenuta dall’art. 5 c.c., (Sent. n. 161/85, Corte Cost.).
Da ciò consegue che anche la
difesa approntata dall’ordinamento all’inviolabilità della vita deve cedere di
fronte alla condotta del medico che possa metterla a rischio o addirittura
pregiudicarla, se tale condotta sia stata posta in essere in ossequio alla
volontà liberamente e consapevolmente espressa, sulle terapie cui sottoporsi o
non sottoporsi, dallo stesso titolare del bene protetto.
E’ importante, a questo punto,
definire con rigore l’ambito entro il quale può essere esercitato il diritto di
autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, perché direttamente
incidente sui principi della inviolabilità e dell’indisponibilità della vita e
perchè qualsiasi scantonamento si tradurrebbe in una gravissima violazione in
ragione dell’essenzialità del diritto su cui andrebbe
ad
incidere. Infatti l’individuo nell’esercizio del
diritto di autodeterminazione terapeutica potrebbe autorizzare anche condotte
direttamente causative della sua morte.
L’ambito entro il quale
l’individuo può autorizzare anche condotte direttamente causative della sua
morte viene stabilito chiaramente dallo stesso
legislatore costituzionale, quando afferma che «nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario». Pertanto, tutto ciò che discende da tale
principio in termini di necessario consenso o di possibile dissenso deve essere
esercitato con riferimento ad un «trattamento sanitario», ovvero l’adesione o
il rifiuto può riguardare solo una condotta che ha come contenuto
competenze di carattere medico e che può essere posta in essere
unicamente da un soggetto professionalmente qualificato, come è, appunto, il
medico, e sempre all’interno di un rapporto di natura contrattuale a contenuto
sanitario instaurato tra quest’ultimo ed il paziente.
Pertanto rientrerà, ad esempio,
nella previsione dell’art. 32, comma 2, Cost. l’ipotesi, volendo rimanere in
tema, del distacco dal respiratore artificiale effettuato da un medico e non da
un familiare o da un altro soggetto, poiché l’interruzione di una terapia, consentita
dalla norma costituzionale, è quella che si pone all’interno di un rapporto
terapeutico o comunque in stretta relazione con un trattamento sanitario. In
ragione di ciò, gli attori del rapporto terapeutico instaurato sono, quindi,
unicamente il medico ed il paziente. D’altra parte la lettera della norma è
chiara “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario”,
alla luce della quale l’esclusione dell’imposizione terapeutica ha come unici
luoghi di estrinsecazione:
1) il rapporto tra lo Stato e la
persona – basti pensare, ad esempio, a sperimantazioni, castrazioni e
vaccinazioni obbligatorie, che il legislatore costituzionale vuole così
scongiurare del tutto o ammettere solo per esplicita previsione di legge;
2) il solo rapporto terapeutico
instaurabile tra privati, ovvero quello tra l’operatore sanitario ed il suo
paziente, del quale essi rimangono gli unici attori a partire dal momento
iniziale, quando per l’attivazione della terapia il medico ha bisogno del
consenso del paziente e, fino alla conclusione, quando per l’interruzione del
trattamento il paziente ha come suo unico interlocutore il medico, che ha il
dovere di far cessare il trattamento sanitario non voluto.
In conclusione, tra privati,
l’unico possibile scenario all’interno del quale può esercitarsi il dirimo di
autodeterminazione della persona in materia di trattamento sanitario, in tutte
le sue diverse manifestazioni, è il rapporto instaurato tra il paziente ed il
suo medico e che ha come contenuto delle prestazioni sanitarie. (Ciò trova speculare corrispondenza con i doveri che
incombono sul medico in ragione della sua professione, come meglio specificato
nello stesso codice deontologico, in quanto egli nell’esercizio di quest’ultima
deve improntare la sua azione al rispetto del principio della salvaguardia
della vita del paziente, del quale dovrà sempre acquisire il consenso,
sopperendo solo in sua mancanza con interventi di necessità ex art. 54, c.p., (
v, Cass. sopra citata), e del quale dovrà rispettare, ovviamente, anche la
volontà di dissenso, che potrà consistere in up rifiuto di trattamenti o in una
richiesta di interruzione della terapia precedentemente avviata.
E’ evidente, pertanto, che solo
su tale soggetto, qualificato in ragione della sua professione, e non su altri
incomberà un dovere di osservare la volontà di segno negativo del paziente, in
ragione del rapporto instauratosi, che pone in relazione i due per
l’espletamento di una condotta di natura sanitaria a contenuto concordato, con
la conseguenza che, se egli dovesse porre in essere una condotta direttamente
causativa della morte del paziente per espressa volontà di quest’ultimo,
risponderà ad un preciso dovere che discende dalla previsione dell’art. 32,
comma 2, Cost., mentre la stessa condotta posta in
essere da ogni altro soggetto non risponderà ad alcun dovere giuridicamente
riconosciuto dall’ordinamento, non essendo stata esercitata all’interno di un
rapporto terapeutico, nei quale solo quale nascono e si esercitano diritti e
doveri specifici, tra cui quelli di cui si discute.
D’altra parte non sfugge l’importante ruolo che al riguardo è in grado di svolgere il
medico il quale, solidamente sorretto da valutazioni di carattere sanitario,
nonché orientato dal proprio codice di deontologia professionale e vincolato
allo stesso, è l’unico a poter garantire, da un punto di vista tecnico e da un
punto di vista dell’osservanza dei principi e dei diritti, il rispetto nel caso
concreto dei confini tra l’esercizio di una libera ed informata
autodeterminazione del paziente ed arbitrii forieri di violazioni di diritti
essenziali, quali quelli in gioco. Inoltre la sua figura è fondamentale nella
costituzione del presupposto per l’esercizio del diritto, incidendo egli
direttamente sul processo di formazione della volontà del paziente attraverso
l’informazione di quest’ultimo. Di conseguenza non è possibile prescindere
dalla sua figura nel concreto dispiegarsi del consenso o del dissenso informato
del paziente.
È evidente che il rifiuto delle
terapie rappresenta nell’esperienza comune, soprattutto se causativo della
morte, un fatto eccezionale, in quanto è ben radicato nell’uomo l’istinto di
conservazione e che in ogni caso la relativa manifestazione di volontà per
essere valida deve possedere una serie di requisiti non sempre presenti,
soprattutto nelle persone che si trovino a fruire di
terapie salvavita e quindi in condizioni estreme. Tali requisiti si evincono,
secondo la giurisprudenza e la dottrina, dalla Costituzione e dai principi
dell’ordinamento giuridico e sono identificabili nel fatto che il rifiuto di
una terapia o il rifiuto di continuarla deve innanzitutto essere personale,
ovvero deve promanare dal titolare stesso del diritto alla vita che potrebbe
essere pregiudicata o che sarà pregiudicata, in quanto a nessuno è consentito
decidere della vita altrui senza incorrere nei divieti della legge anche
penale. Pertanto, non potranno esercitare tale diritto per conto del malato il
rappresentante legale del minore o dell’infermo di mente, in quanto egli ha
titolo solo per effettuare interventi a favore e non in pregiudizio della vita
del rappresentato, né hanno giuridicamente potere di rappresentanza in materia
i familiari dell’interessato. Altro requisito del consenso o del dispenso è che
per essere valido deve essere consapevole ovvero informato, incidendo esso su
diritti essenziali dell’individuo. Infatti, quest’ultimo ne può disporre solo
se pienamente consapevole ovvero informato, incidendo esso su diritti
essenziali dell’individuo. Infatti, quest’ultimo ne può disporre solo se
pienamente consapevole della sua condizione psico-fisica, delle prospettive
evolutive della sua condizione e delle conseguenze che possono scaturire dalle
sue scelte, purché altrimenti la sua volontà sarebbe viziata da elementi di
conoscenza distorti o mancanti e quindi non libera. Inoltre, il rifiuto deve
essere autentico ovvero non apparente, non condizionato da motivi irrazionali,
ad esempio la paura, deve essere effettivamente attribuibile alla volontà del
soggetto e quindi non frutto di costruzione o di suggestione di alcun tipo
esercitata da terzi, nonché deve essere strettamente collegato a concrete
situazioni personali del malato, ad esempio la sofferenza causata dal male o
l’incurabilità della malattia, ecc, e non legato a superstizioni, pregiudizi o
altro. È necessario, altresì, che il rifiuto sia reale e, segnatamente, sia
compiutamente e chiaramente espresso e non sia semplicemente desumibile dalla condizioni di sofferenza o dalla gravità del male.
Altro importante requisito allo stato della legislazione, è costituito
dall’attualità del rifiuto, non essendo sufficiente che la persona abbia
espresso precedentemente la sua volontà in tal senso, in quanto, attesi
l’essenzialità dei diritti sui quali è destinato ad incidere ed il collegamento
di tali decisioni a condizioni, anche interiori, mutevoli, il rifiuto di una
terapia salvavita può essere revocato in qualsiasi momento e quindi deve
persistere nel momento in cui il medico si accinge ad attuare la volontà del
malato (giurisprudenza: Cass., 29.5.01, Volterrani, n.
26446; dottrina; Mantovani, Criminalia, 2006; Santuosso-Fiecconi, La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2005).
A questo punto, chiarito lo
scenario giuridico entro il quale si colloca il caso in esame, si deve necessariamente
procedere all’esame dei fatti oggetto del presente giudizio, valutando se la
condotta dell’imputato, eziologicamente determinante, come concausa, nel
decesso del paziente, che, senza l’ausilio del macchinario e a causa della sua
malattia, cessava di respirare, sia penalmente rilevante o meno.
Certamente la condotta posta in
essere dall’imputato integra l’elemento materiale del reato di omicidio del
consenziente, in quanto, oltre all’effettiva sussistenza del dato estrinseco
del consenso della vittima, il distacco di quest’ultima dal respiratore
artificiale effettuato dal predetto determinava il suo decesso dopo poco.
Né vale a tal riguardo sostenere
che, invece, il medico si limitava a non proseguire la terapia in ottemperanza
della volontà espressa dal paziente, ponendo in essere una condotta
semplicemente omissiva, poiché tale interpretazione, che giudice alle stesse
conclusioni circa la liceità della condotta seppure per una strada diversa e
con qualificazione diversa del relativo proscioglimento, appare essere il
risultato di una costruzione giuridica che finisce per forzare la realtà dei
fatti. E’, invece, ravvisabile nell’atto del distacco del respiratore una innegabile condotta interventista, che non può essere
assimilata, e non solo dal punto di vista naturalistico, alla condotta, essa
si, omissiva del medico che si limiti a non iniziare una terapia non voluta dal
paziente. Ciò è tanto vero che se si volesse
criminalizzare quest’ultimo comportamento, nonostante la sussistenza della
dichiarazione conforme del malato, si dovrebbe individuare una fattispecie
penale diversa dall’omicidio del consenziente, come, ad esempio, quella
dell’omissione dì atti d’ufficio per ragioni di sanità e, nel caso di morte del
paziente, quella di cui all’art, 586, c.p., con disparità di trattamento
concettualmente non giustificabile. Seguendo una tale interpretazione sii
avrebbe inoltre, specularmente, un’ingiustificabile diversità di trattamento
anche con riferimento alla condotta antagonista a quest’ultima ipotesi, consistente
nell’imposizione di una terapia non voluta, che sarebbe, secondo la Code
di Cassazione, perseguibile penalmente per il reato di violenza privata ( v.
Cass. 29.5.02, Volterrani, n, 26446), diversamente dalla condotta antagonista
al caso in esame e consistente nel rifiuto di staccare il respiratore
artificiale. Parimenti non vale a tal riguardo affermare, altresì, che
l’imputato, dopo avere omesso di proseguire una terapia non voluta,
semplicemente non impediva che il paziente morisse a causa della sua malattia,
come se il decesso del malato non fosse poi la conseguenza immediata della
condotta commissiva del medico. Infatti tale
interpretazione appare corrispondere più ad un artificio logico che alla realtà
dei fatti, con riferimento ai quali nessuno è in grado di smentire il dato
obiettivo che, se l’imputato non fosse intervenuto attivamente, staccando il
malato dalla macchina che gli assicurava la respirazione assistita,
quest’ultimo non sarebbe deceduto quel giorno e a quell’ora. Pertanto, non vi è
dubbio che all’azione dell’imputato, unitariamente consistita nell’atto di
distacco del respiratore, corrispondeva come evento
naturalisticamente e giuridicamente conseguente la morte del paziente, dato,
questo, dal quale non è possibile prescindere nella presente valutazione,
separando artificiosamente in due distinte fasi -omissione del trattamento e
non intervento in soccorso del malato- la condotta del medico che è unica, sia
da un punto di vista della materialità che da un punto di vista della volizione.
D’altra parte l’individuazione di una causa di giustificazione del reato non
appare foriera, più in generale, di conseguenze negative quali, ad esempio, la
possibilità di un pericoloso ampliamento della liceità della condotta sotto il
profilo dell’erronea supposizione della scriminante, poiché sempre dell’oggetto
del dolo si discuterebbe e, come tale, sovrapponibile all’analogo caso di
erronea supposizione degli elementi del fatto di cui all’art. 47, c.p.. Anzi nel caso dell’erronea supposizionje di un causa di
giustificazione la giurisprudenza ha avuto sempre una posi:|:ione più rigorosa,
richiedendo qualcosa di più del semplice difetto dell’elemento psicologico e
segnatamente ha ritenuto necessario accertare anche la ragionevolezza di questo
erroneo convincimento ( Cass. 24,5.90, Colantonio; cass. 7.7.98, Calamita;
ecc.).
Del reato contestato sussiste
anche l’elemento psicologico, poiché il dottor Riccio ben sapeva che
pnterruzione della terapia di ventilazione assistita avrebbe comportato il
decesso del paziente ed il fatto che egli abbia adempiuto
alla volontà del paziente non esclude di per sé la volontarietà della
sua azione direttamente causativa del decesso di quest’ultimo, in quanto è
proprio la volontà conforme della vittima a costituire l’elemento
caratterizzante la fattispecie dell’ornici dio^ìpr^onsenziente rispetto
all’omicidio volontario."Non si può neppure affermare che il dottor Riccio
non fosse in grado di ipotizzare l’antigiuridicità
della sua condotta, se è vero, come è vero, che era a conoscenza della
pronuncia del Giudice civile di qualche giorno prima.
Pertanto, l’unica soluzione
perché la condotta del medico, attuativa della volontà del paziente e causativa
della morte di quest’ultimo, possa essere ritenuta di per sé lecita, sarebbe
quella di ridisegnare, mediante l’intervento del legislatore, i limiti della
fattispecie di cui all’art. 579, c.p., escludendo
esplicitamente l’ipotesi del medico che, ottemperando la volontà del paziente,
cagioni la morte di quest’ultimo, mentre una previsione incriminatrice così
ampia ingloba necessariamente anche questo caso.
Peraltro, se è vero che esistono
del reato contestato tutti gli elementi costituivi, nel caso concreto appare
sussistere anche la scriminante di cui all’art. 51 c.p. Invero dalla ricostruzione
dei fatti precedentemente operata discende con certezza che Piergiorgio Welby
da tempo, almeno da sei mesi, aveva deciso di porre fine alla terapia di
ventilazione assistita cui era sottoposto dal 1997 e a tale scopo aveva
perseguito tutte le strade possibili, anche rivolgendosi al Giudice civile, per
poter vedere riconosciuto il proprio diritto all’interruzione del trattamento
sanitario. Vari medici per motivi diversi si erano rifiutati di assecondare la
sua volontà, fino a che era entrato in contatto con il dottor Riccio, medico
specializzato in anestesia e rianimazione. Il rapporto che si costituiva tra i
due è qualificabile come quello tipico che si instaura tra un medico ed il suo
paziente, preceduto da una precisa acquisizione di informazioni da parte del
medico sulle condizioni del paziente ed esso aveva ad oggetto
competenze di carattere squisitamente sanitario, quali quella di porre
fine al trattamento di respirazione assistita con il distacco del predetto
dalla macchina e quella di somministrare contestualmente una terapia sedativa
al paziente. Il contesto entro il quale, pertanto, si consumava la condotta
dell’imputato era quello presupposto dal legislatore costituzionale per il
legittimo esercizio del diritto all’autodeterminazione della persona attraverso
la richiesta di interruzione del trattamento sanitario. A sostegno di tale
affermazione si rimanda anche alle valutazioni critiche espresse
precedentemente da questo Giudice sulle argomentazioni contenute nell’ordinanza
del GIP. Si ritiene di dover solo aggiungere che il medico] nel caso in esame,
interveniva su un trattamento sanitario a quell’epoca in atto, quale quello
della respirazione assistita, operando per la sua cessazione e somministrando
contestualmente una terapia sedativa, come richiesto dal paziente, per
salvaguardare Tequilibrio psico-fisico di quest’ultimo nel momento assai
critico del suo percorso finale ovvero ponendo in essere una condotta a
contenuto specificamente medico ed attuabile, nel suo complesso, solo da uno
specialista in anestesia, come ebbe ad affermare essere necessario anche il
medico curante della vittima, dottor Sciarra.
Inoltre va detto che la richiesta
di interruzione della terapia formulata da Piergiorgio Welby aveva tutti i
requisiti di validità in precedenza evidenziati ovvero era personale,
autentica, informata, reale ed attuale, infatti sono
riscontrabili nella decisione del malato la piena consapevolezza e la
determinazione tenuta fino all’ultimo. A tal riguardo valgono le riflessioni
dello stesso Welby precedentemente riportate e contenute nei suoi scritti, che
in ragione del loro stesso contenuto rivelano l’esistenza e l’autenticità di
tali condizioni. A conferma di ciò appaiono importanti le dichiarazioni della
moglie nel corso dell’audizione davanti a questo Giudice. Ella infatti, in quella sede chiariva che il marito aveva sempre
scritto personalmente tutto, “aveva una tastierina virtuale dove poteva muovere
con il dito il cursore” ed è pertanto chiaro che il contenuto degli scritti del
predetto sia attribuibile solo a quest’ultimo e sia frutto, quindi, di sue
personali e sofferte riflessioni, nonché di decisioni prese in totale
autonomia. La moglie riferiva, inoltre, che fin dall’inizio del loro rapporto
egli la volle informare della sua malattia, dei sintomi e dell’esito infausto
che la stessa avrebbe potuto avere anche a breve termine; le aveva, infatti,
detto : <<io dovrei essere già morto perché mi
avevano detto all’inizio che non sarei arrivato ai venti anni e invece sono
ancora qui… io morirò di una morte orribile per soffocamento perché i muscoli
piano piano si disfano e la mia fine sarà quella di non poter più respirare».
Egli, inoltre, su tutto ciò cne
riguardava la sua malattia decideva e si informava sempre in piena autonomia,
mai delegando alcuno, neppure la moglie, che alle specifiche domande del
Giudice descriveva l’atteggiamento del marito rispetto alla malattia, chiarendo
che «non ha mai delegato nessuno, nemmeno me, anzi se
io qualche volta lo prevenivo chiedendo al medico di venire a casa, dovevamo
litigare e io non lo feci mai più, insomma ho fatto sempre chiedere a lui
oppure lo consigliavo, -senti sarebbe il caso…,-. Se lui diceva di no, non
chiamavo il medico. Era una persona troppo intelligente, libera e autonoma».
Piergiorgio Welby inoltre si è
sempre tenuto aggiornato sull’evoluzione della malattia, si informava anche
costantemente sulle evoluzioni della scienza in materia (v. pg 17 e seg., libro “Lasciatemi morire”) e ha sempre deciso
personalmente come gestire la malattia. Anche il semplice chiamare o non
chiamare il medico era, infatti, oggetto di una sua decisione personalissima.
Anche quando si arriv|) nel 1997 alla decisione sulla
tracheotomizzazione, fu lui a decidere, seppure egli si risentì a lungo per
l’atteggiamento della moglie, che, in un momento cosi difficile per lui, non lo
aveva sostenuto nella decisione di lasciare andare avanti la malattia senza
interventi cosi invasivi, attribuendo sul punto alla congiunta un ruolo
decisionale, che poi lei in realtà non ebbe, come evincibile dalla
testimonianza di quest’ultima In conclusione, appare evidente come Piergiorgio
Welby^ia^tato sempre informato su tutto ciò che riguardava la sua malattia,
decidendo in relazione ad essa in maniera totalmente autonoma ed ancorata alla
realtà delle sue condizioni. Questa consapevolezza e questa volontà di autonoma
determinazione sono rimaste presenti nel predetto fino all’ultimo, come
evincibile da quanto sopra descritto, poiché egli fino alll’ultimo istante, non
solo ha mantenuto intatte le sue facoltà mentali, cosa del tutto compatibile
con la patologia sofferta che non pregiudica le capacità intellettive del
malato, ma è stato in grado nonostante lo stadio gravissimo di atonia in cui
versava e la sofferenza fisica e psichica da lui sopportata nell’ultimo
periodo, di autodeterminarsi con lucida coerenza e ammirevole fermezza. Ciò è
dimostrato dal fatto che non si è lasciato scoraggiare dagli ostacoli di ogni
tipo, frapposti tra la sua decisione e l’attuazione delle sue volontà, ciò
anche nell’ultimissimo periodo. Infatti, quando i suoi amici dell’associazione
"Luca Coscioni", in particolare i parlamentari don i quali da tempo
aveva condiviso alcune battaglie su tali temi, chiesero al medesimo di rinviare
la sua decisione di interrompere la terapia di ventilazione polmonare a dopo le
festività natalizie per dare ulteriore tempo al dibattito politico sul testo
legislativo relativo al cosiddetto "testamento/ biologico", egli,
arrivato allo stremo, si rifiutò di assecondare i tempi e le ragioni della
politica, separando a quel punto la sua vicenda personale da ogni valenza
esteriore e mediatica e riappropriandosi della dimensione personalissima del
dolore e della sua dignità di uomo. Decise, infatti, di interrompere la
terapia, stabilendo lui i tempi e le modalità della sua morte ovvero il giorno
in cui morire, cosa fare fino al momento prima, chi volere accanto a sé, con
quale musica accompagnare il suo distacco dal mondo. Fino all’ultimo, non solo
l’imputato, ma anche la moglie gli chiese se
effettivamente fosse determinato ad andare avanti nella sua decisione e lui, in
piena consapevolezza, rispose affermativamente non solo con cenni, ma con frasi
di senso compiuto ed univoco, e pregò la moglie di non piangere per
accompagnarlo serenamente in quell’ultimo percorso. Al riguardo ci sono le
testimonianze della moglie e dell’on. Cappato, i quali, tra l’altro, firmarono
in segno di conferma, unitamente alla sorella ed all’on. Marco Pannella, il
verbale redatto dal dott. Riccio, nel quale si dava atto, tra l’altro, del
consenso al distacco dal ventilatore mantenuto fino all’ultimo da Piergiorgio
Welby. Erano inoltre presenti al commiato altre persone, tra cui la stessa
madre, che in quell’occasione, pur nell’ovvio dolore per l’imminente dipartita
del figlio, si mostrò serenamente sollevata per il fatto che finalmente si
desse attuazione alla sofferta volontà del congiunto.
Certo, ciò che sorprende è come
l’eccezionalità dell’esperienza della morte sia stata poi vissuta da
Piergiorgio Welby in concreto con modalità di assoluta quotidianità e
semplicità, come di un momento apparentemente uguale a tanti altri: egli ha infatti voluto seguire fino a pochi attimi prima un
programma televisivo di giochi a premi, quasi a voler sdrammatizzare ciò che
nell’immaginario individuale e collettivo concentra su di sé, più di ogni altra
esperienza umana, sentimenti di paura, quasi a voler ricondurre tale esperienza
nell’alveo di quello che poi essa è, ovvero un evento naturale dell’esistenza
umana- Ciò induce a pensare ad una sua condizione di grande serenità, come di
chi, fino a quel momento mai domato da ogni giro di vite che la malattia gli
aveva imposto, sia ormai profondamente consapevole di avere esaurito ogni
aspettativa di vita, di una vita che possa essere ancora chiamata tale e che
abbia conservato la dignità coessenziale alla qualità di uomo. Inoltre è da
ritenere che era presente in lui anche una grande e
serena determinazione, ancora più forte se raffrontata ad una prova così
difficile; determinazione, che è figlia necessariamente di un vissuto pieno,
come d’altra parte dimostrano i suoi scritti, che è figlia di una lucida
consapevolezza del presente e del passo che sta per affrontare, come in
precedenza chiarito, e che è figlia della sua tenace volontà di non voler
abbandonare SI ruolo di protagonista della propria vita, in quest’ultima
preservando dignità e qualità.
Sulla permanenza della volontà
del paziente fino all’ultimo, in particolare, va chiarito che il distacco dal
respiratore artificiale avveniva contestualmente alla somministrazione della
terapia sedativa, pertanto l’affievolimento della funzione respiratoria
avveniva di pari passo alla graduale perdita della coscienza da parte del
Welby. In ogni caso appare del tutto irrilevante, oltre che arduo dal punto di
vista probatorio, andare ad accertare se lo stato di coscienza del paziente sia cessato nel momento esatto in cui subentrava la morte
naturale per il distacco dalla macchina. In altre parole appare del tutto
irrilevante andare ad accertare concretamente se egli sia
stato messo nelle condizioni di poter, fino all’ultimo istante, revocare
la sua precedente decisione, poiché ciò sarebbe stato in totale contrasto con
l’intento coerentemente perseguito fino a quel momento e con la sua storia
personale ed in quanto tale accertamento "impossibile" appare, in
ogni caso, rappresentare esso stesso un’inutile forzatura. Infatti, non può che
costituire un inutile artificio voler far coincidere il requisito
dell’attualità della volontà con la necessaria e stretta contestualità tra la
morte e la perdita di coscienza della persona, soprattutto quando si rende
opportuno o necessario procedere alla sedazione del paziente. In realtà quello
che effettivamente rileva sotto tale profilo non è la stretta contestualità tra
la perdita di coscienza e la morte ma la prevedibilità dellì’intervento, ovvero
se il paziente permanga nella sua decisione, pur sapendo quello a cui sta andando incontro e sempre che quello che
effettivamente poi avviene è ciò che era stato previsto e che era comunque da
lui ragionevolmente prevedibile. Anche sotto tale profilo si può affermare con
ragionevole certezza che Piergiorgio Welby ha mantenuto ferma la sua decisione
funo alla perdita di coscienza avvenuta contestualmente o poco prima al suo
decesso, evento, quest’ultimo, che egli sapeva bene che sarebbe subentrato al
distacco dalla macchina. Assai significativo sotto il profilo della
prevedibilità appare, infatti, essere l’episodio raccontato dalla moglie, che
riferiva al Giudice che m domenica prima del decesso il marito aveva voluto
verificare entro quanto tempo approssimativamente sarebbe potuta subentrare la
morte ed aveva chiesto alla moglie di staccarlo dal respiratore artificiale,
constatando in quell’occasione la rapida discesa dei valori.
Si rinvengono pertanto nel caso
in esame tutti gli elementi in precedenza enucleati per la sussistenza della scriminante
di cui all’art. 51, c.p., con conseguente liceità
della condotta posta in essere dall’imputato.
In conclusione, parlare nel caso
di specie genericamente di eutanasia appare, quindi, del tutto fuorviante da un
punto di vista del rigore concettuale e della comprensione dei fatti. Basti,
infatti, riflettere sul fatto che per la qualificazione dei casi rientranti nel
concetto di eutanasia la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto coniare una
serie infinita di distinzioni che comunque non sono in grado di esaurire il
variegato scenario che offre la realtà e che comunque non consentono una reale
individuazione della specificità dei singoli casi. Si distingue al riguardo,
tanto per citare solo alcune delle catalogazioni più ricorrenti ed accreditate,
in eutanasia attiva non consensuale, eutanasia attiva consensuale, eutanasia
passiva, eutanasia pura, eutanasia pietosa, ecc». Ed è ancor più fuorviante
nella fattispecie in esame utilizzare una simile definizione, perché si rischia
di sovrapporre casi del tutto eterogenei con riferimento ad un tema che,
riguardando assai da vicino l’intangibilità della vita umana, per la sua
essenzialità e delicatezza impone un rigore assoluto ed una delimitazione delle
fattispecie quasi "chirurgica”, perché altrimenti si potrebbe correre il
rischio di non comprendere adeguatamente la specificità del caso in esame e si
potrebbe correre il rischio di estendere, in via di principio, a casi
ontologicamente diversi il riconoscimento costituzionale dell’esercito di un
diritto ed il riconoscimento speculare della sussistenza di un’esimente penale.
Basti pensare, ad esempio, alle peculiarità del caso apparentemente similare,
ma profondamente diverso, di colui che nelle medesime condizioni di Piergiogio
Welby si faccia staccare il respiratore da un congiunto.
Una tale interpretazione del
principio di autodeterminazione consapevole in tema di trattamento sanitario
non è senza effetti sulla categoria concettuale facente capo al cosiddetto
"accanimento terapeutico", in quanto in una visione sistematica
quest’ultima appare acquisire una connotazione di tipo residuale. In altre
parole, se viene riconosciuta efficacia giuridica alla
volontà dell’individuo sulle cure mediche cui sottoporsi, l’insistenza
terapeutica in questo caso deve essere qualificata dal punto di vista giuridico
come mera violazione della volontà consapevolmente espressa dal paziente,
indipendentemente dal fatto che il trattamento sanitario si sostanzi o meno in
una situazione definibile come "accanimento terapeutico”. D’altra parte la
terapia cui la persona intende sottrarsi non necessariamente si deve
sostanziare in una situazione estrema di "accanimento terapeutico"
perché egli possa esercitare il diritto di farla cessare.
Pertanto l’accanimento
terapeutico, come categoria giuridica, assumerebbe una connotazione autonoma
rispetto al diritto di autodeterminazione terapeutica ed un contenuto
residuale, nel senso che in esso potrebbe rientrare
tutto ciò che è insistenza terapeutica al di fuori del caso di consapevole
rifiuto espresso direttamente e nell’immediatezza dal destinatario delle cure,
come avveniva nel caso in esame. La categoria concettuale, rilevante sotto il
profilo giuridico e qualificabile come accanimento terapeutico, potrebbe,
infatti, riguardare i casi di terapia esercitata nei bonfronti di soggetti non
più in grado di decidere per sé, relativamente ai quali la malattia a prognosi
infausta è pervenuta alla fase terminale o nei quali li sia irreversibilità
della condizione di coma Infatti solo in questi casi il
titolarci del bene protetto si troverà nella condizione di non poter esprimere
la propria yolontà, che, se positiva, avrebbe potuto riconvertire il presunto
accanimento En terapia voluta e che, se negativa, ne avrebbe potuto lamentare
la violazione. Pertanto solo all’interno di tale categoria residuale poi si
dovrebbe porre la questione relativa all’ultrattività della volontà del
soggetto, non più in grado di esprimerla.
È evidente come, in ogni caso, al
di là di qualsiasi opportuna classificazione sistematica dell’accanimento
terapeutico, i fatti oggetto del presente procedimento sono del
tutto diversi da simili fattispecie.
Neppure sembra potersi fare
rientrare il caso in esame nella più ampia categoria concettuale denominata
“suicidio assistito”. Può infatti essere definita
condotta suicidaria quella di colui che, ormai consapevole della immediata
prossimità della propria morte e della sua inevitabilità alla stregua delle
conoscenze scientifiche, decida i tempi e le modalità del suo trapasso in modo
da consentire che esso sia privo di indicibili, quanto inutili, sofferenze? Noi
possiamo, infatti, solo immaginare cosa voglia dire morire per soffocamento,
quando al movimento meccanico involontario preposto all’inspirazione non
risponda l’acquisizione dell’aria necessaria. Piergiorgio Welby, invece,
l’aveva già sperimentato concretamente nel 1997 e lo stava rivivendo negli
ultimi tempi, quotidianamente, in quel progressivo esaurirsi della sua capacità
respiratoria nonostante l’assistenza meccanica del ventilatore polmonare: «Mina
quanto sto male, quanto sto male»
Può, infatti, essere definita
suicidio la condotta di colui che, ormai consapevole della immediata prossimità
e della inevitabilità della propria morte decida i
tempi e le modalità del suo trapasso in modo da consentire che il distacco dai
suoi cari avvenga nel modo più sereno, più partecipato, più vicendevolmente
compassionevole possibile? Peraltro tali riflessioni appartengono più al mondo
della morale che al mondo giuridico, mentre nell’ambito di quest’ultimo i
concetti che ci interessano assurgono, come dimostrato in precedenza, ad una
chiarezza insuperabile; la condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita
costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciutogli in ottemperanza
al divieto di trattamenti sanitari coatti sancito dalla Costituzione.
In conclusione, si può, quindi,
affermare che l’imputato Mario Riccio ha agito alla presenza di un dovere
giuridico che ne scimina l’illiceità della condotto
causativa della morte altrui e si può affermare che egli ha posto in essere
tale condotta dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che
hanno legittimato l’esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi
ad un trattamento sanitario non voluto.
Va pertanto dichiarato il
proscioglimento di Riccio Mario perché non punibile in ragione della
sussistenza della esimente di cui all’art. 51, c.p.
PQM
Visto l’art. 425 c.p.p. dichiara
non luogo a procedere nei confronti di Riccio Mario perché non punibile per la
sussistenza dell’esimente dell’adempimento di un dovere.