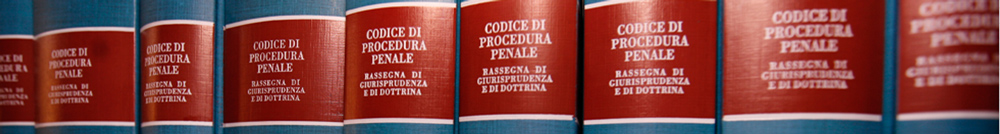Enti pubblici
La Corte Costituzionale impiega la metà del proprio tempo per dirimere i contrasti tra Stato e Regioni. Presidente Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, Relazione 2 aprile 2004
La Corte Costituzionale impiega la metà del proprio tempo per dirimere i contrasti tra Stato e Regioni
Presidente Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, Relazione 2 aprile 2004
La giustizia costituzionale nel 2003
Osservazioni generali
Nel corso del 2003 la Corte ha tenuto 39 adunanze, distribuite in 17 udienze pubbliche e 22 camere di consiglio. Ha emesso nel complesso 382 decisioni, 134 sentenze e 248 ordinanze (che rappresentano, rispettivamente, il 35% e il 65% del totale), definendo 609 giudizi.
La Corte ha operato nella sua composizione completa, costituita da 15 giudici.
In un solo caso (sentenza 116) si riscontra la mancata coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore della pronuncia.
Le decisioni hanno riguardato per il 65,18% giudizi in via incidentale, per il 14,92% giudizi in via principale, per il 6,02% conflitti tra Stato e regioni, per l’11,51% conflitti tra poteri dello Stato, per l’1,57% giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo. Tre ordinanze sono di correzione di errori materiali.
Lo spazio assunto dal giudizio principale risulta più evidente considerando esclusivamente il numero delle sentenze. Infatti, su un totale di 134 sentenze, il 40,29% è emesso nel giudizio incidentale, il 35,92% nel giudizio principale, il 13,43% nei conflitti tra Stato e regioni, il 5,22% nei conflitti tra poteri dello Stato, il 4,47% nel giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
Comparando questi dati con quelli degli ultimi anni risulta che, in un contesto caratterizzato dalla diminuzione del numero totale delle pronunce (erano state 471 nel 1999, 592 nel 2000, 447 nel 2001, 535 nel 2002), il rapporto tra ordinanze e sentenze, pur rimanendo in linea con la tendenza, presente fin dalla metà degli anni ‘90, alla progressiva riduzione del numero delle sentenze (nel triennio 1999-2001 le sentenze hanno costituito il 31,85% del totale delle decisioni, mentre nel 2002 sono state il 25,23%), vede una netta ripresa della percentuale delle sentenze, che non pare imputabile al giudizio incidentale (nel cui ambito le sentenze rappresentano nel 2003 il 21,68%, a fronte di una media del triennio 1999-2001 del 24,37% e del 20% nel 2002).
L’incremento percentuale delle sentenze si collega essenzialmente alla riduzione del peso del giudizio incidentale, e alla crescita di quello degli “altri giudizi”, nel cui ambito la quasi totalità delle pronunce è rappresentata da sentenze.
Anche qui, può aiutare una comparazione diacronica.
Le pronunce emesse nel giudizio incidentale, limitandosi a considerare i dati successivi al periodo del c.d. “smaltimento dell’arretrato” (seconda metà degli anni ‘80), hanno oscillato, nel periodo 1987-2001, tra il 76,84% (nel 1988) e il 90,04% (nel 1987), rappresentando mediamente oltre i 4/5 di tutte le decisioni della Corte (l’84,29% nel 2002). Nel giudizio principale, la percentuale media è stata del 7,17%, con oscillazioni che vanno dal 2,76% del 1998 all’11,14% del 1988, mentre nel 2002 ci si è attestati sul 5,6%. Quanto ai conflitti Stato-regioni, anche qui, a fronte di una media di circa il 5% si sono registrate notevoli oscillazioni, dal 2,19% del 2000 all’11,06% del 1988 (il 2,24% nel 2002). Circa i conflitti tra poteri, la media di tutto il periodo è intorno al 6%, ma si registra una crescita pressoché costante (8% nel triennio 1999-2001, 7,28% nel 2002). Le percentuali riguardanti le pronunce sull’ammissibilità del referendum abrogativo sono meno facilmente inquadrabili in tendenze della giustizia costituzionale, dipendendo da vicende politiche, ciascuna delle quali presenta caratteri a sé.
L’attività della Corte nel corso del 2003 è stata quindi dedicata, per larga parte, al contenzioso Stato-regioni (cui si riferisce quasi il 50% delle sentenze, se si sommano i dati del giudizio principale e del conflitto tra enti). Tra le due grandi funzioni che caratterizzano gli organi della giustizia costituzionale (e che ne hanno connotato, storicamente, l’origine), ovvero quella di arbitraggio della ripartizione delle competenze e quella di difesa costituzionale delle libertà, prevale, forse per la prima volta nella storia della Corte costituzionale italiana, la funzione arbitrale.
Il merito delle decisioni rispecchia pienamente il grande rilievo, anche qualitativo, assunto dal giudizio sui rapporti tra Stato e regioni.
Infatti, come si vedrà, le pronunce relative ai “diritti e doveri dei cittadini”, che sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, conseguenza del giudizio incidentale, tendono a collocarsi nella linea di sviluppo di giurisprudenza sperimentata e consolidata.
È il campo dei rapporti Stato-regioni quello in cui si possono rintracciare le maggiori novità. La riforma del Titolo V, realizzata con la legge costituzionale 3/2001, ha messo la Corte di fronte a norme costituzionali “nuove di zecca”, chiamandola a una complessa opera di interpretazione, nell’ambito della quale un ausilio limitato ha fornito la precedente giurisprudenza.
Nel corso del 2002 la maggior parte delle decisioni in questo settore aveva riguardato ricorsi promossi nella vigenza del vecchio Titolo V, o problemi di diritto intertemporale, collegati al sopravvenire del nuovo parametro costituzionale, in assenza, tra l’altro, di disposizioni transitorie. E invece nel 2003 che si affronta decisamente il merito delle questioni. Definendo il riparto delle competenze, peraltro, la Corte è in molti casi chiamata ad affrontare problematiche relative a diritti fondamentali: basti pensare al tema della tutela della salute, alla disciplina delle comunicazioni, alla tutela dell’ambiente, alla determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali. D’altra parte, non è questo un fenomeno sorprendente, in quanto le più antiche esperienze di giustizia costituzionale (a partire da quella degli Stati Uniti) testimoniano che dietro controversie che si configurano formalmente come conflitti di competenza, spesso si celano questioni relative alla garanzia dei diritti.
Quanto alle questioni pervenute alla Corte nel corso del 2003, si tratta di ben 1196 ordinanze che promuovono giudizi incidentali, di 98 ricorsi in via principale, di 15 ricorsi che promuovono conflitti tra enti, di 22 ricorsi che promuovono conflitti tra poteri dello Stato (cui vanno aggiunti 26 ricorsi ancora da delibare in sede di giudizio di ammissibilità) e di un giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo. Un esame delle ordinanze di rimessione mostra, peraltro, che la maggior parte (ben il 56,35%, pari a 674 ordinanze) pone questioni relative alla nuova disciplina dell’immigrazione, spesso identiche. Il 13,55% delle questioni, inoltre, riguarda il processo penale e il 5,43% il nuovo codice della strada. Volendo, su tale base, allungare uno sguardo prospettico sul 2004, pertanto, pare di poter affermare che anche nell’anno in corso la maggior parte dell’attività della Corte sarà dedicata alla definizione dei rapporti Stato-regioni, in piena continuità con quanto avvenuto nel 2003.
I. Il giudizio sulle leggi
- Il giudizio in via incidentale
1.1. Considerazioni introduttive
Nel 2003 la Corte costituzionale ha emesso 249 decisioni nel giudizio in via incidentale, pari a circa il 65% del totale.
Si tratta della cifra più bassa mai riscontrata. Come si è detto, nel periodo 1987-2001, esse hanno oscillato tra il 76,84% (nel 1988) e il 90,04% (nel 1987), rappresentando mediamente oltre i 4/5 di tutte le decisioni della Corte (l’84,29% nel 2002).
54 sono sentenze (pari al 21,68%), mentre 195 sono ordinanze (78,32%). I dati confermano la tendenza alla riduzione del numero delle sentenze rispetto a quello delle ordinanze presente ormai dalla metà degli anni ‘90: ad esempio nel triennio 1999-2001 nel giudizio incidentale soltanto il 24,37% delle decisioni ha assunto la forma della sentenza (con un picco negativo nel 2001, ove si è scesi sotto la soglia del 20%). Sempre più frequenti sono le ordinanze che affrontano nel merito questioni sollevate per la prima volta, esaminate in camera di consiglio in assenza di parti costituite, dichiarandone, con ampiezza di argomentazioni, la manifesta infondatezza.
Merita di sottolineare che persiste, in alcuni casi, un fenomeno già riscontrato in passato, ovvero il ritardo, a volte enorme, con il quale i giudici, specie quelli tributari, trasmettono le ordinanze alla Corte: nella questione decisa con l’ordinanza 57, l’ordinanza di rimessione, emessa il 4 maggio del 1994, è stata trasmessa soltanto nel 2002! A differenza di quanto accaduto in altre occasioni, in questo caso la Corte non ha censurato l’operato del rimettente.
1.2. La nozione di “giudice” e di “giudizio”
A proposito della legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, nel corso del 2003 meritano segnalazione le questioni proposte da un notaio e da un consiglio comunale. La questione sollevata da un notaio, chiamato a redigere un atto pubblico di donazione, è stata dichiarata inammissibile per la impossibilità di ricondurre la funzione notarile alla giurisdizione, in quanto è da essa assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione. In tale occasione la Corte ha precisato che “le considerazioni del notaio rimettente circa la difficoltà in cui verserebbe il soggetto privato, interessato ad adire la Corte costituzionale per sottoporre a essa il dubbio di costituzionalità su norme limitative dell’autonomia negoziale, quando – come nella specie – sia previsto a pena di nullità che l’atto sia ricevuto in forma pubblica dal notaio, si risolvono in critiche di merito alla scelta contenuta nell’art. 1 della legge costituzionale 1/1948, che ha escluso l’azione diretta d’incostituzionalità” (ordinanza 52). La questione sollevata da un consiglio comunale in sede di convalida degli eletti è stata dichiarata inammissibile (ordinanza 78) sulla base di consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza 93/1965). Ammissibile è stata pacificamente dichiarata, sulla base della precedente sentenza 376/01, la questione sollevata da un collegio arbitrale (ordinanza 11).
1.3. Rapporto tra giudizio di costituzionalità e giudizio a quo
L’autonomia del giudizio di costituzionalità dal giudizio a quo, prevista dall’art.22 delle norme integrative, è stata ribadita nell’ordinanza 270: “il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato”.
1.4. Il carattere concreto del giudizio incidentale. La rilevanza
Rigoroso è il controllo della Corte sulla motivazione dell’ordinanza di rimessione, al fine di difendere il carattere incidentale del giudizio e la sua natura concreta. Così, è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione che “esaurisce immediatamente il petitum del processo principale”, in quanto “la questione di legittimità costituzionale si presenta, … impropriamente, come azione diretta contro la norma censurata, in quanto l’eventuale pronunzia di accoglimento di questa Corte verrebbe a concretare di per sé e ad esaurire la tutela richiesta nel giudizio principale al rimettente, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice a quo per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente”. La questione, pertanto, è stata ritenuta carente del carattere di incidentalità, “il quale necessariamente presuppone che il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non coincida con la proposizione della questione stessa” (ordinanza 175).
Numerose sono le ordinanze di manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza (riguardanti, in diversi casi, la “scarsa chiarezza e incompletezza nella descrizione della fattispecie”: tra le molte, v. ad esempio l’ordinanza 305). Rientra in questa ipotesi la omessa considerazione, da parte del giudice, di norme che abbiano inciso su quella impugnata (ordinanza 40), eventualmente abrogandola (ordinanza 144). La Corte ribadisce che “lo scrutinio di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme abrogate prima della rimessione della questione è possibile solo a condizione che si dia conto delle ragioni per le quali tale scrutinio mantiene la sua rilevanza nel giudizio principale” (sentenza 104).
In altri casi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza, realizzando, quindi, un controllo sul giudizio di rilevanza svolto dal giudice, sia pur limitato alla evidenza, cosa che viene riscontrata nei casi in cui la questione è sollevata dopo che la norma censurata ha già trovato applicazione nel giudizio (ordinanza 215). Manifestamente inammissibili, secondo consolidati orientamenti, sono dichiarate anche le questioni meramente ipotetiche o astratte (ordinanze 129 e 147).
1.5. La non manifesta infondatezza
Quanto alla non manifesta infondatezza, è stata ribadita la necessità di una autonoma motivazione in proposito, con la conseguente inammissibilità di questioni motivate per relationem ad altre ordinanze che sollevano la stessa questione (ordinanze 60 e 335) o attraverso il mero richiamo all’eccezione svolta da una parte (ordinanze 66 e 118).
1.6. La determinazione del thema decidendum da parte del giudice a quo
Il giudice deve indicare in maniera univoca e chiara la questione sollevata, facendo propria una scelta interpretativa: questioni perplesse, ancipiti, prospettate in forma alternativa, sono state dichiarate inammissibili (ordinanze 34, 128, 159 e 299). “Il generico richiamo, nell’ordinanza di rimessione, a norme collegate da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell’ordinanza stessa, comporta l’inammissibilità della questione, dal momento che tale individuazione costituisce il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità” (ordinanza 85). La Corte, peraltro, non rifiuta di circoscrivere l’oggetto della questione, quando ciò possa avvenire sulla base della motivazione dell’ordinanza di rimessione (ordinanza 14; sentenza 185). Si è ritenuto altresì che l’erronea indicazione di disposizioni censurate, dovuta a mero errore materiale, non sia tale da determinare l’inammissibilità della questione (tenuto conto, tra l’altro, che l’indicazione dell’articolo richiamato erroneamente non appariva nel caso di specie necessaria ai fini della prospettazione della questione) (sentenza 275). Non osta, poi, all’individuazione della norma censurata l’errore materiale contenuto solo nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sentenza 325).
1.7. L’oggetto del giudizio. Il trasferimento della questione
Quanto all’oggetto del giudizio, la Corte ha ribadito (risolvendo un conflitto tra enti: sentenza 302) che i regolamenti di delegificazione non hanno valore di legge e come tali non sono soggetti al giudizio sulle leggi (sulla inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme secondarie, v. anche ordinanza 145 e sentenza 212). Peraltro, sempre riguardo alla delegificazione, se i giudici rimettenti reputano che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme legislative anteriori, la Corte ha ritenuto di potersi pronunciare su queste ultime, in quanto ancora in vigore (sentenza 239).
In un caso in cui il vizio denunciato derivava non dalla norma, ma da sue modalità applicative, contenute in norme subprimarie, sottratte al controllo della Corte, ma sindacabili dal giudice competente per il merito, la questione è stata dichiarata non fondata (sentenza 105).
In alcuni casi la Corte ha effettuato il trasferimento della questione dalla disposizione censurata ad altra che la riproduce, contenuta in un testo unico, sopravvenuto dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione (ordinanza 299). Il trasferimento è stato effettuato anche quando l’abrogazione della norma, e la sua trasposizione nel testo unico, erano avvenute precedentemente all’ordinanza di rimessione. Non si ritiene necessariamente, in tale ipotesi, di essere di fronte a una erronea ricostruzione del quadro normativo, da cui consegua la manifesta inammissibilità della questione (sentenza 304, ordinanza 328).
Peraltro, la Corte non ha trasferito la questione, pronunciandosi sulla norma originariamente sottoposta al suo giudizio, qualora questa sia stata sostituita da una norma successiva che non è stata ritenuta rilevante in quanto “l’intervento legislativo non ha modificato la disciplina censurata”, limitandosi a recepire il contenuto di sentenze della Corte costituzionale relativamente a profili diversi da quello in discussione (sentenza 135). Il trasferimento non è stato operato neppure alla norma che proroga l’efficacia della disposizione censurata, in quanto il giudice deve comunque fare applicazione della disciplina vigente nel momento in cui ha sollevato la questione, la cui eventuale illegittimità costituzionale travolgerebbe le successive proroghe (sentenza 310).
1.8. Il parametro del giudizio
Circa la determinazione del parametro del giudizio, non si registrano novità. È da segnalare un accenno relativo alla possibilità di invocare a parametro, nel giudizio incidentale, norme comunitarie. La Corte, trattandosi in quel caso di giudizio principale, afferma di poter prescindere “dal problema più generale, che investe ora l’interpretazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione, se ed entro quali limiti l’ipotesi di contrasto di una norma interna con l’ordinamento comunitario sia idonea a radicare la competenza del giudice delle leggi” (sentenza 303). Nell’unico giudizio incidentale del 2003 avente ad oggetto norme regionali anteriori alla riforma del Titolo V (sentenza 227), la Corte non ha affrontato il problema del mutamento del parametro, trattandosi di norme di regione speciale in una materia, la caccia, nella quale già una precedente decisione (536/2002) aveva precisato il permanere del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (in caso contrario, secondo la giurisprudenza anteriore, se ne sarebbe dovuta dichiarare la inammissibilità, essendo questione sollevata dopo il sopravvenire del nuovo Titolo V).
1.9. L’intervento dei terzi nel giudizio incidentale
La Corte ha ribadito l’inammissibilità dell’intervento di soggetti non “parti nel giudizio a quo al momento dell’emissione dell’ordinanza di rimessione e [privi di] un interesse qualificato ad intervenire che possa dirsi immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” (sentenza 227; così anche sentenze 26, 341 e 346). Si è precisato altresì che non rileva il fatto che i soggetti che chiedono di intervenire abbiano in corso giudizi analoghi, sospesi in attesa della pronuncia della Corte, poiché l’intervento “si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale” (ordinanza 179).
Circa i poteri delle parti, la Corte ha ribadito che “non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze” (ordinanza 174).
1.10. Ambito delle conoscenze acquisibili dalla Corte
La Corte afferma che non può essere eccepita (nella specie da parte dell’Avvocatura generale dello Stato) l’irrilevanza di una questione sulla base di documentazione, non delibata dal giudice a quo, “acquisita al di fuori delle forme previste per il processo costituzionale, dalla legge 87/1953, e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale” (ordinanza 287: si trattava di note, relative al giudizio a quo, allegate dall’Avvocatura generale dello Stato al suo atto di costituzione).
1.11. Interpretazione conforme a Costituzione, diritto vivente, potere interpretativo dei giudici
Un aspetto caratterizzante molte decisioni rese in via incidentale nel 2003 è il tentativo della Corte di distinguere il suo ruolo da quello dei giudici comuni nella garanzia della costituzionalità dell’ordinamento.
La Corte ha ribadito la centralità dell’interpretazione conforme alla Costituzione come compito dei giudici: essa riafferma il principio, già più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (sentenza 301). La Corte sottolinea, ad esempio, che “eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione” (sentenza 198). La questione è stata dichiarata inammissibile (o manifestamente inammissibile) qualora il giudice rimettente non abbia tentato l’interpretazione conforme (ordinanza 279), anche se si sia richiamato a un diritto vivente contrario, dal quale abbia ritenuto di non poter prescindere (ordinanza 229), tanto più quando un’interpretazione idonea a fugare il dubbio di costituzionalità fosse rintracciabile nella giurisprudenza (ordinanza 348), specie in quella della Cassazione (ordinanze 19, 107, 244). Si ribadisce che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un’interpretazione costituzionalmente corretta (ordinanza 19), cosicché una questione può essere dichiarata manifestamente inammissibile soltanto perché, a fronte di una disposizione alla quale “secondo larga parte degli interpreti” potrebbe essere data interpretazione conforme a Costituzione, senza necessità di un intervento della Corte, “il rimettente omette qualsiasi motivazione circa l’impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione” (ordinanza 208).
La Corte ritiene che sia fatto un uso “improprio” della questione di costituzionalità quando il rimettente chieda essenzialmente un avallo a una sua interpretazione della disposizione impugnata (“per renderla conforme a Costituzione”, ma, più precisamente, al fine di preservare la stessa in vista del futuro giudizio di appello o di Cassazione; si afferma in modo netto “l’estraneità di siffatta finalità alla logica del giudizio incidentale”: ordinanza 155; sentenza 229, ordinanza 289).
Alla conclusione circa un improprio utilizzo della questione di costituzionalità si giunge anche nel caso in cui il rimettente afferma di voler far propria l’interpretazione della disposizione conforme a Costituzione proposta dalla Corte con una sentenza interpretativa di rigetto, ma si trovi in ciò ostacolato da un “diritto vivente” (o, quantomeno, da un indirizzo giurisprudenziale uniforme) di senso opposto, sollevando perciò su tale indirizzo la questione: il giudizio di costituzionalità, in questo caso, è attivato dai rimettenti, secondo la Corte, per “ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta”, utilizzando quindi “in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare una interpretazione che essi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile” (ordinanza 109).
Diverso è il caso in cui sia il giudice del rinvio a sollevare questione, sostenendo di essere consapevole della astratta possibilità di non sollevare questione, ma di essersi indotto a farlo onde sottrarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, al quale era vincolato. Qui la Corte non rileva un uso improprio della questione di costituzionalità: essa afferma però che “nelle ipotesi in cui i principî costituzionali vengano invocati dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimità ed evitarne l’applicazione, la motivazione della rilevanza della questione deve essere particolarmente rigorosa”, al fine di mostrare la necessità di una sentenza di accoglimento per conferire effettività ai principi costituzionali; cosa che il giudice non avrebbe fatto nel caso di specie (ordinanza 151).
Da segnalare particolarmente è una decisione emessa in un giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali: a seguito di un contrasto riscontrato tra una propria sentenza e una decisione interpretativa della Corte, il giudice rimettente chiedeva una pronuncia caducatoria. La questione è dichiarata manifestamente inammissibile, poiché “l’ordinanza delle sezioni unite, oltre ad apparire perplessa (in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione, il denunciato contrasto si riduce ad un laconico ‘forse’), si chiude con l’esplicito invito al ‘rispetto delle reciproche attribuzioni’, come se a questa Corte fosse consentito affermare i principî costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione” (ordinanza 243).
1.12. Le decisioni interpretative di rigetto
Quanto alla tipologia delle decisioni, poche sono quelle interpretative di rigetto. Ad esempio, con la sentenza 198 la Corte ha invitato il giudice ad abbandonare l’interpretazione meramente letterale per ricorrere a quella analogica (in assenza di diritto vivente), in nome del principio di supremazia della Costituzione. Con la sentenza 233 il rimettente è sollecitato ad accogliere una interpretazione opposta a quella da cui muove, in quanto, tra l’altro, il supposto diritto vivente contrario è stato disatteso dalla stessa Corte di cassazione con pronunce successive alla ordinanza di rimessione.
1.13. Le decisioni di accoglimento, le decisioni manipolative, l’inammissibilità per discrezionalità del legislatore, l’illegittimità consequenziale
Tra le sentenze di incostituzionalità, oltre a quelle di accoglimento semplice si segnalano decisioni di tipo additivo, sostitutivo o di accoglimento parziale. Deve sottolinearsi l’assenza di sentenze additive di principio, almeno nella tipica forma di pronunce che, nella motivazione, contengono un’esplicita affermazione dei ruoli affidati rispettivamente al legislatore e ai giudici nell’attuazione del principio medesimo.
A fronte di una omissione incostituzionale la Corte ha utilizzato la sentenza additiva (169, 211, 253, 262, 275, 345, 350) ovvero la inammissibilità, quando l’integrazione dell’ordinamento richiederebbe l’esercizio di poteri normativi discrezionali (sentenze 2, 33, 332, ordinanza 76). In particolare, si è detto che la Corte “ben può estendere l’ambito di applicazione di una norma quando, in relazione al valore costituzionale tutelato, lo esiga, secondo il criterio della ragionevolezza, la ratio della norma stessa” (sentenza 275). Al contrario, si ritiene di non poter adottare una pronuncia additiva, finalizzata a circoscrivere la portata di una norma ad alcune situazioni, quando “potrebbero esistere altri casi in cui quella ratio [limitatrice] ricorra ugualmente: ma la loro identificazione resta riservata al legislatore, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali” (sentenza 332).
La presenza di una norma incostituzionale, la cui cancellazione pura e semplice potrebbe comportare un inammissibile vuoto fino all’intervento del legislatore, ha determinato o sentenze sostitutive (sentenze 104 e 301), oppure per un accoglimento parziale (sentenze 148, 149,185, 239, 360). Talora la Corte ha individuato nella motivazione un principio orientativo per il legislatore, senza porlo però nel dispositivo, evitandone così l’applicazione diretta da parte dei giudici (sentenza 360).
In un’unica decisione si è fatto uso dell’art. 27 della legge 87/1953, in riferimento a una norma analoga a quella dichiarata incostituzionale (sentenza 169). Peraltro la Corte ha affermato, proprio sulla base della disciplina contenuta nell’art. 27, la palese infondatezza della tesi che vorrebbe “non più operante una norma” soltanto perché analoga ad altra, già dichiarata incostituzionale (sentenza 306).
1.14. Moniti al legislatore
La “opportunità” (o l’”auspicio”) di una nuova disciplina della materia (in un caso, il risarcimento del danno da parte del vettore marittimo, in un altro il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico o artistico, in un altro ancora il procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti) è fatta presente in decisioni che pure dichiarano l’infondatezza delle questioni (sentenze 71, 346 e 264). Un “invito” al legislatore, affinché impieghi formule più precise nella determinazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione è presente nella ordinanza 134.
La Corte, poi, ha affermato di “non poter omettere” di rilevare ancora una volta l’inerzia del legislatore nel campo delle misure di sicurezza “caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche” (sentenza 253).
Un vero e proprio monito al legislatore è contenuto nella sentenza 310, nella quale, pur riconoscendosi l’infondatezza delle censure avanzate avverso le norme che prevedono la sospensione della procedura esecutiva per il rilascio di immobili, si afferma che tale procedura “non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità”. La Corte ha aggiunto che “non si intende con ciò negare che il legislatore debba farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, in quanto appartenenti a categoria protetta, ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali; ma non può indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere [del mancato rilascio] in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”.
1.15. La restituzione degli atti al giudice a quo
Le decisioni di restituzione degli atti al giudice rimettente nell’anno in esame sono 18, tutte motivate sulla base di jus superveniens. In alcuni casi lo jus superveniens è costituito da una decisione di accoglimento parziale della Corte (ordinanze 7, 20, 184, 236, 316, 321, 344), più frequentemente da un cambiamento del quadro normativo. Una ordinanza di restituzione degli atti (ordinanza 62) affronta il tema della “doppia pregiudizialità”, costituzionale e comunitaria: la restituzione atti consegue al sopravvenire della pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, che ha “esaminato e risolto la questione della conformità all’ordinamento comunitario della norma statale di cui il rimettente denuncia l’illegittimità costituzionale, anche sotto il profilo dal medesimo censurato”. La Corte ribadisce che “i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale”.
Una precisazione sui caratteri della restituzione degli atti è contenuta nella sentenza 333, con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione risollevata da un giudice (dopo la restituzione atti) sulla norma sopravvenuta. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il rimettente avrebbe dovuto fare applicazione delle disposizione abrogata: a fronte “di jus superveniens direttamente attinente la normativa oggetto di censura, la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione [riguardo alla norma originariamente censurata] spetta al giudice a quo…il provvedimento di restituzione degli atti risponde appunto all’unico fine di consentire tale necessaria valutazione”.
1.16. Il giudicato costituzionale
Inammissibili sono dichiarate le questioni dirette a censurare precedenti decisioni della Corte. Ciò vale sia per quelle relative all’enunciato normativo risultante da una sentenza, rispetto al quale si chiede venga ripristinata la norma annullata (ordinanza 9), sia per quelle che ripropongono, in termini identici, altra questione sollevata dallo stesso rimettente nello stesso giudizio e dichiarata inammissibile per vizi non sanabili. Al riguardo, la Corte riafferma che “in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo, non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione” (ordinanza 63).
Infine, si può segnalare la sentenza 211, con la quale è dichiarata incostituzionale la norma di un testo unico (art. 159, commi 2, 3 e 4 D.Lgs 267/00) che riproduce altra norma (art. 113 D.Lgs 77/1995) già dichiarata incostituzionale (con sentenza 69/1998), senza che alcun riferimento sia contenuto, né nell’ordinanza di rimessione, né nella sentenza della Corte, all’eventuale violazione del giudicato costituzionale.
2. Il giudizio in via principale
2.1. Considerazioni introduttive. Il sopravvenire del nuovo Titolo V
Nel corso del 2003 la Corte ha emesso 57 decisioni nell’ambito di giudizi in via principale: 48 sentenze e 9 ordinanze. Con queste ultime (in due casi pronunciate a seguito di camera di consiglio: ordinanze 339 e 357) si dichiara estinto il ricorso per rinuncia (ordinanze 67, 230, 281, 342, 357, 382) o cessata la materia del contendere (per mutamento del quadro normativo: ordinanze 15 e 292; per promulgazione parziale con omissione delle norme impugnate di una legge siciliana: ordinanza 339; peraltro, la cessazione della materia del contendere, per i due medesimi motivi è dichiarata in altri casi con sentenza: sentenze 334 e 351).
32 decisioni sono pronunciate su ricorsi statali, 25 a seguito di ricorsi regionali. Si conferma, con una decisa accentuazione, un trend crescente già verificatosi negli anni precedenti, che assume maggiore rilievo se si passa dal valore assoluto a quello percentuale, raggiungendo, con il 14,92% sul totale delle pronunce dell’anno, la cifra più alta mai toccata (si pensi che, ad esempio, nel triennio 1993-1995, era stato toccato il livello massimo con il 9,3%; nel 2002, la percentuale era stata del 5,6%).
16 decisioni riguardano questioni sollevate nella vigenza del vecchio Titolo V, 12 su ricorso regionale e 4 su ricorso statale. In quest’ultimo caso, si tratta di ricorsi del Commissario dello Stato avverso leggi regionali siciliane, gli unici che non siano divenuti improcedibili in conseguenza della modifica dell’art. 127 (la improcedibilità dei ricorsi governativi, nel caso delle regioni ordinarie, era stata affermata dalla sentenza 17/2002, cui hanno fatto seguito altre decisioni, relative alle singole regioni speciali). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni nella vigenza del vecchio Titolo V sono risolte, secondo una giurisprudenza ormai costante a partire dalla sentenza 376/2002, “alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri” (così le sentenze 28, 37, 91, 92, 93, 96, 103,186, 197, 221, 308, 334). “La Corte infatti, in assenza di nuove impugnazioni, non ha motivo per porsi il problema della compatibilità di quella norma con il sistema cui ha dato vita la riforma, mentre è comunque salva la possibilità che la nuova disciplina sia fatta valere dallo Stato o dalle Regioni mediante nuovi atti di esercizio o di tutela delle rispettive attribuzioni” (sentenza 28).
Qualora, poi, le norme statali impugnate non abbiano prodotto effetti, si dichiara la inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in nome del principio di continuità. A partire dalla citata sentenza 376/02, infatti, la Corte ha espressamente escluso la sopravvenuta illegittimità costituzionale delle norme preesistenti alla riforma, affermando che esse restano in vigore fino a quando non vengono sostituite da nuove norme, dettate dall’autorità competente nel nuovo sistema (così sentenze 196 e 197).
Un caso particolare è quello di un decreto-legge emesso e impugnato nel contesto del precedente sistema di riparto delle competenze, cui si è sostituita, dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V, una legge di conversione non impugnata. La questione è dichiarata inammissibile, poiché le norme del decreto-legge non hanno trovato applicazione: in assenza si qualsiasi effetto lesivo nei confronti delle regioni si determina una carenza di interesse sopravvenuta. Non si è ritenuto possibile trasferire la questione alle norme della legge di conversione, in quanto ciò sarebbe dovuto avvenire in riferimento a parametri nuovi: si sarebbe trattato, così, di una “questione diversa rispetto a quella originariamente sollevata, che avrebbe pertanto dovuto essere promossa nei termini di cui al nuovo art. 127” (sentenza 228).
2.2.L’impugnativa di “leggi statutarie” delle regioni speciali
Nel periodo in esame, la Corte è stata chiamata a giudicare (sentenza 49) la legittimità costituzionale di una legge statutaria della regione Valle d’Aosta. Si tratta di un ricorso di tipo preventivo, previsto da questo come dagli altri statuti speciali a seguito della legge costituzionale 2/1999, non dissimile da quello di cui all’art. 123 Costituzione, in riferimento agli statuti delle regioni ordinarie. Nel caso di specie, successivamente alla proposizione del ricorso la legge impugnata, decorso il termine per la richiesta di referendum, è stata promulgata e pubblicata. Con la conseguenza che il giudizio della Corte si è trasformato da preventivo in successivo.
2.3. La “scissione dei ricorsi”
Una novità processuale riscontrabile nell’anno è costituita dalla “scissione dei ricorsi”: all’interno di un unico ricorso si individuano questioni relative a materie omogenee, da essere decise con separate decisioni. “Il ricorso, uno nella forma, è plurimo nel contenuto. Esigenze di omogeneità e univocità della decisione inducono a distinguere le materie e a procedere, quindi, alla decisione separata di ciascuna questione o gruppo di questioni”(sentenza 201). In questi casi, il dispositivo della pronuncia si presenta preceduto dalla formula “riservata ogni decisione sulla questione ecc.” (così sentenze 201, 300, 313, 361, 362, 363, 370, 376, 377, 378; v. anche la sentenza 331, che definisce l’ultima delle questioni sollevate dal ricorso già oggetto delle sentenze 201 e 313).
2.4. I soggetti ricorrenti
Quanto ai soggetti legittimati a proporre ricorso in via principale, la Corte ribadisce, anche dopo la riforma del Titolo V, che tra essi non sono compresi gli enti locali (nella specie il comune). L’art. 127, infatti, affida, “con formulazione dal tenore inequivoco”, la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali alla regione, “né è sufficiente l’argomento sistematico invocato dal ricorrente per estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali” (il ricorrente comune di Vercelli aveva sostenuto che “la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ha attribuito direttamente ai comuni potestà amministrative e normative che dovrebbero poter essere difese nel giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e nel giudizio per conflitto di attribuzione”: sentenza 303).
2.5. L’intervento dei terzi nel giudizio principale
Inammissibile è stato dichiarato, conformemente a una giurisprudenza costante, l’intervento in giudizio di soggetti terzi interessati alla decisione. In un caso, la motivazione si limita a rilevare il carattere tardivo dell’intervento (sentenza 226), mentre negli altri, indipendentemente dalla eventuale tardività, si ribadisce che “nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse” (così sentenza 49; v. anche sentenze 226, 303, 307, 315 e 338).
2.6. La genericità e la sufficienza del ricorso
Riguardo ai caratteri del ricorso, viene ribadito che questo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, quanto ad oggetto, parametro, motivazione delle censure, determinandosi in caso contrario la inammissibilità (sentenze 213, 222, 242, 303): alla Corte spetta l’unico compito di “giudicare sulle questioni così come sono sollevate, un compito che non comprende quello di determinarne l’oggetto e i limiti” (sentenza 313). E ammissibile altresì la questione promossa sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili: “a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale – il giudizio in via principale (soggetto a termini di decadenza, in quanto processo di parti, svolto a garanzia di posizioni soggettive dell’ente ricorrente) può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative, e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose” (sentenza 228).
2.7. L’impugnazione di un’intera legge
L’impugnazione di una intera legge, se solitamente è inammissibile per genericità delle censure (sentenza 94), è invece ammissibile quando la legge ha un contenuto specifico ed omogeneo (sentenza 359).
2.8. La determinazione dell’oggetto del ricorso nella delibera del Consiglio dei ministri
L’oggetto dell’impugnazione deve essere definito dal ricorso in conformità alla decisione governativa, con la conseguenza che sono inammissibili le questioni sollevate nei confronti di disposizioni che il governo (sulla base di quanto risulta dal verbale del consiglio dei ministri e, ove da questo richiamata, della relazione del ministro per gli affari regionali) non ha deliberato di impugnare (sentenze 315 e 338).
2.9. Il parametro del giudizio
La Corte ha ritenuto, conformemente alla propria precedente giurisprudenza, che il parametro possa essere costituito anche da una direttiva comunitaria. Infatti,”nei giudizi di impugnazione deve essere tenuto fermo l’orientamento già espresso da questa Corte…, secondo il quale il valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione soprattutto quando una esplicita clausola legislativa di salvaguardia del diritto comunitario renda, come nella specie, manifestamente insussistente il denunciato contrasto” (sentenza 303).
2.10. La “parità delle armi” tra Stato e regioni dopo la riforma del Titolo V
Un problema molto dibattuto dopo la riforma del Titolo V è stato quello della “parità delle armi” tra Stato e regioni nel giudizio principale, sotto il profilo dei vizi denunciabili.
Per quanto riguarda l’interesse a ricorrere delle regioni, la Corte ha avuto occasione di ribadire, riferendosi ad una questione sollevata nella vigenza del vecchio Titolo V, che la violazione dell’art. 97 Costituzione, sotto il profilo della valutazione di efficienza ed economicità, da parte di una legge statale, è “estranea all’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promuovibile dalla regione”(sentenza 96). Riguardo, poi, ad una questione sollevata, per eccesso di delega, in riferimento al nuovo titolo V, la Corte ha confermato la propria precedente giurisprudenza, secondo la quale “nel giudizio promosso in via principale il vizio di eccesso di delega può essere addotto solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni o province autonome ricorrenti” (sentenza 303).
Quanto alla questione se, ai sensi del nuovo art. 127, lo Stato possa dedurre come parametro violato qualsiasi norma costituzionale, ovvero solo quelle concernenti il riparto delle competenze legislative, la Corte, dopo un primo cenno contenuto nella sentenza 94, esprime una posizione netta con la sentenza 274 (richiamata successivamente dalla sentenza 312, nella quale lo Stato invoca a parametro, legittimamente secondo la Corte, l’art. 21 Costituzione).
Per affermare che, “pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale”, la Corte, oltre al dato letterale, richiama quello sistematico, rilevando che, nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato è “pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, comma 1) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, comma 2). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, appunto – avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento. Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i comuni, le città metropolitane e le province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa.”
2.11. Il permanere del peculiare meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane
Dopo la riforma del Titolo V, era stata messa in dubbio la permanente efficacia del meccanismo di impugnazione delle leggi siciliane previsto dall’art. 28 dello statuto speciale: ritenendo che il nuovo procedimento dell’art. 127 garantisca alla Sicilia un maggior margine di autonomia, l’art. 10 della legge costituzionale 3/2001 avrebbe imposto di dichiarare improcedibili i ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V contro le leggi siciliane, così come già avvenuto riguardo ad altre regioni speciali nel corso del 2002 (ordinanze 65 e 377/02, sentenze 408 e 533/02).
La Corte, tuttavia, ha ritenuto non essere possibile valutare se il nuovo art. 127 configuri un “forma di autonomia più ampia” rispetto al sistema siciliano: “si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza”. La conclusione è che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane disciplinato dallo Statuto speciale, unico tra quelli previsti dagli statuti speciali, resta tuttora applicabile, salva una sempre possibile modifica statutaria (sentenza 314).
2.12. Le ordinanze di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio
Le ordinanze di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio lasciano trasparire un fenomeno nuovo nei rapporti Stato-regioni, già segnalato dalla dottrina: scomparso il rinvio governativo a seguito della modifica dell’art. 127, quella che è stata definita come “contrattazione di legittimità” tra Stato e regioni tende ad avviarsi dopo il ricorso statale, e spesso conduce alla approvazione di una nuova disciplina regionale, questa volta non impugnata dallo Stato poiché “contrattata” con reciproca soddisfazione. In questo senso possono essere lette le ordinanze 15 e 292, di cessazione della materia del contendere, e le ordinanze di estinzione di giudizi su leggi regionali promossi dal governo (67, 281, 342, 357). I due casi di estinzione di un giudizio promosso da una regione hanno una diversa spiegazione: nella ordinanza 230 si dà atto di una intervenuta intesa tra la regione e il governo, che giustifica la rinuncia al ricorso, mentre la rinuncia al ricorso della regione Umbria, di cui si prende atto nella ordinanza 382, non porta ragioni.
2.13. Altri tipi di decisione nel giudizio principale
Tra le decisioni non di merito, si possono altresì richiamare: una declaratoria di inammissibilità per aberratio (sentenza 372); una sentenza di cessazione della materia del contendere per abrogazione della norma impugnata, con espressa previsione di inefficacia di tutti gli atti applicativi adottati (sentenza 362).
Meritano poi di essere citate due pronunce interpretative di rigetto, che giungono ad una interpretazione adeguatrice delle norme impugnate, nel senso che esse non si applicano alle province autonome ricorrenti, sulla base di una clausola di salvezza delle loro competenze, che viene valorizzata dalla Corte “indipendentemente dalla lettera della norma e dalla sua collocazione” (sentenze 91 e 228; altre pronunce interpretative di rigetto sono le sentenze 303, 312, 370, 376).
Nel 2003 si rinviene, nel giudizio principale, un’unica dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale di cui all’art. 27 della legge 87/1953: l’incostituzionalità è estesa ad altra disposizione contenuta nella legge impugnata, che “si pone in inscindibile nesso” con quella annullata (sentenza 338).
In due occasioni è stato chiesto alla Corte di sollevare di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale. In un caso si trattava di istanza della regione resistente relativa alla legge statale invocata dal governo quale parametro interposto; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata sulla base di proprie precedenti decisioni (sentenza 226). In una seconda occasione, la provincia autonoma ricorrente ha chiesto alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme della legge 87/1953 che precludono l’applicazione al giudizio principale dell’istituto dell’errore scusabile. La Corte ha escluso la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità relativa proprio a “quelle norme legislative che, regolando il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il massimo di certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio” (sentenza 303).
II. Gli altri giudizi
1. Il conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni
1.1. Considerazioni introduttive
Nel corso del 2003, 23 sono le pronunce che risolvono conflitti intersoggettivi (pari al 6,02% dell’attività della Corte, contro il 2,24% dell’anno precedente), tutte adottate a seguito di udienza pubblica. Si tratta di 18 sentenze e di 5 ordinanze, due di manifesta inammissibilità (ordinanze 30 e 79) per inidoneità dell’atto oggetto del conflitto, due di cessazione della materia del contendere (ordinanze 53 e 168), una di estinzione del processo per rinuncia (ordinanza 24). Soltanto una decisione è conseguenza di un ricorso statale, mentre ben 22 derivano da ricorsi delle regioni e delle province autonome, a conferma di una tendenza ormai radicata. L’unico ricorso statale (deciso con sentenza 13) concerne l’esercizio del c.d. “potere estero”. Tra le decisioni relative a ricorsi regionali, 3 hanno ad oggetto sentenze (sentenze 29, 276, 326), le altre riguardano atti amministrativi o regolamenti.
Aspetto caratterizzante le pronunce sui conflitti dell’anno 2003 (soltanto 8 decisioni affrontano il merito della controversia) è il tentativo della Corte di salvaguardare il “tono costituzionale” del conflitto, tenendo netta la linea di frontiera che lo separa dagli “ordinari rimedi giurisdizionali” (su questo, ampiamente, la sentenza 95).
La maggior parte delle pronunce (17) risolvono conflitti promossi prima della legge costituzionale 3/2001, e utilizzano quindi a parametro disposizioni contenute nel vecchio Titolo V. Soltanto in un caso il sopravvenire del nuovo parametro determina conseguenze sul giudizio: la sentenza 329 dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse alcuni conflitti regionali sorti a seguito di un decreto del presidente del consiglio in materia di tutela della salute poiché: a) sulla base dell’art.117, comma 6, lo Stato non ha più il potere di emanare questo tipo di atto; b) l’atto medesimo non ha avuto alcuna attuazione; c) le regioni possono sostituire la disciplina dettata dall’atto impugnato. Questo, peraltro, in forza del principio di continuità, mantiene la propria vigenza nell’ordinamento, pur assumendo carattere cedevole.
La Corte ribadisce la inapplicabilità dell’istituto dell’acquiescenza ai giudizi per conflitto, trattandosi di istituto incompatibile con la indisponibilità delle competenze di cui si controverte (sentenze 39 e 95).
1.2. Il profilo soggettivo
Quanto ai soggetti ricorrenti, la Corte riafferma che gli enti locali (nella specie, i comuni) non possono proporre conflitto di attribuzione, neppure dopo la riforma del Titolo V, in quanto “nessun elemento letterale o sistematico consente…di superare la limitazione soggettiva che si ricava dagli art. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87” (sentenza 303).
1.3. Il profilo oggettivo: l’atto lesivo
Riguardo all’atto che dà luogo al conflitto, è affermata la idoneità dei regolamenti di delegificazione, che non possono essere impugnati in via principale (sentenza 302), mentre la Corte ribadisce che i conflitti tra enti non possono riguardare atti legislativi (sentenza 303).
Numerose sono le pronunce di inammissibilità (o di manifesta inammissibilità) per inidoneità dell’atto ad essere lesivo della sfera di competenza costituzionale: è questo il caso di “istruzioni ministeriali” relative ad una fase interna e provvisoria del procedimento (sentenza 97), di istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi che non incidono sulla loro ripartizione tra Stato e regione siciliana (ordinanze 30 e 79), di un atto meramente esecutivo di una precedente legge non impugnata (sentenza 113), di un atto che non preclude un successivo esercizio delle competenze che la ricorrente rivendica (sentenza 265, nella quale si precisa la mancanza dell’interesse a ricorrere), di una nota della ragioneria generale dello Stato, che costituisce “all’evidenza esercizio di normale attività interpretativa da parte di organi istituzionalmente chiamati a svolgerla” (sentenza 95). Inammissibile è anche il conflitto volto a rivendicare funzioni “invocando la titolarità del bene cui ineriscono” (nel caso, il demanio marittimo, sentenza 150), ed è ribadita la inammissibilità del conflitto che si traduca in una vindicatio rei (sentenza 95). Nel caso di conflitto su atti giurisdizionali, la Corte riafferma la inammissibilità di conflitti volti non a contestare la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale, ma, semplicemente, errores in iudicando (sentenze 29, 276 e 326).
1.4. La definizione del giudizio
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in tre casi: per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte (sentenza 265), a seguito di concorde valutazione delle parti, condivisa dalla Corte (ordinanza 53), perché l’atto impugnato è stato annullato dal Tar con sentenza passata in giudicato (ordinanza 168).
Due di queste decisioni (ordinanze 53 e 168) mostrano i rischi di sovrapposizione del conflitto tra enti con il giudizio amministrativo: in entrambi i casi, infatti l’atto oggetto del conflitto era stato impugnato anche di fronte al giudice amministrativo.
Inammissibile, per sopravenuta carenza di interesse, a seguito di una nuova legge statale che riconosce alla regione ricorrente le competenze rivendicate, è dichiarato il ricorso oggetto della sentenza 114.
Viene infine ribadita l’estensione alla provincia di Bolzano delle decisioni pronunciate a seguito di ricorso della provincia di Trento (sentenza 267).
2. Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
2.1. Considerazioni introduttive
Il numero complessivo delle pronunce della Corte rese a fronte di ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è stato, nel 2003, di 44 (pari all’11,51% dell’attività della Corte; il 7,28% nell’anno precedente), a conferma di una tendenza crescente riscontrabile ormai da alcuni anni. Di queste, soltanto 8 sono sentenze, pronunciate a seguito di udienza pubblica, mentre 36 sono ordinanze, emesse nell’ambito del giudizio di delibazione dell’ammissibilità del conflitto.
Ben 7 sentenze e 32 ordinanze riguardano conflitti, relativi all’insindacabilità parlamentare dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, di cui sono parte organi giurisdizionali e una delle due camere (20 sono in questa materia i conflitti ammessi).
Le altre 5 pronunce hanno visto contrapposti, rispettivamente, il consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia (relativamente al conferimento di ufficio direttivo: ordinanza 112 e sentenza 380); un giudice e il comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (in relazione alla opposizione del segreto di Stato: ordinanza 209, che ammette il conflitto); i promotori di una richiesta di referendum popolare e il parlamento, il governo e la commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi (ordinanza 195, di inammissibilità); il “delegato effettivo” di un comune che chiede l’indizione di referendum popolare ai sensi dell’art. 132, comma 2, Costituzione, e il parlamento (ordinanza 343, di inammissibilità).
Su 44 decisioni, le pronunce che risolvono nel merito un conflitto tra poteri sono 4: in due di esse (sentenze 219 e 379) si ritiene infondato il ricorso di un giudice contro una camera in riferimento all’art. 68, comma 1, affermando che spettava alla camera di appartenenza pronunciare l’insindacabilità del parlamentare; in una (sentenza 263) si accoglie il ricorso della camera dei deputati contro un organo giurisdizionale, relativamente alla validità dell’impedimento di un parlamentare sottoposto a procedimento giudiziario; nell’ultima si accoglie il conflitto promosso dal Csm contro il ministro della giustizia (sentenza 380).
2.2. La fase di delibazione
Nella sentenza 116 (sulla quale si tornerà infra), la Corte ha occasione di precisare la portata e il senso della fase di delibazione: “il legislatore del 1953 ha…conferito alla Corte costituzionale, in sede di delibazione sull’esistenza della ‘materia di un conflitto’, un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del thema decidendum del conflitto, tale addirittura da rischiare talvolta di investire gli aspetti di merito della questione…Si tratta…di un potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione, che si esprime attraverso la fissazione di regole che necessariamente definiscono la ‘materia’ del conflitto, stabilendo inderogabilmente soggetti e termini per lo svolgimento del processo. Regole che, per la loro natura conformativa, non possono essere eluse”.
2.3. I profili soggettivi
Riguardo ai profili soggettivi del conflitto, la Corte ribadisce la legittimazione del comitato promotore del referendum abrogativo, limitatamente “all’esclusione di tecniche elusive della richiesta referendaria da parte del legislatore…nonché alla garanzia di corrette ed adeguate modalità di svolgimento della campagna referendaria”, pur sottolineando la insufficienza di due soli presentatori e promotori a rappresentarlo (ordinanza 195); afferma per la prima volta la legittimazione del comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, “essendo competente a dichiarare definitivamente, nell’ambito delle materie di sua competenza, la volontà del potere cui appartiene “ (ordinanza 209); mentre non affronta, funditus, la questione della legittimazione del “delegato effettivo” di un comune che chiede l’indizione di referendum popolare ai sensi dell’art. 132, comma 2, Costituzione, in quanto la inammissibilità deriva dal profilo oggettivo, che viene esaminato per primo (ordinanza 343). E poi ribadita la legittimazione del consiglio superiore della magistratura e del ministro della giustizia, già riscontrata in sede di prima delibazione sull’ammissibilità (ordinanza 112 e sentenza 380).
2.4. I profili oggettivi: in particolare, il conflitto su atti legislativi
Riguardo ai profili oggettivi, la Corte ribadisce che gli interessi tutelabili attraverso lo strumento del conflitto dai comitati promotori dei referendum abrogativi sono circoscritti “all’esclusione di tecniche elusive della richiesta referendaria da parte del legislatore…nonché alla garanzia di corrette ed adeguate modalità di svolgimento della campagna referendaria” (ordinanza 195).
L’aspetto di principale interesse riguarda l’ammissibilità dei conflitti su atti legislativi, che viene affrontata in due ordinanze. Dando ormai per scontata l’ammissibilità di tale conflitto (sulla quale v. sentenza 457/99) la Corte si limita ad escludere “che possa genericamente chiedersi, sulla base di rilievi concernenti solo alcune disposizioni, l’annullamento, nonché la provvisoria sospensione dell’efficacia, di tre interi testi normativi” (ordinanza 195). Essa ribadisce, poi, che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato su atti legislativi è ammissibile solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale (ordinanza 343). Tale pronuncia avvalla l’idea, avanzata dalla dottrina, che il conflitto tenda ad assumere il carattere di strumento di chiusura del sistema.
2.5. Aspetti processuali
In due sentenze, entrambe relative all’art. 68 Costituzione, la Corte ha fatto uso dei propri poteri istruttori, chiedendo alle camere la trasmissione di documenti, menzionati negli atti difensivi delle stesse per sostenere l’esistenza di un “nesso funzionale” tra opinioni espresse e attività parlamentare (sentenze 219 e 379).
Si segnala, inoltre, che l’unica istanza di sospensione dell’atto impugnato presentata è stata dichiarata assorbita nella decisione di inammissibilità resa in sede di delibazione (ordinanza 195).
Due conflitti, poi, sono stati dichiarati inammissibili poiché con precedenti decisioni della stessa Corte era già stato annullato l’atto che ha dato luogo alla controversia (ordinanze 3 e 157).
2.6. Il problema della riproponibilità del conflitto già dichiarato improcedibile
Nella prima parte dell’anno, si continuano a riscontrare decisioni di improcedibilità a causa del mancato rispetto del termine di cui all’art. 26, comma 3 delle norme integrative (il deposito del ricorso presso la Corte deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla sua notificazione, congiuntamente all’ordinanza che ammette il conflitto): così le sentenze 99, 106, 111, tutte rese a seguito di camera di consiglio.
La sentenza 116 trae le conseguenze dell’improcedibilità così pronunciata. Con questa decisione viene risolto, nel senso della inammissibilità, il problema della riproposizione del medesimo ricorso quando non sia stata effettuata entro i termini la notificazione del precedente atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità. Il principale ostacolo da superare a tal fine era costituito dalla mancata previsione di termini da parte della legge 87/1953, con riguardo alla proposizione del conflitto: la Corte, a seguito di un’ampia ricostruzione della storia e della ratio del conflitto tra poteri, rileva che tale mancata previsione attiene alla fase anteriore alla proposizione del ricorso ed è volta a “favorire al massimo, al di fuori delle strettoie dei termini di decadenza, la ricerca e la conclusione di intese extragiudiziarie tra gli organi interessati al conflitto”. Attestato, con il deposito del ricorso, che non è possibile la composizione spontanea della controversia, “sussiste invero l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti. Va dunque superata la ormai palesata situazione di conflittualità e di incertezza, che non si attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le quali invece, attenendo alle garanzie di ripartizione costituzionale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali”.
A tale decisione hanno fatto seguito molteplici ordinanze, con le quali sono stati dichiarati inammissibili sia ricorsi che riproponevano conflitti già dichiarati improcedibili (ordinanze 153, 188, 189, 247, 254), sia conflitti semplicemente “divenuti” improcedibili per la mancata notifica entro i termini (ordinanza 238), sia conflitti già dichiarati inammissibili (ordinanze 214, 277, 280, 358).
3. L’ammissibilità del referendum abrogativo
3.1. La partecipazione al giudizio di ammissibilità del referendum
Nell’anno 2003, 6 sono le decisioni in ordine all’ammissibilità di richieste di referendum abrogativo (pari all’1,57% dell’attività della Corte), 2 di ammissibilità e 4 di inammissibilità.
Quanto al procedimento, si conferma la prassi, presente fin dalla sentenza 16/1978, di sentire in camera di consiglio i rappresentanti dei presentatori e quella, più recente (instaurata con la sentenza 31/2000), di consentire di depositare memorie ad altri soggetti aventi un interesse qualificato, che poi vengono ammessi ad illustrarle (nel giudizio definito con la sentenza 42, sono stati sentiti il difensore del “Comitato per il no” e quello del “Forum delle Associazioni familiari”).
3.2. I requisiti attinenti alla formulazione del quesito
Quanto ai limiti, quelli espliciti contenuti nell’art. 75 Costituzione non hanno trovato utilizzazione nelle sentenze del 2003. Le decisioni di inammissibilità sono motivate sulla base del carattere sostitutivo-propositivo, e non meramente abrogativo, della richiesta (sentenze 43 e 46); della disomogeneità del quesito, che comprende disposizioni di contenuto eterogeneo (sentenza 45; così anche sentenza 42); del carattere contraddittorio della richiesta, che lascerebbe permanere nell’ordinamento norme che si pongono in contrasto con la ratio stessa del quesito (sentenza 42).
È confermata la tendenza (avviata con la sentenza 36/1997) a ritenere inammissibilmente propositive quelle richieste che non comportano “l’automatica espansione di una disciplina comunque già esistente, ancorché originariamente residuale”, ma invece “una disciplina diversa, non derivante direttamente dall’estensione di preesistenti normative o dal ricorso a forme autointegrative” (sentenza 43). Il limite della necessaria completezza del quesito referendario ha trovato, poi, un’applicazione moderata. A più riprese si incontrano, nelle sentenze del 2003, affermazioni volte a negare l’incidenza sul giudizio di ammissibilità della “incompleta ripulitura della normativa residua, nella quale siano lasciate parole o proposizioni incoerenti con le restanti disposizioni” (sentenza 42), vuoi poiché si produrranno in ordine a queste, eventualmente, i normali effetti caducatori (sentenza 44), vuoi poiché l’estensione della portata abrogatrice è rimessa alla discrezionalità dei proponenti (entro il limite della non contraddittorietà: sentenza 41).
III. Il contenuto delle decisioni
1. Le fonti del diritto
1.1. Leggi retroattive e di interpretazione autentica
Il legislatore ha il potere di precisare per il passato il significato, ascrivibile a una tra le possibili varianti di senso del testo originario, di una disposizione, purché la portata retroattiva non violi altri principi costituzionali. Pertanto, qualora a un indirizzo giurisprudenziale prevalente se ne contrapponga un altro, consistente anche se minoritario, deve escludersi la illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica. Né può sostenersi che la norma interpretativa incida sulla certezza dei rapporti giuridici, in quanto tale effetto è insito nel fenomeno stesso dell’interpretazione autentica (sentenze 26 e 341).
Una volta ritenute ammissibili le leggi di interpretazione autentica, il problema riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che incontra la sua portata retroattiva. Il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell’art. 25 della Costituzione; e quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.
Nel caso deciso con la sentenza 291, “la norma censurata supera il vaglio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Costituzione), in quanto il legislatore si è limitato ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già contenuto e riconoscibile nel novero delle esegesi plausibili, costituendo ‘una delle possibili letture del testo originario’”. Siffatta originaria plausibilità esclude anche ogni lesione del principio di affidamento: se questo è, in linea di principio, violato da disposizioni retroattive “che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori”, ciò non accade nel caso in esame, in quanto si trattava di questione controversa, nella quale si poneva un “obiettivo dubbio ermeneutico”.
1.2. Leggi provvedimento
Riguardo alla legge regionale che istituisce un nuovo comune, la Corte ha affermato che si tratta di una tipica legge provvedimento, adottata sulla base di un procedimento disciplinato, in ogni aspetto, dalla legge generale. “La legge provvedimento, che non innova e tanto meno si sovrappone alla legge generale, sostituendola pro parte, è attuativa della scelta compiuta con quest’ultima, la quale dunque non può considerarsi estranea al…giudizio” (sentenza 47).
1.3. Decreti-legge
Il sindacato sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, nel caso di un decreto legge convertito, deve limitarsi alla “evidente mancanza”, che non può essere sanata dalla legge di conversione, configurando un vizio in procedendo della stessa. Il ricorso alla decretazione d’urgenza è giustificato, nel caso di un decreto-legge di interpretazione autentica, in quanto dai lavori parlamentari risulta che il punto controverso ha formato oggetto di un ampio dibattito ed emerge che la funzione della norma è di evitare l’ulteriore proliferare di un contenzioso già imponente avente conseguenze nelle relazioni sindacali nel settore dell’autotrasporto (sentenza 341).
1.4. Leggi di delegazione e decreti legislativi
È ammissibile, come più volte affermato in passato, il ricorso alla delegazione legislativa per l’introduzione di nuove norme penali, sulla base dell’equiparazione fra legge e atti aventi forza di legge ai fini del rispetto della riserva di cui all’art. 25 Costituzione. “Il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide, ma, in ogni modo, esso non ha a che vedere con le esigenze di determinatezza della norma incriminatrice, nella specie soddisfatte dalla formulazione del D.Lgs” (ordinanza 134). Peraltro, nelle materie coperte da riserva assoluta di legge, come quella dell’art. 25, l’esistenza della delega non può essere desunta dalla mera “connessione” con l’oggetto della delega stessa (nel caso deciso con la sentenza 212, la delega aveva a oggetto le spese di giustizia, mentre il D.Lgs disciplina la materia delle pene pecuniarie).
Riguardo alla delega per il conferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali, la Corte riafferma che “che il riferimento a ‘clausole generali’, come quelle relative agli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall’indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l’area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo” (sentenza 125).
Quando si tratta di leggi che delegano il governo ad attuare direttive comunitarie afferenti a molteplici materie, elevato è il rischio che i principi e criteri direttivi risultino “di non facile interpretazione”. Da qui l’invito al legislatore “affinché impieghi formule [il più possibile] precise” (ordinanza 134).
Per quanto riguarda il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, esso “si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, tenendo conto delle finalità che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e tenendo altresì conto che le norme delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi e criteri, in quanto la delega legislativa non fa venir meno ogni discrezionalità del legislatore delegato, che risulta più o meno ampia a seconda del grado di specificità dei principi e criteri fissati nella legge delega; sicché, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali – più o meno ampi – margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia ad essa rispondente” (sentenza 199; così anche sentenze 25 e 125).
L’art. 76 Costituzione non elimina ogni margine di scelta nell’esercizio della delega: esso “non osta all’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante; va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera ‘scansione linguistica’ delle previsioni dettate dal delegante, essendo consentito al primo di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di ‘riempimento’ che lega i due livelli normativi, rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata” (sentenza 199).
In ordine alla delega per la “revisione” e il “riordino” della legislazione concernente la circolazione stradale, la Corte ribadisce che tali intenti, “in quanto possono comportare l’introduzione di innovazioni della preesistente disciplina, esigono la previsione di principi e di criteri direttivi, idonei a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo”; pertanto, una previsione contenuta nel decreto delegato in assenza di una direttiva del legislatore delegante rappresenta una innovazione sostanziale, in violazione dell’art. 76 Costituzione (sentenza 239).
Circa una delega mirata al “coordinamento” delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province, la Corte puntualizza che “coordinare (non solo formalmente) vuol dire…anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui ratio originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore” (sentenza 220).
1.5. Norme di attuazione degli statuti speciali
La riserva di competenza in favore delle norme di attuazione degli statuti speciali, che non possono essere modificate con legge ordinaria, ma solo secondo la procedura appositamente prevista dagli statuti, è affermata, a seguito della legge costituzionale 2/1993, anche con riferimento alla regione Valle d’Aosta (che fino a tale data non disponeva di norme di attuazione). A maggior ragione le norme di attuazione non possono subire deroghe da parte di regolamenti, sia pure di delegificazione (sentenza 38).
1.6. Regolamenti statali
Nel caso di regolamenti di delegificazione, la Corte ha ribadito che, qualora il regolamento vada oltre i limiti della materia su cui è abilitato a disporre, la clausola abrogatrice delle norme di leggi anteriori resta inoperante, non perfezionandosi pertanto la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo con quelle di natura secondaria. Spetta comunque ai giudici rimettenti valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di “delegificazione” (sentenza 239).
1.7. Diritto comunitario
I principi enunciati nelle decisioni della Corte di giustizia, rese nell’ambito del giudizio a seguito di rinvio pregiudiziale disciplinato dall’art. 234 del Trattato, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti entro i quali la norma nazionale conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale (ordinanza 62, che riprende la precedente 255/99 e la sentenza 113/85, che aveva affermato la diretta applicabilità delle sentenze interpretative della Corte di giustizia).
1.8. Diritto internazionale
Scarse sono, nell’anno 2003, le pronunce che contengono riferimenti espliciti al diritto internazionale. Si segnala la sentenza 149 sul processo minorile, nella quale si evocano, per sostenere la tutela del preminente interesse del minore ad una rapida uscita dal processo, accanto all’art. 31 Costituzione, “i principi enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia, a cui questa Corte si è ripetutamente richiamata”.
1.9. Aspetti di drafting dei testi normativi
Un significativo cenno in ordine alle tecniche di redazione dei testi normativi è contenuto nella sentenza 314, relativa a una legge della regione siciliana, che la Corte afferma essere formulata “come di consueto ma non perciò meno reprensibilmente, attraverso multipli rinvii che ne rendono impossibile la diretta percezione del significato”. Questo rilievo colloca la decisione nella linea giurisprudenziale propria di altre Corti, che considerano costituzionalmente illegittime, in quanto in violazione del principio di certezza del diritto, le formule legislative che valgono a dissimulare la portata normativa.
Diritti e doveri dei cittadini
Il principio di eguaglianza
L’art. 3 Costituzione compare, quale parametro, nella maggior parte delle ordinanze di rimessione. Attraverso la sua invocazione, si lamenta quello che è stato definito il vizio della arbitrarietà della legge. Conseguenza dei limiti generali che attengono al modo stesso di percepire il diritto e la funzione legislativa, in esso rientrano, si è detto, tutti i casi di “leggi contro la natura del diritto”. Analoghi criteri di valutazione della costituzionalità delle leggi si rinvengono in tutti i sistemi di giustizia costituzionale.
All’interno di questo tipo di vizio si possono distinguere diversi modi d’essere del vizio di arbitrarietà, cui conseguono differenti tecniche di giudizio, come mostra la giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003.
La prima manifestazione dell’arbitrarietà è l’irrazionalità: l’imperativo di razionalità impone al legislatore di equiparare il trattamento giuridico di situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare il trattamento delle situazioni diverse. Il giudizio assume uno schema ternario, ove accanto alla norma da valutare e al parametro costituzionale costituito dall’art. 3 si colloca il tertium comparationis, ovvero la norma che, usata come pietra di paragone, consente di cogliere la “rottura” logica dell’ordinamento.
Il controllo sull’irrazionalità della legge si distingue da quello sull’irragionevolezza. Anche il controllo sull’irragionevolezza presuppone differenze di disciplina giuridica, e quindi l’esistenza di un termine di paragone. Ma, diversamente dal controllo sulla irrazionalità, nel controllo di irragionevolezza entra un principio costituzionale di sostanza, il quale consente di apprezzare la rottura dell’ordinamento costituzionale operata eventualmente dalla legge oggetto del giudizio.
Molteplici decisioni sono riconducibili a questi due tipi di giudizio.
Nella prima categoria, possiamo collocare le pronunce secondo le quali le differenziazioni denunciate si giustificano, o si censurano, in ragione della disomogeneità, o della omogeneità, delle situazioni messe a raffronto. Ad esempio, è stata dichiarata infondata la questione relativa all’assenza della incompatibilità tra la carica di sindaco e l’ufficio di primario di divisione del locale ospedale, pur essendo tale incompatibilità prevista per i direttori amministrativo e sanitario della Usl: il tertium comparationis non è idoneo, “poiché non sussiste certo omogeneità di posizioni fra titolari degli uffici preposti alla gestione dell’azienda Usl e dipendenti di questa con compiti tecnico-sanitari, come i primari” (sentenza 220). Si parla, espressamente, di “assenza di violazione dell’art.3 per aver diversamente disciplinato sul piano sostanziale situazioni diverse” nella sentenza 70, nella quale sono messe a raffronto la situazione del traente bancario adempiente nel “termine di grazia” e quella del debitore cambiario adempiente nel termine “di grazia”. La diversità di situazioni è sottolineata anche nella sentenza 71, ove si compara la limitazione posta alla responsabilità del vettore marittimo nel trasporto nazionale con la disciplina della responsabilità nel trasporto internazionale (sulla non omogeneità delle situazioni messe a raffronto v. anche ordinanza 368). Si possono collocare in questo contesto anche la sentenza 345, nella quale si censura la diversità di trattamento (quanto ad agevolazioni fiscali) tra gli immobili di interesse storico e artistico appartenenti a privati, e gli immobili di interesse storico e artistico appartenenti a enti pubblici o a persone giuridiche private, nonché la sentenza 211, che censura la disparità di trattamento tra la posizione di chi debba procedere in executivis nei confronti di un ente locale e quella di chi proceda, invece, nei confronti di una azienda sanitaria.
Nella seconda categoria di giudizi si possono collocare le decisioni nelle quali la differenziazione trova (o non trova) una giustificazione in specifici valori costituzionali che si ritengano degni di tutela e sono invece ignorati dal rimettente. Ad esempio, i benefici tributari riconosciuti ai proprietari di immobili locati di interesse storico o artistico (e non ai proprietari di immobili non vincolati) trovano giustificazione in considerazione degli obblighi gravanti su tali proprietari come riflesso della tutela costituzionale dei beni che discende dall’art. 9, comma 2, Costituzione (sentenza 346). Invece, non è giustificata la differente disciplina, quanto alla concessione della detenzione domiciliare, prevista per la madre di figlio minore e per la madre di figlio totalmente handicappato, tenuto conto dei principi costituzionali che impongono di tutelare lo sviluppo della personalità di quest’ultimo (sentenza 350, citata amplius infra). Riconducibile a questo ambito è anche la sentenza 104, con la quale si dichiara incostituzionale la norma (art. 45, comma 1, D.Lgs 151/01) che prevede che anche i genitori adottivi, così come quelli naturali, possano fruire dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino: infatti, precisa la Corte, “perché l’applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione”. A base di questa decisione, che sembra configurare un giudizio di mera razionalità, è dato rintracciare i valori costituzionali cui i riposi giornalieri sono preordinati, in quanto questi “oggi non hanno più l’originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche, come questa Corte ha già più volte affermato…, ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità”. Un giudizio di ragionevolezza è anche quello compiuto con la ordinanza 108. La Corte, chiamata ad estendere la disciplina prevista nella norma impugnata anche al maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali, afferma che “il ricorso all’incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie di cui all’art. 392, comma 1, Cpp, nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente”.
Un terzo livello di sindacato è stato definito giudizio “di giustizia” o di “intrinseca irragionevolezza”. Questo giudizio prescinde dal carattere ternario, dalla comparazione tra norme, per assumere la forma del controllo della adeguatezza della legge rispetto al caso regolato. Significativa è, al riguardo, la sentenza 185, che giudica “irragionevole” la compressione di un diritto (si trattava del diritto di proprietà) in nome di un valore costituzionalmente tutelato (la tutela dei beni culturali), in quanto la misura limitativa è stata ritenuta eccessiva ed esuberante rispetto alla finalità perseguita, che già poteva ritenersi soddisfatta da altre previsioni contenute nell’ordinamento. La arbitrarietà, in altri termini, deriva dalla assenza di giustificazione ex se dell’eccesso di tutela. Si potrebbe altresì richiamare, al riguardo, l’ordinanza 84, nella quale la mancanza di un doppio grado di giurisdizione di merito per motivi di fatto in materia di pensioni non è considerata arbitraria e incongruente, trovando giustificazione nelle specificità di questo tipo di giudizio, in quanto le questioni di fatto ben possono trovare una adeguata trattazione nel corso del previo procedimento amministrativo. Un giudizio di giustizia è rintracciabile anche nella “intrinseca irragionevolezza” della normativa sui riposi giornalieri dei genitori adottivi censurata (insieme alla diseguaglianza di cui si è detto supra) con la sentenza 104. Questo tipo di controllo di costituzionalità spiega il ricorso a una sentenza sostitutiva, nella quale si dichiara la incostituzionalità della norma “nella parte in cui prevede che i riposi…si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, ‘entro il primo anno di vita del bambino’ anziché ‘entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia’”. Le esigenze che i riposi sono volti a tutelare, infatti, impongono una disciplina “adeguata al caso”, ovvero ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino.
Un richiamo all’eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, è contenuto nella sentenza 350, relativa alla possibilità della detenzione domiciliare per la madre di un figlio portatore di grave handicap, indipendentemente dall’età di quest’ultimo. La Corte, dopo aver sottolineato il particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto disabile, la cui salute psico-fisica può essere notevolmente pregiudicata dall’assenza della madre, afferma che “la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all’impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità”.
2.2. Diritti inviolabili
Nel campo della tutela risarcitoria del danno alla persona, la Corte ha invitato il giudice rimettente a una lettura conforme a Costituzione dell’art. 2059 del Cc, da interpretare “nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge”. A tal fine si richiama la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, nella quale viene affermata “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 Cc, tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Costituzione); sia infine il danno (spesso definito in dot trina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (sentenza 233).
La necessità che la disciplina sul mobbing sia orientata alla salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore sul luogo di lavoro (artt. 2 e 3, comma 1, Costituzione) è affermata dalla sentenza 359.
2.3. Libertà personale
Riguardo alle misure cautelari la Corte, chiamata a scrutinare la norma (art. 284, comma 5-bis Cpp) che preclude la concessione degli arresti domiciliari nei confronti di persona condannata per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, ha ribadito quanto già affermato in precedenti decisioni: “mentre la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l’an della cautela) comporta, per definizione, l’accertamento, di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza – non può invece ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l’apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta come necessaria (il quomodo della cautela): ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti” (ordinanza 130).
Peraltro, si riafferma che “la determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali, nelle quali è consentito adottare misure custodiali – tanto più nei confronti dei minori, per i quali vale un criterio di ulteriore assoluta eccezionalità – spetta al legislatore, ai sensi dell’art. 13 della Costituzione, nel rispetto degli altri principi costituzionali e nei limiti della non manifesta irragionevolezza”; di conseguenza, la mancata previsione della misura nei confronti di minori per il delitto di furto (salve limitate eccezioni) non è irragionevole: rispecchia una scelta legislativa e non è in contrasto con norme costituzionali da cui si debba, in ipotesi, desumere la necessità di prevedere una misura custodiale (ordinanza 137).
Autonomia dei privati
Il tema dell’autonomia statutaria e gestionale delle persone giuridiche private è affrontato dalla sentenza 301, relativa alla nuova disciplina delle fondazioni di origine bancaria, avuto riguardo, come parametri, agli artt. 2, 18 e 41 Costituzione (per quest’ultimo profilo, v. infra). In primo luogo, si afferma che “le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da ‘uno scopo’ che ne impronta l’attività (v. artt. 16 e 27 del Cc)”. Al contrario, la norma che accorda “all’Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati”. La Corte afferma anche che “la destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l’ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni”, e che debbono essere interpretate in modo restrittivo (come limitate alla banca conferitaria e alle società con essa in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo) le norme sulle incompatibilità dei componenti degli organi della fondazione, in quanto, in caso contrario, sarebbe ingiustificatamente compressa, secondo quanto rilevato dai rimettenti, “la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione”.
Libertà religiosa
L’esercizio del diritto di professare la propria religione può essere limitato, così come altri diritti, quali la libertà personale o quella di circolazione e soggiorno, in conseguenza di misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Occorre tuttavia che “il legislatore eserciti la sua discrezionalità in modo equilibrato, per ‘minimizzare’ i costi dell’attività di prevenzione, cioè per rendere le misure in questione, ferma la loro efficacia allo scopo per cui sono legittimamente previste, le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali coinvolti. Infatti, nella configurazione di tutte le misure limitative della libertà della persona, e dunque anche delle misure di prevenzione, l’esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigenze in vista delle quali essa sia legittimamente prevista e disposta”.
Nel caso del diritto di libertà di culto in forma associata non è possibile quel contemperamento tra opposte esigenze che la legge ha realizzato in nome del diritto alla salute (per cui il giudice, caso per caso, può consentire l’allontanamento dal comune al fine della sottoposizione a cure del prevenuto): “la sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per consentire la partecipazione periodica e continuativa a cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, come risulta evidente sia dalla circostanza che l’autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta la durata della misura, sia dall’ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di pubblica sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose…D’altro canto, una volta considerato che la lamentata restrizione all’esercizio della propria professione di fede religiosa è condizionata da una situazione di fatto – la limitata diffusione sul territorio dell’organizzazione ecclesiastica – non si può escludere che, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, l’obbligo di soggiorno sia fissato, in conformità con la richiesta dell’interessato, in un comune dove tale organizzazione esista e nel quale la persona sottoposta alla misura di prevenzione vada a fissare la propria residenza” (sentenza 309).
Libertà di informazione
La garanzia del pluralismo nel servizio radiotelevisivo viene in rilievo nella sentenza 312, avente ad oggetto una legge della provincia di Bolzano, impugnata dal governo in via principale. In particolare, ad avviso del ricorrente, l’art. 21 Costituzione sarebbe stato leso dalla norma che consente alla provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi senza fornire alcuna garanzia circa i programmi oggetto di dette convenzioni. La Corte ha ritenuto sufficiente a garantire il pluralismo la possibilità che il comitato provinciale per le comunicazioni (“organo consultivo della Provincia per tutte le attività previste ai fini di un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo ‘libero e pluralistico’”) esprima parere sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione. La medesima sentenza richiama anche il consolidato orientamento della Corte, secondo il quale “l’informazione esprime non tanto una materia, quanto ‘una condizione preliminare’ per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa” (così già sentenza 29/1996).
Prestazioni patrimoniali imposte
Della riserva di legge dell’art. 23 Costituzione, riferibile anche alle norme procedimentali che disciplinano gli accertamenti presuntivi, è stato riaffermato il carattere relativo, in quanto la norma costituzionale “pone al legislatore l’unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa” (sentenza 105).
Il contributo di solidarietà posto a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo tetto (art. 37 della legge 488/99) non ha natura tributaria, dovendosi inquadrarlo nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, in quanto costituisce una prestazione patrimoniale avente la finalità di sostenere gli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. La previsione di contributi di solidarietà è scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, in quanto operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall’art. 2 della Costituzione, attraverso l’imposizione di un’ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori superiori a un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale (ordinanza 22).
Diritto di azione e di difesa. Giusto processo
Numerose sono, anche nel 2003, le decisioni in tema di diritto di difesa (art. 24) e di diritto a un giusto processo (art. 111) (si vedano anche, oltre a quelle richiamate infra, le ordinanze 143, 183, 225, 273, 355 e la sentenza 284).
Innanzitutto, viene ribadita la discrezionalità di cui gode il legislatore nella regolamentazione dei diversi istituti processuali e nella previsione di forme differenziate di garanzia con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio, nel rispetto del criterio della ragionevolezza (ordinanze 84 e 286, sentenza 203).
Su tale base, sono state rigettate questioni basate unicamente sulla comparazione tra procedimenti: ad esempio, quella relativa alle differenze esistenti tra il procedimento cui può ricorrere l’ente locatore nel caso di morosità dell’inquilino nelle locazioni di edilizia residenziale pubblica e il procedimento cui possono ricorrere i locatori nelle comuni locazioni abitative (sentenza 203).
La discrezionalità del legislatore è richiamata anche riguardo alla scelta del regime di procedibilità: questa scelta “coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità”. In tale prospettiva, la scelta di prevedere la perseguibilità d’ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime), e non anche in rapporto ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 345, comma 1, Cpp), “si risolve in un’opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale: e ciò tanto più a fronte della circostanza che, nel primo caso, viene in rilievo un interesse, quale quello alla tutela del lavoro, che è oggetto di particolare considerazione da parte della stessa Costituzione” (ordinanza 178).
Nell’ordinanza 287, relativa alla omessa previsione di un generale obbligo, in capo al pubblico ministero, di ottemperare alla richiesta di specifici atti di indagine avanzata dall’indagato nella fase delle indagini preliminari, con il correlato obbligo di motivare l’eventuale rigetto della richiesta (art. 415bis Cpp), precisato trattarsi di scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, si ribadisce che “il diritto di difesa – garantito oltretutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva – è conformato diversamente dal legislatore nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell’esercizio dell’azione penale e l’attività di formazione della prova, quest’ultima propria della fase dibattimentale” (nello stesso senso, ordinanze 8 e 352).
Con specifico riferimento all’art. 111 Cost, riguardo al procedimento per decreto (art. 459 Cpp), la Corte afferma che “il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso; dall’altro non esclude che il diritto dell’indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell’accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi”. In particolare, nel procedimento per decreto, “ove venga proposta opposizione, il contraddittorio tra accusa e difesa si esplica da quel momento in modo pieno, con le medesime modalità e garanzie previste nel procedimento ordinario, in un contesto in cui la notificazione del decreto viene a svolgere la mera funzione di informazione dei motivi dell’accusa”.
Sotto il profilo della parità delle parti nel processo penale, l’art. 111 è stato evocato dai rimettenti anche in relazione alle spese, “non potendosi dire quel principio osservato se l’imputato, ingiustamente sottoposto a procedimento penale, dovesse restare gravato di tutti gli oneri della propria difesa”. La Corte ha respinto tale rilievo, affermando, da un lato, che dai lavori preparatori “con nettezza risulta che il principio della parità delle parti trova la sua concretizzazione nell’eguale diritto alla prova e nella regola che questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi, essendovi invece, a questo riguardo, nel processo penale una naturale asimmetria che può essere bensì attenuata ma non eliminata, collegata, come è, allo jus puniendi che solo allo Stato può spettare”; dall’altro, che “nel processo penale, atteso l’ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell’azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra l’esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e l’aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale di vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall’uso illegittimo di quella potestà”. Per cui, “la condanna dello Stato al pagamento delle spese processuali non è soluzione imposta dalla Costituzione: non irragionevolmente il legislatore ha bilanciato le contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità conseguenti all’esercizio dell’azione penale e più in generale dell’attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave” (ordinanza 286).
Il principio di parità tra accusa e difesa è al centro anche dell’ordinanza 110, ove si afferma che “esso – pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 – non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, giacché una diversità di trattamento può essere, come nella specie, stabilita ragionevolmente, nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero e degli ausili strutturali di cui, ratione officii, può avvalersi”. Analoga la premessa della pronuncia nella quale si è negato che il principio in questione fosse violato dalla norma (art. 582, comma 2, Cpp) che “consente soltanto alle parti private ed ai difensori – e non anche al pubblico ministero – di presentare l’atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato”. Infatti, tale previsione, “si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e status che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall’altro, potendosi questi ultimi avvalere delle strutture del proprio ufficio e risultando, dunque, in concreto agevolati nella presentazione, eventualmente anche a mezzo di incaricato, dell’atto di impugnazione” (ordinanza 110).
Sul principio del giusto processo ritorna l’ordinanza 251 (relativa alla norma secondo la quale l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v’è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall’invio all’assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato: art. 22 legge 990/69): “anche dopo la novella dell’art. 111 Costituzione, il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale, giacché la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto ‘ragionevole’, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia…, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Costituzione, comprensivo anche del diritto di non essere inutilmente chiamato in giudizio”. D’altra parte, “l’art. 24 Costituzione, non comporta necessariamente l’assoluta immediatezza dell’esperibilità del diritto di azione”.
Viene riaffermata, in riferimento alla nuova disciplina del procedimento di liberazione anticipata (art. 69bis legge 354/75), “la piena compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum” (ordinanza 352).
Per irragionevole limitazione del diritto di difesa è dichiarata l’incostituzionalità sia dell’art. 438, comma 6, sia dell’art. 458, comma 2, Cpp, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Tale pronuncia, ai sensi dell’art. 27 della legge 87/1953, è estesa, negli stessi termini, all’art. 464, comma 1, secondo periodo, Cpp, in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall’opponente a decreto penale (sentenza 169).
Quanto alla tutela del principio di imparzialità-terzietà del giudice, l’art. 111 – è stato ribadito – “non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione…; sicché meramente nominalistico appare l’argomento che, in senso contrario, vorrebbe dedursi dalla locuzione “giudice terzo e imparziale”, quasi che essa sia espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale e non già la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l’ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla res iudicanda” (sentenza 240). Su tale base, si afferma che “certamente contraria – ma altrettanto certamente già prima della legge costituzionale 2/1999 – al principio di imparzialità-terzietà è la fusione, in un unico soggetto, delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda, ma [che] ciò non implica la costituzionalizzazione del processual-civilistico principio della domanda e il bando di qualsiasi iniziativa officiosa”. Infatti, “l’iniziativa officiosa – prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell’officiosità dell’iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti”: ciò che avviene negli artt. 6 e 8 della legge fallimentare.
L’assenza di “un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito” è ribadita dall’ordinanza 84, “non inerendo tale istituto alla garanzia del diritto di difesa, sicché il legislatore può diversamente strutturare il giudizio di appello”; infatti, “la garanzia della difesa si realizza non tanto con la duplicità della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse”.
Il rischio che “l’indiscriminata estensione a tutte le cause civili del criterio di competenza introdotto dall’art. 11 Cpp [circa la competenza, per i procedimenti che vedono coinvolti magistrati, del giudice di altro distretto] sia suscettibile di risolversi – con riferimento a singole tipologie di controversie – nel sacrificio di interessi e valori costituzionalmente rilevanti”, è riaffermato dalla Corte, peraltro in una pronuncia, già citata, di inammissibilità, avendo il remittente chiesto una sentenza additiva in materia dove il legislatore deve fare uso dei suoi poteri discrezionali, apprezzando i caratteri dei diversi, possibili casi (sentenza 332).
In nome del diritto di difesa del contribuente è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma (art. 60, ultimo comma, d.P.R. 600/73) che prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica; “il legislatore – ha stabilito la Corte – può, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa”.
Alcune pronunce richiamano l’art. 112 Costituzione, evocando principi pacificamente affermati nella precedente giurisprudenza. Così, si afferma che “la citata norma costituzionale — stabilendo che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale — non esclude che l’ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa” (ordinanza 178), e che “il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio della azione penale” (ordinanza 110).
Un’unica decisione torna sull’art. 34, comma 2, Cpp, in materia di incompatibilità del giudice. Era stata denunciata la mancata previsione della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero qualora, nel corso del procedimento, lo stesso giudice abbia in precedenza applicato una misura cautelare personale nei confronti della medesima persona sottoposta alle indagini. In tal caso, peraltro, non ricorre – ad avviso della Corte – la sovrapposizione tra giudizi svolti da uno stesso giudice, inammissibile in base al principio del giusto processo, non potendosi ritenere “giudizio” la decisione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a prendere in tema di archiviazione, data la natura interlocutoria e sommaria (ordinanza 54).
Pene e misure di sicurezza
Anche nel 2003 la Corte ha adottato una di quelle pronunce, numerose negli ultimi anni, attraverso le quali si correggono o si eliminano automatismi legislativi, per dare spazio all’apprezzamento della situazione concreta da parte del giudice, con la conseguente possibilità per il giudice stesso di adottare diverse determinazioni nell’ambito delle previsioni legali come unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali (in particolare con riguardo all’esigenza di flessibilità e di individualizzazione della risposta penale nei confronti di soggetti minori).
Nella sentenza 253 è dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma (art. 222 Cp) che imponeva al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto comportante una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dell’imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo più lungo in relazione all’entità della pena edittale prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità sociale. La legge censurata, infatti, “adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un’unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare, questo tipo di fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dell’infermo”. La sentenza afferma che “mentre solo il legislatore…può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l’accennato automatismo, consentendo che, pur nell’ambito dell’attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato”.
In un’altra decisione (sentenza 135) si ribadisce che il principio rieducativo enunciato nell’art. 27, comma 3, Costituzione, non è violato dalla norma (art. 4bis, comma 1, legge 354/75, sull’ordinamento penitenziario) che subordina alla collaborazione con la giustizia l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati alla pena dell’ergastolo per alcuni delitti. Trattandosi, infatti, di “collaborazione oggettivamente esigibile” e, pertanto, rimessa alla scelta del condannato, la norma “non impedisce in maniera assoluta e definitiva l’ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia”.
Né il principio dell’art. 27, comma 3, Costituzione è violato dalla norma (art. 51bis legge 354/75) che, nel caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, impone al Tribunale di sorveglianza, ai fini della decisione sulla prosecuzione o sulla cessazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, di tenere conto in ogni caso del limite di pena di ancora da espiare stabilito nella misura di tre anni dall’art. 47, comma 1, del medesimo ordinamento per l’ammissione al beneficio, e non gli permette di valutare se permangano le condizioni per proseguire il percorso di rieducazione e di recupero sociale già avviato con la concessione della misura. Infatti, “in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, la nuova disciplina tiene conto dell’esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l’entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando la condizione generale di ammissibilità dell’affidamento in prova rappresentata dal limite di pena ancora da espiare” (ordinanza 139).
Sulla detenzione domiciliare è intervenuta la sentenza 350, che ha ritenuto in contrasto con il principio di ragionevolezza la norma (art. 47ter, comma 1, lettera a, legge 354/75) che “prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l’esistenza delle condizioni necessarie per un’effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante”. Le situazioni messe a raffronto, ritenute “analoghe ed equiparabili fra loro” sono “quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci” (sentenza 350).
La discrezionalità del legislatore nel modulare le scelte punitive e nello stabilirne la misura, costantemente affermata dalla giurisprudenza costituzionale, è ribadita: “uno scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile soltanto ove l’opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’assoluta arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza”. Di conseguenza, non è irragionevole un diverso trattamento del reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro rispetto a quello di omesso versamento delle ritenute fiscali del datore di lavoro quale sostituto d’imposta: infatti, “il mancato adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1, 4, 35, 38 della Costituzione)” (ordinanza 206).
Il tema della determinatezza della fattispecie penale viene in rilievo nella ordinanza 347, in materia di definizione di armi da sparo. La Corte riafferma che “il principio di determinatezza dell’illecito penale — che il giudice a quo, pur senza evocare l’art. 25, secondo comma, Costituzione, pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure — non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto (definizione che rischierebbe di risultare comunque non esaustiva)”. Ciò che il rimettente lamentava, in realtà, altro non era che “un profilo attinente all’ordinaria verifica circa la rispondenza del fatto al modello legale tipico, che spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione”.
2.10. Tutela della famiglia, della maternità e del minore
L’art. 30 Costituzione non ammette un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi. Sulla base di tale principio, molte volte affermato dalla Corte, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86, nella parte in cui non esenta dall’imposta di registro i provvedimenti di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario. La Corte sottolinea che “la mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell’esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell’altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale”. Tra l’altro, “l’esenzione, seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta” (sentenza 202).
Peraltro, viene ribadito che “la convivenza more uxorio, basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile, presenta caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l’automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento” (ordinanza 204).
Tre pronunce intervengono sul tema dell’adozione.
Innanzitutto, va citata la già richiamata sentenza 104, che effettua un’ampia ricostruzione della evoluzione normativa e giurisprudenziale degli istituti a protezione della maternità e del minore, per giungere a stabilire che, in caso di adozione ed affidamento, i genitori possano godere dei riposi giornalieri, indipendentemente dall’età del bambino, nel primo anno dal suo ingresso nella famiglia (anziché, come avviene per i genitori naturali, nel primo anno di vita del bambino).
Quanto all’adozione di maggiorenni, la Corte ha ritenuto di non poter estendere al caso di adozione di maggiorenne da parte di soggetto che ha figli minori la ratio di precedenti decisioni, volte a superare il divieto di adozione di maggiorenni per chi avesse figli maggiorenni, ma incapaci di esprimere la loro volontà (ordinanza 170).
Riguardo all’adozione internazionale, è stata dichiarata incostituzionale la disposizione (art. 72 D.Lgs 151/01) che non consentiva alle libere professioniste, a differenza di tutte le altre lavoratrici, di percepire l’indennità di maternità nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato nella famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di età. “Le ragioni che hanno indotto il legislatore…a superare il limite dei sei anni di età per il trattamento di maternità nell’adozione internazionale, come risulta dalla relazione al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja, – si afferma – sono essenzialmente individuabili nella valutazione relativa alle difficoltà derivanti dall’inserimento dei minori stranieri nella comunità familiare ed in quella scolastica, che aumentano in modo esponenziale con il crescere dell’età, richiedendo soprattutto nei primi tempi “un’assistenza particolare da parte dei nuovi genitori”. Le medesime ragioni ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall’attività lavorativa dei genitori adottanti: di conseguenza, la limitazione del diritto delle libere professioniste non solo è priva di autonoma ratio, ma urta in modo stridente con i principi costituzionali che impongono la tutela del minore” (sentenza 371).
In tema di minori stranieri, la Corte sostiene che una lettura meramente letterale della norma (art. 32, comma 1, D.Lgs 286/98) che consente ai soli minori dati in affidamento (ma non a quelli sottoposti a tutela) di ottenere, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno, “condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza”, invitando pertanto il rimettente ad optare per la soluzione interpretativa che renda la disposizione conforme a Costituzione (sentenza 198).
Quanto al processo minorile, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 27, comma 4, del d.P.R. 448/88, “nella parte in cui prevedeva che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto potesse essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo”. Alla luce “dell’art. 31, secondo comma, Costituzione e dei principi enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia… – afferma la Corte – la tutela del preminente interesse del minore non può essere fatta meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal procedimento”, ma richiede che l’estromissione la più possibile sollecita dal circuito processuale non sacrifichi l’esigenza di garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova in dibattimento. L’obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale non esclude cioè che debba comunque essere adottata la decisione a lui più favorevole, ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento. “La disciplina censurata – prosegue la sentenza – non contempera tali esigenze, posto che, se gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento emergono solo in dibattimento, o se l’imputato non ha potuto beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nell’udienza preliminare, l’unica alternativa alla pronuncia di una sentenza di condanna è, come emblematicamente dimostrato dalla vicenda oggetto del giudizio a quo, il proscioglimento dibattimentale per concessione del perdono giudiziale. Ma tale esito, che presuppone un’affermazione di colpevolezza, realizza un livello di tutela dell’imputato minorenne certamente inferiore rispetto a quello assicurato dal proscioglimento per irrilevanza del fatto, i cui effetti processuali e sostanziali sono di gran lunga più favorevoli” (sentenza 149).
Circa la composizione del tribunale per i minorenni, la Corte non ha reputato che la sostituzione integrale della componente togata con magistrati del tribunale ordinario metta in pericolo la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione. Infatti, “le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, nonché dall’apporto di altri operatori che ne preparano o fiancheggiano l’attività e dalle specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile” (ordinanza 330).
2.11. Tutela della salute
Il diritto alla salute è oggetto di alcune sentenze emesse nel giudizio in via principale.
La tutela della salute è, dopo la riforma del Titolo V, una materia di competenza legislativa concorrente, nella quale intervengono Stato e regioni. Tuttavia, la salute della persona è ritenuta un “bene che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali” (così la sentenza 361, sul c.d. “fumo passivo”, su cui v. amplius infra). Inoltre, “interventi legislativi regionali…sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di – o in difformità da – determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola regione”. Peraltro, “la valutazione di illegittimità di norme regionali tendenti a vincolare le scelte terapeutiche non equivale in alcun modo al riconoscimento della liceità di pratiche (quali, in ipotesi, gli interventi di c.d. psicochirurgia) delle quali possa essere messa in discussione la natura stessa di terapie piuttosto che di interventi soltanto lesivi dell’integrità dei pazienti, e che, in questa seconda ipotesi, rientrerebbero nell’ambito di previsione di generali divieti” (sentenza 338).
Due pronunce intervengono in materia di farmacie.
La legge regionale che stabilisce limitazioni di orario, turni e ferie per le farmacie tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell’utilità sociale) e l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico. La Corte, richiamando un proprio precedente in materia (sentenza 446/88), ha ribadito che “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere con il contingentamento delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d’utenza) vanno nello stesso senso di quelle che si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto, come è stato più volte osservato, l’accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie. Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore, un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico considerato nel suo complesso” (sentenza 27).
Inoltre, la Corte ritiene irragionevole la mancata previsione, per le farmacie comunali, del regime delle incompatibilità stabilito per l’attività del singolo farmacista privato: infatti, il divieto in questione “è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute” (sentenza 275).
Secondo l’ordinanza 130, poi, non viola l’art. 32 Costituzione la norma (art. 284, comma 5bis, del Cpp) per la quale non possono essere concessi gli arresti domiciliari nei confronti di chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, anche se, come nel caso di specie, trattasi di soggetto affetto da HIV e tossicodipendente, in quanto “l’art. 275 Cpp, …delinea un ‘sistema’ cautelare specifico nei confronti delle persone che versino in condizioni di salute particolarmente gravi, predisponendo un regime di particolare dettaglio per quanti siano affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria, al fine di pervenire ad un articolato bilanciamento fra le plurime esigenze coinvolte e le misure applicabili nella specie; cosicché, configurandosi tale peculiare normativa come disciplina speciale per quelle categorie di soggetti, essa è certamente destinata a prevalere rispetto alla previsione dettata dalla norma oggetto di impugnativa”.
Il diritto alla salute viene in rilievo anche nella citata sentenza 253, con la quale è dichiarato incostituzionale l’art. 222 Cp (v. supra). Si afferma infatti che “per l’infermo di mente l’automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione”.
2.12. Diritto al lavoro e giusta retribuzione
In materia lavoristica, meritano di essere segnalate due decisioni che confermano precedenti sentenze.
Innanzitutto, quanto al temporaneo svolgimento di mansioni superiori, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo la quale il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione, richiede che “il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. In altri termini, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l’automatica applicazione del corrispondente trattamento economico, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni lavorative effettuate”. Pertanto, non è incostituzionale la legge regionale che ha riconosciuto ai soggetti, che, pur appartenendo ad altra qualifica, hanno svolto temporaneamente funzioni apicali, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni. Tanto più che essa “ha riconosciuto il diritto ad un compenso aggiuntivo, costituito dalle indennità accessorie spettanti per l’esercizio di funzioni dirigenziali, garantendo così, almeno nel minimo essenziale, l’attuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità del lavoro prestato” (sentenza 115).
Quanto al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, nel caso di crediti di lavoro, la Corte ne aveva dichiarato con la sentenza 459/00 l’incostituzionalità limitatamente ai rapporti di diritto privato. Chiamata ad estendere la portata di tale decisione anche ai rapporti di lavoro pubblico (art. 22, comma 36, legge 724/94), essa, pur confermando i principi cui si era ispirata, ha ritenuto la questione non fondata. “La materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non è estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, giacché la puntualità della corresponsione del dovuto concorre, insieme alla congruità del suo ammontare, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita. Questo…non significa [però] affatto che il meccanismo del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui al terzo comma dell’art. 429 Cpc, debba ritenersi principio costituzionalizzato. Vuol dire solamente che il legislatore è libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un’effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti”. Inoltre, si fa rilevare che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione – relativamente al rapporto di lavoro privato – risultava decisivamente fondata sulla constatazione che la norma impugnata poteva incentivare l’inadempimento del datore di lavoro, consentendogli di lucrare (con investimenti finanziari, pur privi di rischio) l’eventuale differenziale tra il rendimento dell’investimento ed il tasso di svalutazione. Siffatta ratio decidendi non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. La pubblica amministrazione infatti conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare…, sotto il profilo…della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”. Tanto più che “la norma impugnata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno e lo esonera dall’onere della relativa prova” (sentenza 82).
2.13. Previdenza e assistenza
Varie pronunce si occupano, senza introdurre particolari elementi di novità rispetto al passato, dei trattamenti previdenziali.
Di solito, tra i parametri invocati, accanto all’art. 38 Costituzione, compare anche l’art.3, sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza. Ad esempio, si afferma che “non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato “alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore” e che “la scelta del legislatore appare … giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico” (ordinanza 162; in questo senso anche ordinanza 121).
Chiamata a controllare la costituzionalità della norma (art. 11, comma 2, legge 223/91) che, ai fini del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per infortunio sul lavoro o per malattia, la Corte ha rilevato che l’art. 38 Costituzione non è violato, “in quanto l’ordinamento previdenziale prevede, per la disoccupazione involontaria nel settore edilizio, sia il trattamento ordinario di disoccupazione previsto come istituto di carattere generale, sia quello speciale… E pertanto l’eventuale mancanza dei requisiti previsti per l’ulteriore particolare trattamento di disoccupazione speciale, contemplato dalla norma impugnata in favore dei dipendenti di alcune imprese in situazioni ben determinate, non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la disoccupazione” (sentenza 285).
Manifestamente infondata è dichiarata la questione volta ad estendere ai lavoratori dipendenti in permesso sindacale la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (estesa dalla Corte, con sentenza 171/02, ai lavoratori in aspettativa sindacale). Infatti, soltanto nel caso dell’aspettativa sindacale il sindacato, in quanto beneficiario della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuto a corrispondere all’Inail il premio assicurativo, per cui le due fattispecie non sono comparabili. Neppure è violato, secondo la Corte, “il principio di adeguatezza della tutela previdenziale in caso di infortunio subìto dal lavoratore (art. 38, secondo comma, Costituzione) considerato che…il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l’occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale” (ordinanza 136).
Quanto al trattamento pensionistico, in una questione relativa ai dirigenti generali dello Stato, si ribadisce che “il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato – che pure deve sussistere tanto al momento del collocamento a riposo del lavoratore, quanto successivamente – non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi” (ordinanza 162).
Riguardo, specificamente, al trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi (censurato in quanto coloro che hanno versato i contributi in due diversi regimi speciali previdenziali, rispettivamente per gli artigiani e per i commercianti, otterrebbero un trattamento deteriore rispetto a chi è stato soggetto a un’unica gestione) la Corte ha riaffermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l’estensione del meccanismo della “totalizzazione” dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali ai fini della misurazione della pensione” e che la soluzione adottata non è irragionevole, in quanto risponde all’esigenza di preservare gli equilibri finanziari delle diverse gestioni (sentenza 325).
Ampia discrezionalità al legislatore è riconosciuta anche in materia di anzianità convenzionale, qual è quella derivante dal riscatto degli anni di studio, con il solo limite della non arbitrarietà (ordinanza 121).
È stata riproposta alla Corte l’annosa questione dell’integrazione al minimo delle persone (v. già sentenza 18/1998). Essa ha ritenuto che “l’integrazione al minimo delle pensioni è già, di per sé, finalizzata ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita al lavoratore che, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, abbia maturato, sulla sola base dei contributi accreditati, il diritto ad un trattamento pensionistico di importo troppo esiguo per soddisfare i bisogni minimi di protezione della persona, sicché il riconoscimento dell’integrazione può considerarsi sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, mentre in merito all’eventuale attribuzione di ulteriori benefici va riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili” (ordinanza 173).
La Corte, chiamata di nuovo ad occuparsi del seguito legislativo della propria sentenza 243/93, sul computo dell’indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici, ha riaffermato che la legge 87/1994 rappresenta una risposta adeguata e tempestiva. “L’indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale…sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà”. Va quindi escluso che “l’entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell’indennità di buonuscita dell’elemento sul quale la contribuzione è calcolata” (sentenza 87).
2.14. Iniziativa economica privata
L’art. 41 Costituzione è stato evocato come parametro nelle ordinanze di rimessione relative alla nuova disciplina delle fondazioni bancarie, in particolare quanto alla limitazione dei “settori ammessi”, nei quali cioè è possibile l’intervento di dette fondazioni. La Corte ha rilevato che, “anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del D.Lgs 153/99), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate – che attengono…alla necessaria individuazione dello ‘scopo’ della persona giuridica – non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività” (sentenza 301).
Relativamente all’apertura, in una regione, di una filiale di un’agenzia di viaggi già autorizzata in altra regione, la Corte ha affermato che l’obbligo di comunicare l’apertura della filiale “non lede la libertà di iniziativa economica, poiché con esso non si pone alcun vincolo alle scelte dell’impresa riguardo alla propria articolazione territoriale; tanto meno può considerarsi onere procedimentale in grado di ostacolare la libera circolazione dei fattori produttivi e l’esercizio del diritto al lavoro”. Al contrario, contrasta con gli artt. 41 e 120 Costituzione la previsione, per l’apertura di filiali, di un onere economico ulteriore, nella forma dell’integrazione del deposito cauzionale, rispetto a quello già sostenuto inizialmente. Quest’obbligo, prosegue la sentenza, “lede il diritto dell’imprenditore di modulare a sua scelta l’organizzazione territoriale dell’agenzia di viaggi e al tempo stesso, gravando l’impresa di oneri economici aggiuntivi, costituisce un illegittimo ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose, nonché all’esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale” (sentenza 375).
2.15. Proprietà
La reiterazione o la proroga di vincoli urbanistici espropriativi comporta la necessaria indicazione di un termine e di un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. “L’obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo (nella specie 10 anni, secondo la legge regionale denunciata, trattandosi di piano di edilizia popolare), da considerarsi come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo” (sentenza 148).
La proroga della sospensione delle procedure di esecuzione forzata per il rilascio di immobili ad uso abitativo, nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolare protezione, non lede il diritto di proprietà in quanto “può trovare una giustificazione nella fase transitoria di passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà; ciò al fine di consentire loro di trovare un idoneo alloggio in base alla propria capacità finanziaria, con il concorso di istituti predisposti o agevolati dalle pubbliche autorità preposte e responsabili del settore. La sospensione della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto. In tale periodo transitorio (con oneri, si noti, come nella specie, a carico di soggetti privati) può rientrare la proroga, stabilita con la disposizione contestata” (sentenza 310).
È stata poi ritenuta lesiva del diritto di proprietà la norma (art. 52 D.Lgs 490/99) secondo la quale non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d’artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l’inamovibilità da uno stabile, del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d’uso. Essa, infatti determina una compressione irragionevole del diritto di proprietà, in quanto l’intento perseguito (in attuazione dell’art. 9 Costituzione), poteva già considerarsi attuato sulla base di numerose altre previsioni contenute nella medesima normativa: la misura, pertanto, è “esuberante rispetto alla finalità di tutela perseguita” (sentenza 185, già citata).
2.16. Accesso alle cariche elettive
La Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di agevolazioni della partecipazione femminile alle cariche pubbliche. Non si è considerata lesiva degli artt. 3, comma 1, e 51 Costituzione la norma della regione Valle d’Aosta secondo la quale le liste elettorali devono comprendere, a pena di esclusione, candidati dei due sessi (sentenza 49). Essa, infatti, non esplica alcuna incidenza sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uno o dell’altro sesso: non introduce ulteriori requisiti di eleggibilità, né può essere qualificata come una di quelle “misure legislative, volutamente diseguali”, che “possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)”, ma che la Corte ha ritenuto non possano “incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”, tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza 422/1995). Infatti, la norma impugnata, secondo la Corte, non prevede “alcuna misura di ‘disuguaglianza’ allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di ‘compensare’ tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti”. Non si è ritenuto intaccato neppure “il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell’uno e dell’altro sesso e gli eletti dello stesso sesso”. La norma stabilisce soltanto un vincolo alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che presentano le liste, vincolo che “può senz’altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell’intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell’obiettivo di equilibrio della rappresentanza”. Infatti, la legge costituzionale 2/ 2001, integrando gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere “condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”, e ciò proprio “al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi”. D’altra parte, tale finalità era già stata riconosciuta “positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale” dalla Corte, nella sentenza con la quale (422/1995) era stata dichiarata l’incostituzionalità di diverse disposizioni di legge prevedenti l’obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle camere e dei consigli regionali e comunali.
In materia di ineleggibilità, la Corte ha ribadito (riprendendo la sentenza 287/97) che l’art. 51 Costituzione, “riferendosi ai ‘requisiti’ per l’accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall’altro lato, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto ‘richiedono’. Tra tali condizioni richieste all’aspirante candidato possono ben essere comprese non solo l’inesistenza di incarichi tali da determinare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale, ma anche l’inesistenza di incarichi la cui titolarità sia ritenuta incompatibile con la candidatura in questione” (sentenza 306). Nel caso di specie, l’art. 51 non è stato ritenuto violato dalla norma che prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana dei “capi servizio…degli uffici statali che svolgono attività nella regione”. Essa infatti si riferisce a una categoria precisamente circoscritta, e non contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale “le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell’art. 51 Costituzione, devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse”, con la conseguente incostituzionalità di cause di ineleggibilità dai confini generici ed elastici, suscettibili di essere dilatate in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse.
2.17. Voto degli italiani all’estero
La disciplina relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti all’estero (previsto dall’art. 48 Costituzione, come modificato a seguito della legge costituzionale 1/2000), è sfiorata dalla Corte nell’ordinanza 195, con la quale si dichiara inammissibile il conflitto promosso dal comitato promotore di un referendum, secondo il quale l’esercizio del voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all’estero, previsto dalla legge 459/2001, sarebbe stato in contrasto con “la segretezza del voto, proclamata dall’art. 48 della Costituzione”. Secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata altresì violazione, da parte della stessa legge e del regolamento attuativo, delle regole democratiche in materia di campagne elettorali. La Corte ha affermato che, nel caso in cui si “fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza, si [sarebbe determinata] la conseguenza di rendere assai più difficile l’espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all’estero”, e che le “presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei regolamenti impugnati…non [avrebbero potuto] costituire oggetto sindacabile nella presente sede, trattandosi di scelte lasciate alla discrezionalità del legislatore, specie ove si consideri la necessaria attuazione di nuove norme costituzionali relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio di Stati esteri”.
2.18. Tributi
Riguardo alle disposizioni contenenti agevolazioni e benefici tributari, si conferma che, “quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione”. Peraltro, questa estensione, si è ribadito, “è consentita quando lo esiga…ratio dei benefici stessi” (sentenza 202, con la quale si esentano dall’imposta di registro i provvedimenti di determinazione del contributo di mantenimento a carico del genitore naturale). Tali disposizioni possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza nei soli casi della palese arbitrarietà o irrazionalità. Ciò vale a maggior ragione quando la questione di costituzionalità sia diretta a limitare, e non ad ampliare il beneficio, risultando quindi sollevata in malam partem. Pertanto, “nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo [ai soli] immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione” (sentenza 346).
Non è manifestamente irragionevole l’esclusione da un’agevolazione fiscale (dettata con l’intento, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo di cui all’art. 44 Costituzione, di incentivare l’attività agricola) di coloro che – per il limitato numero di giornate lavorative che la coltivazione dei fondi di loro proprietà richiede ovvero per il fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (ordinanza 336).
Molte delle questioni sollevate in materia tributaria invocano come parametro (da solo, o unitamente all’art. 53) il principio di eguaglianza. Un esempio è costituito dalla questione decisa con la sentenza 98, relativa alla base imponibile per il calcolo dell’Invim per gli immobili (strumentali delle società) esenti dall’Invim decennale. Si lamentava una disparità di trattamento rispetto agli immobili assoggettati all’Invim decennale, poiché il valore iniziale assunto come riferimento per gli immobili strumentali è quello della data di acquisto e non, come avviene per gli altri, della scadenza dell’ultimo decennio di possesso. La Corte ha affermato che non può “dubitarsi della coerenza sistematica della norma censurata, là dove prevede che, in caso di trasferimento degli immobili strumentali, ai fini della determinazione della base imponibile debba assumersi come valore iniziale quello della data di acquisto. È questa, infatti, una logica conseguenza della scelta, operata dal legislatore, di assoggettare i suddetti immobili al solo prelievo all’atto del loro trasferimento, e non anche al prelievo periodico”. Scelta, quest’ultima, la cui ratio è che per gli immobili strumentali non esiste il rischio di elusione dell’imposta che c’è, invece, per gli altri (e che spiega l’esistenza stessa dell’Invim decennale).
3. Ordinamento della Repubblica
3.1. Il parlamento
Riguardo alla insindacabilità dei parlamentari, di cui all’art. 68, comma 1, Costituzione, la Corte introduce alcune precisazioni, nel solco della propria precedente, vasta giurisprudenza sul tema.
In primo luogo, “l’attività svolta in seno ad organi parlamentari, quali certamente sono le Commissioni parlamentari di inchiesta, ha l’identica natura di quella svolta nelle altre articolazioni in cui i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono chiamati a svolgere le proprie attribuzioni: la definizione di attività parlamentare – soprattutto agli effetti della garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati, a norma dell’art. 68 della Costituzione – non può, infatti, ammettere arbitrarie limitazioni a seconda della ‘struttura’ all’interno della quale le funzioni anzidette vengono ad essere in concreto esercitate” (sentenza 219).
Si precisa altresì che “la ‘tipizzazione’ degli atti compiuti dal parlamentare, che rileva agli effetti della garanzia di insindacabilità, non è quella che scaturisce dal nomen (valido solo sul piano meramente ricognitivo); ma è quella che, secondo un paradigma di effettività, deriva dalla riconducibilità degli atti all’esercizio delle attribuzioni proprie – anche se attuate in forma ‘innominata’, sul piano regolamentare – dei componenti i due rami del Parlamento. È l’atto del parlamentare, in sé e per sé considerato – e non necessariamente la sua riconducibilità agli schemi del regolamento parlamentare – a dover presentare quegli indici di riconoscimento della partecipazione ai lavori delle assemblee, delle commissioni e degli altri organi della Camera o del Senato, che valgano a qualificarlo come opinione manifestata nell’esercizio delle funzioni di membro del Parlamento”. Cosicché anche una lettera, inviata da un capogruppo al presidente di una Commissione parlamentare di inchiesta, presenta le caratteristiche necessarie per poter essere inquadrata nel novero degli atti di esercizio della funzione parlamentare. Il contenuto politico dell’atto non ha rilievo: “se esso promana da una ‘fonte’ parlamentare e si manifesta come esercizio delle attribuzioni proprie di quella funzione, è evidente che il suo contenuto comunicativo – abbia o meno risalto politico, tecnico o di altra natura – non presenta in sé aspetti significativi o dirimenti agli effetti dello scrutinio relativo alla applicabilità della garanzia sancita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione” (sentenza 219).
Anche una interrogazione dichiarata inammissibile dal Presidente dell’assemblea sulla base delle norme regolamentari può costituire atto di esercizio delle funzioni del parlamentare, con la conseguenza che le opinioni in essa contenute (e le loro eventuali riproduzioni in altre sedi) sono coperte dall’insindacabilità. Molteplici, e non sempre ancorate a criteri rigorosamente predeterminati, sono infatti i motivi di inammissibilità previsti dalla norma regolamentare. E se “il controllo inteso alla ‘tutela della sfera personale e dell’onorabilità dei singoli’ può apparire uno strumento idoneo a equilibrare, con la protezione di questi valori nell’ambito dell’ordinamento parlamentare, la potenzialità lesiva di essi insita nella esenzione del parlamentare…da ogni responsabilità giuridica per le opinioni espresse nello svolgimento del mandato, non altrettanto può dirsi di criteri come quello che restringe la sfera del potere ispettivo nei confini propri della responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento, in cui si realizza piuttosto una regolamentazione dell’istituto in chiave funzionale, a tutela dei rapporti fra Camere ed esecutivo, che poco ha a che fare con la libertà di espressione del parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, che l’insindacabilità tende a proteggere al massimo grado. Se si tiene poi conto che contro la decisione presidenziale non è previsto, almeno esplicitamente, né viene praticato alcun rimedio, nemmeno in forma di appello all’assemblea, ben si comprende come legare indissolubilmente al vaglio positivo di ammissibilità la caratterizzazione dell’atto come esercizio di funzione parlamentare, e viceversa, significherebbe attribuire al Presidente della Camera un potere assoluto incidente su una prerogativa – quella della insindacabilità – che, benché indirizzata a rafforzare lo statuto dell’organo parlamentare, si riferisce pur sempre alla libertà di espressione di ogni singolo membro delle Camere”. Spetterà pertanto alla Corte valutare caso per caso il contenuto dell’atto e le ragioni della sua mancata ammissione (sentenza 379).
Nel conflitto che vede la Camera dei deputati contrapposta ad un giudice, che aveva dichiarato la contumacia di un parlamentare imputato, nonostante la concomitanza con i lavori parlamentari, la Corte ha ribadito quanto già affermato con la sentenza 225/01: “la posizione dell’imputato, che sia membro del Parlamento, di fronte alla giurisdizione penale…non è assistita da speciali garanzie costituzionali diverse da quelle stabilite dall’art. 68, commi 1 e 2, per cui, al di fuori delle ipotesi ivi stabilite, trovano applicazione, nei confronti dell’imputato parlamentare, le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali. La partecipazione all’attività parlamentare, ivi compresa la partecipazione a votazioni, pertanto, non costituisce un impedimento assoluto, non potendosi introdurre una distinzione fra diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai suoi diritti e doveri funzionali, non potendosi inoltre escludere che l’esigenza di indire votazioni insorga in ogni momento nel corso delle attività delle assemblee parlamentari, indipendentemente dalla preventiva programmazione dei lavori. Tuttavia l’autorità giudiziaria, come ogni altro potere, allorquando agisce nel campo suo proprio e nell’esercizio delle sue competenze, deve tener conto non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell’applicazione delle regole comuni, e così ai fini dell’apprezzamento degli impedimenti invocati per chiedere il rinvio dell’udienza…Pertanto il giudice non può, al di fuori di un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale del Parlamento, far prevalere solo la prima, ignorando totalmente la seconda” (come è avvenuto nel caso di specie: sentenza 263).
3.2. La necessità di copertura finanziaria (art. 81, comma 4, Costituzione)
Chiamata a verificare il rispetto dell’art. 81, comma 4, da parte della norma secondo la quale il magistrato deve liquidare l’onorario del difensore d’ufficio, qualora questi dimostri di aver esperito, inutilmente, le procedure per il recupero dei crediti professionali, la Corte rileva che non sussiste alcun maggior onere a carico dello Stato, in quanto si tratta di un’anticipazione di una somma che lo Stato è poi tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito e che l’aleatorietà dell’effettivo recupero non incide sulla legittimità della norma impugnata, in quanto la valutazione del legislatore è non manifestamente irragionevole (sentenza 266).
3.3. Pubblica amministrazione e pubblico impiego (art.97 Costituzione)
La pubblica amministrazione conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare, “sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa” (così la citata sentenza 82). Pertanto, ben può essere ritenuta ragionevole la differenziazione della disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente rispetto al lavoratore privato. Le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego (efficace erga omnes, “funzionale all’interesse pubblico di cui all’art. 97 Costituzione, inderogabile sia in pejus che in melius, oggetto di diretto sindacato da parte della Corte di cassazione per violazione o falsa applicazione) “rendono evidente l’impossibilità di ritenere a priori irrazionali le peculiarità della disciplina del processo in cui quel contratto collettivo – ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato – deve essere applicato” (sentenza 199).
È altresì ragionevole non aver previsto, in caso di violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche, la conversione in rapporto a tempo indeterminato, possibile invece per i lavoratori privati. Infatti, “il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell’accesso mediante concorso, enunciato dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione” (sentenza 89).
Alla regola del pubblico concorso – quale metodo che, per l’accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell’efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) – è possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell’art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (sentenza 89). Questo principio è applicabile anche per l’accesso a funzioni più elevate da parte di chi è già in rapporto con la pubblica amministrazione. Violano quindi l’art. 97, commi 1 e 3, norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti. Al contrario, una norma che riguarda l’inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell’ambito dell’amministrazione, in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili, non viola l’art.97, comma 1, in quanto è possibile ritenere che essi verosimilmente avessero, nella precarietà, acquisito l’esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (sentenza 274).
Sempre in materia di impiego pubblico, la sentenza 264, ha ritenuto non irragionevole la mancata previsione di un termine per la misura della sospensione cautelare dal servizio del magistrato sottoposto a procedimento penale disposta dalla sezione disciplinare del CSM in base a una valutazione sommaria, nel merito, dei fatti dedotti nel procedimento penale medesimo. Infatti, precisa la Corte, “in tale contesto, la misura cautelare non ha più nulla dell’”automatismo” che secondo la giurisprudenza di questa Corte comporta, per ragioni di contemperamento degli interessi costituzionali in gioco, la necessità di una durata rigidamente limitata nel tempo: essa può dunque legittimamente durare fino a quando permangano le esigenze cautelari discrezionalmente apprezzate dall’amministrazione”.
Si è ribadito, poi, che “come più volte precisato, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocato per conseguire miglioramenti retributivi” (ordinanza 162).
L’art. 97 è venuto in rilievo anche in riferimento alle cause di incompatibilità. In particolare, esso non è stato ritenuto violato in conseguenza dell’assenza della incompatibilità tra la carica di sindaco e l’ufficio di primario nel locale ospedale: “non si può dire che la funzione del sanitario, che ha essenzialmente compiti di direzione tecnica di servizi, e non di gestione dell’azienda, lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco del Comune, tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione: specie se si tiene presente che la eleggibilità alle cariche rappresentative locali è contenuto di un diritto, che può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti, il cui apprezzamento richiede per lo più – anche se non sempre necessariamente – una interposizione del legislatore” (sentenza 220).
In alcune decisioni (ordinanze 110 e 225) si conferma che il richiamo all’art. 97 in questioni relative a norme processuali è del tutto inconferente: “il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – pur concernendo anche gli organi dell’amministrazione della giustizia – si riferisce esclusivamente alle leggi relative all’ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l’aspetto amministrativo, risultando di per sé estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale”.
3.4. Consiglio superiore della magistratura
Due decisioni riguardano il Consiglio superiore della magistratura.
Anche al procedimento disciplinare, che si svolge davanti all’apposita sezione, si applica il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, con riferimento a qualunque tipo di processo, pur nella diversità delle rispettive discipline connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento. Le soluzioni legislative per realizzare questo principio, ferma comunque la regola che il giudice sia collocato sempre in posizione super partes e di estraneità rispetto agli interessi oggetto del processo, non debbono prefigurare moduli necessariamente identici per tutti i tipi di processo, purché sia comunque assicurato quel “minimo” di garanzie ragionevolmente idonee allo scopo. Conseguentemente, sono incostituzionali le norme che “non prevedono una soluzione organizzativa che impedisca, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni unite della Cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda” (sentenza 262).
Quanto al conferimento degli uffici direttivi, la Corte ribadisce (conformemente alla sentenza 379/92) che la discussione ed il confronto tra Ministro della giustizia e Csm devono svolgersi, sotto il profilo metodologico, in base al principio di leale collaborazione, con l’osservanza di regole di correttezza nei rapporti reciproci e di rispetto dell’altrui autonomia. “Ambedue i soggetti del confronto non possono, per il dovere di correttezza e di leale collaborazione, dare luogo ad atteggiamenti o comportamenti dilatori, pretestuosi, incongrui o contraddittori o insufficientemente motivati…nella ipotesi in cui il contrasto persista, e vi sia un ‘rifiuto del concerto’ da parte del Ministro (rifiuto che in ogni caso deve essere motivato), la procedura non può subire una stasi indefinita. Infatti, spetta al plenum del Consiglio la deliberazione definitiva sull’incarico direttivo da conferire, tenendo conto della proposta iniziale della commissione, delle ragioni del contrasto e di tutte le argomentazioni dedotte, con conseguente adempimento dell’obbligo di motivare la scelta finale in modo adeguato e puntuale”. Il concerto specificamente previsto dall’art. 11, comma 3, della legge 195/1958 è stato interpretato, in modo conforme a Costituzione, nel senso che si risolve in modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti, che non è configurato per provocare un semplice parere non vincolante del Ministro, o per raggiungere necessariamente un accordo con effetto alternativo di veto in mancanza di assenso. Il concerto del Ministro sulla proposta iniziale del Csm implica solo un vincolo di metodo, e non di risultato, in quanto, in mancanza di identità di soluzione, il Csm ed il Ministro della giustizia devono “porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare – a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo – la scelta più idonea” (sentenza 380).
4. La riforma del Titolo V
4.1. Considerazioni introduttive
Per il secondo anno, la Corte è stata chiamata a confrontarsi con i problemi interpretativi aperti dalla riforma del Titolo V. Ormai definite, nella giurisprudenza del 2002, gran parte delle questioni di diritto intertemporale, essa ha potuto concentrarsi sul contenuto della riforma e sulla nuova ripartizione dei poteri tra centro e periferia che essa delinea. A metà 2003, poi, è entrata in vigore la legge statale di attuazione (legge 131/03), i contenuti della quale hanno trovato spazio, come argomento ad adiuvandum, in alcune sentenze: nella sentenza 314, circa il permanere del sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale; nella sentenza 329, sulla scomparsa della funzione statale di indirizzo e coordinamento; nella sentenza 242, in materia di potere estero. Peraltro, come la Corte ricorda con la sentenza 370, continua a mancare qualsiasi norma di attuazione dell’art. 119 Costituzione, con gravi conseguenze sull’assetto dei poteri riformato.
4.2. L’autonomia statutaria
Per quanto attiene alla nuova autonomia statutaria regionale, affermazioni di rilievo (che fanno seguito a quelle contenute nella sentenza 304/2002 e precedono quelle della sentenza 2/2004) si rintracciano nella sentenza 313, nella quale la Corte affronta la questione, assai dibattuta in dottrina, della possibilità, a seguito della modifica dell’art. 121, comma 2, di attribuire alla giunta la potestà regolamentare con legge, senza modificare lo statuto vigente (che, rispecchiando il vecchio contenuto della norma costituzionale, continuava ad attribuire la potestà medesima al consiglio). La Corte, sostenendo che la scelta in ordine all’organo cui attribuire la potestà regolamentare non è predefinita dalla Costituzione, ma è rimessa allo statuto, afferma, a difesa dell’autonomia statutaria, che “l’autonomia è la regola; i limiti sono l’eccezione. L’espressione ‘in armonia con la Costituzione’, che compare nel primo comma dell’art. 123 della Costituzione, non consente perciò un eccesso di costruttivismo interpretativo, come quello di cui fa mostra la difesa della Regione Lombardia, quando argomenta da una presunta forma di governo regionale, implicitamente stabilita dagli articoli 121 e 123 della Costituzione, la spettanza del potere regolamentare alla Giunta regionale: un modo di ragionare che, oltre al rischio di sovrapporre modelli concettuali alle regole particolari, comporta anche quello di comprimere indebitamente la potestà statutaria di tutte le regioni ad autonomia ordinaria, tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori” (nello stesso senso, sentenza 324).
Inoltre, la Corte ha individuato una linea di ripartizione di competenza tra la legge regionale e lo statuto, parlando di una “riserva di statuto” in tema di prorogatio: “la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, [è] oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari”. Peraltro gli statuti, “nel disciplinare la materia, dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione” (sentenza 196).
4.3. Gli organi della regione
Riguardo agli organi della regione, oltre al tema della distribuzione della potestà regolamentare tra giunta e consiglio, la Corte affronta quello, cui si è appena fatto cenno, della prorogatio, affermando che essa è possibile, se lo statuto la prevede, per ogni caso di scioglimento del consiglio, con l’eccezione “dello scioglimento o rimozione ‘sanzionatori’, prevista dall’art. 126, primo comma, della Costituzione. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell’art. 126 Costituzione, ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l’art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii, nonostante l’avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale” (ancora sentenza 196).
Circa la competenza legislativa regionale a determinare i casi di incompatibilità dei consiglieri (art. 122, comma 1), si è dichiarata incostituzionale la legge lombarda che prevedeva l’incompatibilità della carica di consigliere regionale esclusivamente con riguardo alle cariche di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ritenendola in contrasto con il principio consistente “nell’esistenza di ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell’art. 97, primo comma, della Costituzione”. Perciò, “il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere… Ma ciò non esclude scelte diverse nello svolgimento del medesimo principio, con riferimento specifico all’articolazione degli enti locali nella Regione, naturalmente entro il limite della discrezionalità, oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso” (sentenza 201).
La Corte sottolinea altresì, nell’ambito di un giudizio in via incidentale, la differenza che sussiste, quanto a status e funzioni, tra i consiglieri regionali e quelli degli enti locali, sia poiché solo i primi esercitano poteri legislativi, sia per il diverso trattamento loro riservato dalla legge statale (ancora vigente, in nome del principio di continuità, anche per i consiglieri regionali, fino all’intervento della legge regionale) (ordinanza 223).
Quanto alla convalida degli eletti da parte dei consigli regionali, la Corte ha confermato, anche dopo la riforma del Titolo V, la precedente giurisprudenza, secondo la quale “non sussiste alcuna norma o principio costituzionale da cui possa ricavarsi l’attribuzione ai consigli regionali, anche di regioni a statuto speciale, del giudizio definitivo sui titoli di ammissione dei loro componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, così da sottrarre tale materia alla sfera della giurisdizione…Le norme legislative e dei regolamenti interni le quali parlano di un ‘giudizio definitivo’ delle assemblee elettive regionali sulla verifica dei poteri e sulle contestazioni e i reclami elettorali vanno intese, conformemente alla Costituzione, come riferite alla fase ‘amministrativa’ del contenzioso elettorale, e non escludono la successiva eventuale fase giurisdizionale, non potendo le norme regionali disciplinare la giurisdizione né escluderla…Non vale, in contrario, richiamare la modificazione profonda della posizione e delle funzioni delle regioni e dei consigli regionali, intervenuta da ultimo con la riforma del titolo V, Parte seconda, della Costituzione ad opera della legge costituzionale 3/2001; né indicare quanto ci può essere di superato in talune delle argomentazioni [un tempo] impiegate dalla Corte per sottolineare le differenze fra la posizione delle camere parlamentari e quella dei consigli regionali. Infatti la conclusione che qui si tiene ferma non si radica in una ipotetica differenza di ‘natura’ o di funzioni fra assemblee elettive nazionali e regionali – espressione entrambe della sovranità popolare (cfr. sentenza 106/02) – che precluda di per sé l’estensione alle seconde di norme e principi validi per le prime: ma deriva, più semplicemente e decisivamente, dal principio secondo il quale la tutela giurisdizionale è a tutti garantita (art. 24 Costituzione) ed è affidata agli organi previsti dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione…Sottrarre alla giurisdizione, per riservare esclusivamente alla assemblea degli eletti, della quale fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali coinvolti, il giudizio sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, significherebbe negare il ‘diritto al giudice’, e ad un giudice indipendente e imparziale…A fronte di questo diritto, il cui nucleo essenziale costituisce un ‘principio supremo’ dell’ordinamento costituzionale…, non può invocarsi, a fondamento della deroga prospettata, l’articolo 66 della Costituzione, che attribuisce alle camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri membri, in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell’esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l’autonomia della rappresentanza elettiva. La forza derogatoria che a tale norma venga attribuita non potrebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata, e non è quindi invocabile per costruire un’anacronistica esenzione dei consigli regionali dalla giurisdizione” (sentenza 29).
4.4. La potestà legislativa regionale
4.4.1. La possibilità per lo Stato di attrarre competenze legislative al di fuori dell’art. 117, comma 2, in nome del principio di sussidiarietà
Sicuramente, la pronuncia più commentata dell’anno in materia regionale è stata la sentenza 303 che, tra l’altro, interviene anche sul tema della potestà legislativa, a tutela di istanze unitarie.
“Il nuovo art.117 Costituzione – si afferma – distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali. In questo quadro, limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell’ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Costituzione, il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida…la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. È del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”.
La possibilità, per lo Stato, di disciplinare, in nome delle esigenze unitarie, profili delle materie di competenza concorrente che non gli competerebbero, è tuttavia temperata dall’affermazione che “i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata”. La Corte precisa che non è sufficiente una semplice evocazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza per “modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione”.
Tali principi non possono assumere “la funzione che aveva un tempo l’interesse nazionale, la cui sola allegazione non è ora sufficiente a giustificare l’esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all’art. 117 Costituzione Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale. Ciò impone di annettere ai principî di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sentenza 303; la possibilità che lo Stato possa giustificare la propria potestà legislativa sulla base di un richiamo all’interesse nazionale è esclusa anche dalla sentenza 370).
4.4.2. Rapporti tra legge statale e legge regionale
Riguardo ai rapporti tra legge statale e legge regionale, la Corte ha affrontato il fenomeno del “recepimento” di una intera legge statale (in una materia di competenza concorrente quale quella elettorale) da parte di una legge regionale, ritenendo non potersi sostenere che tale legge violi “il limite territoriale della legge regionale e…l’art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l’applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in ‘sostituzione’ di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di ‘recepimento’, senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale” (sentenza 196).
È stato inoltre precisato che al legislatore regionale, in materie di competenza esclusiva dello Stato, è precluso recepire, anche solo ricognitivamente, la normativa statale. In questi casi, infatti, “il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato” (sentenza 313).
4.4.3. La definizione delle materie: aspetti generali
La Corte ha continuato l’opera, avviata nel 2002, di definizione delle materie indicate dall’art. 117 Costituzione.
Innanzitutto, essa ha utilizzato, al fine di ricondurre un determinato oggetto entro una materia, il criterio legislativo-evolutivo. Con la conseguenza che un cambiamento nella legislazione ordinaria di settore può comportare lo spostamento della collocazione di un oggetto nel riparto materiale delle competenze legislative dell’art. 117 Costituzione Così, ad esempio, a seguito della evoluzione legislativa, la disciplina degli asili nido viene ricondotta entro la materia dell’istruzione e, per alcuni profili, entro quella della “tutela del lavoro” (sentenza 370); la disciplina delle fondazioni di origine bancaria è ritenuta estranea, a seguito degli sviluppi legislativi, alla materia concorrente “casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale”, per essere ricondotta invece a quella, statale, dell’ordinamento civile (sentenza 300).
Inoltre, al fine di identificare la materia cui una norma afferisce, assume rilievo la finalità perseguita: una legge regionale sugli animali esotici, per esempio, in quanto persegue obiettivi di tutela igenico-sanitaria e di sicurezza veterinaria viene ricondotta alla materia concorrente della “tutela della salute” (sentenza 222); mentre la disposizione statale che impone anche alle regioni di riservare, nell’acquisto dei pneumatici per i loro autoveicoli, una quota di almeno il 20% ai pneumatici ricostruiti viene ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente (sentenza 378).
In molti casi, peraltro, la Corte riconosce che, “per la loro connessione funzionale, non [è] possibile una netta separazione nell’esercizio delle competenze”: occorre allora “addivenire a forme di esercizio delle funzioni, da parte dell’ente competente, attraverso le quali siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti…Vale il principio, detto della ‘leale cooperazione’, suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione” (sentenza 308; riguardo al vecchio Titolo V, sentenza 96).
4.4.4. La definizione delle materie: l’art. 117, comma 2
Diverse decisioni contribuiscono a definire le materie di competenza statale esclusiva, elencate nel secondo comma dell’art. 117.
La riserva statale della lettera e), in materia di “tutela del risparmio e dei mercati finanziari” (che, secondo la Corte, “ riguarda in particolare la disciplina delle forme e dei modi in cui i soggetti…possono ottenere risorse finanziarie derivanti da emissione di titoli o contrazione di debiti”), consente l’attribuzione ad organi centrali di poteri di coordinamento in tema di accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali (sentenza 376).
Non può ricondursi alla “perequazione delle risorse finanziarie” (riservata allo Stato sulla base della medesima lettera e) una norma che, come quella mirante ad attenuare le conseguenze sanzionatorie del mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, al di là della sua rubrica, non ha alcuna finalità di tal tipo (sentenza 362).
Riguardo alla “tutela della concorrenza” (di cui alla stessa lettera e), la Corte esclude che possa esservi ricondotta una norma che si limita a disciplinare il rapporto pubblicistico tra gestore di impianto di telecomunicazione ed ente pubblico cui spettano i poteri di pianificazione, autorizzazione e vigilanza (sentenza 307).
La lettera g), che si riferisce all’ “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, serve a fondare la potestà legislativa statale in ordine alla norma che consente al ministero del lavoro di avvalersi di una società per azioni, a capitale interamente pubblico, per lo svolgimento di funzioni finalizzate alla promozione dell’occupazione: tale società, infatti, presenta tutti i caratteri proprie dell’ente strumentale, salvo rivestire la forma della società per azioni, ciò che non è sufficiente ad escludere la competenza statale (sentenza 363).
La riserva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (lettera h) preclude una disciplina regionale in materia di polizia di sicurezza (che è cosa diversa dalla polizia amministrativa locale che segue, invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede) (sentenza 313).
Allo stesso modo, la riserva statale in materia di giurisdizione penale (lettera l) preclude una disciplina regionale in materia di polizia giudiziaria (sentenza 313).
Quanto alla materia dell’ “ordinamento civile” (di cui alla medesima lettera l), la Corte non la ritiene invasa da una norma regionale che rimetta alla volontà dei proprietari l’imposizione di vincoli di destinazione d’uso su immobili, i cui operano “locali storici”, finalizzata alla concessione di finanziamenti regionali (sentenza 94); mentre è incostituzionale la legge regionale che disciplina il fenomeno del mobbing, prevedendo, tra l’altro, una diffida nei confronti del datore di lavoro da parte del centro anti-mobbing, diffida che configura un elemento dell’eventuale inadempimento del datore di lavoro (sentenza 359). La materia dell’ordinamento civile, poi, comprende la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato (e, quindi, anche delle fondazioni di origine bancaria; peraltro ciò non toglie che nei loro confronti, così come verso qualunque altro soggetto dell’ “ordinamento civile” valgano anche le norme regionali in quanto incidano sulle funzioni da queste svolte: sentenza 300).
Diverse pronunce contengono interpretazione della lettera m), secondo la quale è riservata allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. La Corte, riconosciuto che si tratta di “un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto”, ritiene che “la conseguente forte incidenza sull’esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regione e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori” (sentenza 88). La invocabilità della lettera m) per ritenere estranea alla sfera regionale una normativa che consente alla regione di siglare convenzioni con enti radiotelevisivi (in quanto si inciderebbe su una materia che attiene “alla struttura democratica dello Stato”) è esclusa attraverso l’argomento (già presente nella giurisprudenza precedente alla riforma), che “l’informazione esprime non tanto una materia, quanto ‘una condizione preliminare’ per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa” (sentenza 312).
Alla definizione della portata della lettera p) (che riserva allo Stato “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”) ha contribuito la sentenza 48, secondo la quale, nel caso dell’ordinamento degli enti locali, “il nuovo testo dell’art. 117 non fa che ripercorrere, in forme nuove, le tracce del sistema costituzionale preesistente, in cui le sole Regioni a statuto speciale godevano già (in particolare dopo la riforma degli statuti recata dalla legge costituzionale 2/1993) di una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio, mentre le Regioni ordinarie ne erano prive”. In particolare, riguardo alla legislazione elettorale, si afferma che “la configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti di questa materia” (così anche sentenza 377, ove si ritiene compresa nella competenza statale una nuova disciplina delle cause di incompatibilità degli eletti a livello locale). Tale riserva preclude, poi, una normativa regionale sul riparto delle spese per elezioni regionali, provinciali, comunali, in caso di loro contemporaneità (sentenza 196). Al contrario, resta fuori dalla competenza statale, (in virtù dell’art. 122, comma 1, Costituzione), la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a cariche elettive regionali, derivanti dalla titolarità di cariche elettive comunali, provinciali e delle città metropolitane (sentenza 201).
Quanto alla “profilassi internazionale “ di cui alla lettera q), la Corte ha ritenuto la materia circoscritta ai profili inerenti all’importazione o esportazione di animali, restandone quindi estranea la legge regionale che, in tema di animali esotici, si limita a disciplinare “aspetti legati alla presenza di questi ultimi all’interno del territorio regionale” (sentenza 222).
La Corte è ritornata con varie pronunce sulla lettera s) (“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”), già oggetto di rilevanti decisioni nell’anno precedente (sentenze 407/2002 e 536/02), per ribadire che “la ‘tutela dell’ambiente’, più che una ‘materia’ in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella ‘residuale’ di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale” (sentenze 222 e 307). Peraltro, è riservata allo Stato la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna (sentenze 226, 331, 312). Quanto alla “tutela dei beni culturali” e alla sua distinzione rispetto alla materia concorrente della “valorizzazione” dei medesimi, la definizione è desunta dalla legislazione vigente, e comprende “apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati” e tutto quanto riguarda “autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l’integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico” ed “esercizio del diritto di prelazione” (sentenza 94). Sulla lettera s), si vedano anche le sentenze 311 e 378.
4.4.5. La potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3)
Circa la potestà legislativa concorrente, la Corte ha ribadito, secondo quanto già affermato con la sentenza 282/02, che, la mancanza di una legge statale che determini i principi fondamentali della materia non impedisce alle regioni di esercitare i propri poteri, “in quanto i principi possono e devono essere desunti dalla preesistente legislazione statale” (sentenze 94, 196, 359). In altre parole, “occorre rivolgersi alle norme dell’ordinamento giuridico statale vigente per individuare, tra tutte, quelle che esprimano scelte fondamentali e operino così da limiti all’esercizio della competenza legislativa regionale” (sentenza 201).
Quanto alla eventualità, prospettata dalla dottrina, che dopo la riforma del Titolo V sia inammissibile, nelle materie regionali, una disciplina statale di dettaglio, sia pure cedevole, la Corte ha affermato di non poter negare “che l’inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e l’enumerazione tassativa delle competenze dello Stato dovrebbe portare ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di legislazione concorrente, e tuttavia una simile lettura dell’art. 117 svaluterebbe la portata precettiva dell’art. 118, comma primo, che consente l’attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle correlative funzioni legislative, come si è già avuto modo di precisare. La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com’è ad assicurare l’immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività” (sentenza 303).
Inoltre, “deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire [in materia di competenza concorrente] con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione” (sentenza 329).
Circa la individuazione dei principi, la sentenza 361, sul c.d. “fumo passivo”, afferma la natura di principi fondamentali delle disposizioni statali che prevedono varie fattispecie di illecito amministrativo al fine della tutela della salute. Il carattere di principi fondamentali, necessariamente uniformi, si ricava dalla “loro finalità di protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall’esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. La natura di principi fondamentali delle norme in questione si comprende non appena si consideri l’impossibilità di concepire ragioni per le quali, una volta assunta la nocività per la salute dell’esposizione al fumo passivo, la rilevanza come illecito dell’attività del fumatore attivo possa variare da un luogo a un altro del territorio nazionale. Non potendosi dunque contestare al legislatore statale, in questo particolare campo di disciplina, il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare, non può essergli disconosciuto nemmeno quello di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti. Ciò deriva dal parallelismo tra i due poteri…numerose volte riconosciuto da questa Corte…: parallelismo che comporta, in linea di principio, che la determinazione delle sanzioni sia nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la predeterminazione delle fattispecie da sanzionare”.
Lo stretto legame tra principi fondamentali, uguaglianza, diritti, emerge anche dalla sentenza 338, ove si afferma (riprendendo in parte la sentenza 282/02) che “stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, “diritti la cui tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale”.
Significativa è anche la sentenza 353, nella quale si afferma che la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie (nella specie, si trattava di pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali – quali agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia e altre) deve “rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, [deve] essere riservata allo Stato”. La possibilità che i principi fondamentali comportino l’inclusione o l’esclusione di singoli settori da una materia (possibilità negata in passato dalla giurisprudenza costituzionale) è sfiorato anche dalla citata sentenza 222: una delle censure avanzate dal governo nei confronti della legge regionale sugli animali esotici riguardava, infatti, la violazione di un supposto principio fondamentale consistente nella riserva allo Stato di tale materia. La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte per mancata specificazione dell’oggetto, “a prescindere…dalla impossibilità, eccepita dalla regione resistente, di qualificare come ‘principi fondamentali’ quelli racchiusi in norme statali che – prive di contenuto prescrittivo, atto ad orientare il modo di esercizio della potestà legislativa regionale – si limitino a sancire l’inclusione o l’esclusione di determinati settori nell’ambito di una materia di competenza regionale concorrente”.
Il mancato richiamo, da parte di una legge regionale, dei principi fondamentali contenuti in leggi statali non determina, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali. Ciò, infatti, “non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, restando tali limiti vincolanti e dovendosi piuttosto valutare in concreto se essi non siano violati dal contenuto normativo delle disposizioni impugnate” (sentenza 327). Comunque, nell’ottica della separazione delle sfere di competenza, è preclusa alla regione la fissazione dei principi fondamentali, in caso di fenomeni, come il mobbing, non ancora disciplinati dallo Stato (sentenza 359).
È stato affrontato anche il problema della possibilità per le regioni, in materie concorrenti, di dettare una disciplina aggiuntiva, più garantista di quella statale rispetto ai valori tutelati dalle norme di principio, secondo un orientamento presente, come si rileva (sentenza 307), nel diritto comunitario. Di norma tale “aggiunta” è ammissibile (sentenza 222), ma non quando i principi statali (che, ad esempio, fissano valori-soglia per l’esposizione a onde elettromagnetiche) sono dettati non per proteggere un unico valore, ma come risultato di un bilanciamento tra molteplici interessi, riconducibili a campi materiali diversi (sentenza 307 e sentenza 331). D’altra parte, il fatto che gli standard fissati dalla regione siano più rigorosi di quelli statali non rappresenta un argomento significativo quando si tratti di questioni di costituzionalità riguardanti non il contenuto delle scelte legislative ma la spettanza delle stesse (sentenza 308).
Nelle materie di competenza concorrente, poi, è illegittima la norma che prevede che determinati standard debbano essere fissati in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto ciò si risolverebbe in una negazione della competenza legislativa delle singole regioni (sentenza 370).
4.4.6. La potestà legislativa regionale residuale (art. 117, comma 4)
Riguardo alle competenze regionali residuali del comma 4 dell’art. 117, la Corte ha rilevato che “in via generale, occorre…affermare l’impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all’ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione” (sentenza 370). Ad esempio, i lavori pubblici, di cui pure l’art. 117 non parla, costituiscono “ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti” (sentenza 303). Materie innominate, come l’edilizia e l’urbanistica, sono a loro volta ricondotte dalla Corte entro la competenza concorrente del “governo del territorio” (sentenza 362). D’altra parte, nella citata sentenza sul mobbing, la Corte afferma che “in realtà l’intera legge si fonda sul presupposto – da ritenere in contrasto con l’assetto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni – secondo cui queste ultime, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati di legiferare” (sentenza 359). Circa i limiti che incontra la potestà legislativa dell’art. 117, comma 4, la sentenza 274 afferma che “valgono soltanto i limiti di cui al primo comma dello stesso articolo (e, se del caso, quelli indirettamente derivanti dall’esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva in ‘materie’ suscettibili, per la loro configurazione, di interferire su quelle in esame)”. La sentenza 303, per parte sua, precisa che “è quindi estranea alla materia del contendere la questione se i principî di sussidiarietà e adeguatezza permettano di attrarre allo Stato anche competenze legislative residuali delle Regioni”.
4.4.7. Le competenze delle regioni a statuto speciale (art. 10 legge costituzionale 3/2001)
La Corte è ritornata in varie occasioni sulla portata dell’art. 10 della legge costituzionale 3/2001, secondo il quale, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della riforma si applicano alle regioni speciali “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Nella sentenza 103 (relativa a una questione sollevata prima della riforma) la Corte afferma che “le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e attualmente sono invocabili…solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione” (per un caso in cui l’art. 10 non opera, in quanto le competenze previste dagli statuti speciali sono più ampie di quelle riconosciute alle regioni ordinarie, o comunque sono equivalenti, v. sentenza 48, sull’ordinamento degli enti locali). Nella sentenza 314 la Corte, come si è già ricordato, ha ritenuto di non poter applicare l’art. 10 ai fini di valutare la perdurante attualità del sistema di impugnativa delle leggi regionali siciliane. Il problema relativo alle materie di potestà primaria delle regioni speciali, che sulla base dell’art. 117, comma 4, possono essere fatte rientrare nella potestà residuale delle regioni ordinarie, sotto il profilo della sorte dei limiti generali previsti dagli statuti speciali (già della sentenza 536/02), è affrontato nella sentenza 274, relativa alla materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale. La Corte ha ritenuto che la riforma abbia fatto venir meno tali limiti (nella specie, quello delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali). “Infatti, se…il vincolo di quel limite permanesse pur nel nuovo assetto costituzionale, la potestà legislativa esclusiva delle Regioni (e Province) autonome sarebbe irragionevolmente ristretta entro confini più angusti di quelli che oggi incontra la potestà legislativa ‘residuale’ delle Regioni ordinarie…onde devono escludersi ulteriori limiti derivanti da leggi statali già qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Pertanto – ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 3/2001 – la particolare ‘forma di autonomia’ così emergente dal nuovo art. 117 della Costituzione in favore delle Regioni ordinarie si applica anche alle Regioni a statuto speciale, come la Sardegna, ed alle Province autonome, in quanto ‘più ampia’ rispetto a quelle previste dai rispettivi statuti”. Peraltro, quando una regione speciale (o una provincia autonoma) ponga a base di un proprio ricorso le competenze, più ampie di quelle statutarie, che le deriverebbero dall’art. 117, ha l’onere di individuarle, pena l’inammissibilità della questione (sentenza 303).
4.4.8. Diritto comunitario e competenze regionali
Quanto all’incidenza del diritto comunitario sulle materie regionali, pur non essendo tale profilo venuto in rilievo in modo espresso (non è stato mai richiamato l’art. 117, comma 5, secondo il quale le regioni “nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione…degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato”), va tuttavia sottolineato come le norme comunitarie compaiono varie volte nella motivazione delle decisioni, vuoi in quanto contiene principi generali idonei a giustificare la possibilità di discipline aggiuntive regionali, vuoi in quanto l’esistenza di atti comunitari relativi a un fenomeno non ancora disciplinato dallo Stato, come il mobbing, porta “ad escludere che esso, nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i principi fondamentali, possa essere oggetto di discipline territorialmente differenziate” (sentenza 359). Circa la possibilità di impugnare, in via principale, norme regionali per violazione del diritto comunitario, v. supra, la sentenza 303.
4.4.9. Regolamenti governativi e competenze regionali (art.117, comma 6)
Riguardo alla potestà regolamentare, la Corte ha ribadito (sentenze 22 e 302) che ai regolamenti di delegificazione è inibito disciplinare materie di competenza regionale: “lo strumento della delegificazione non può operare in presenza di fonti tra le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze. Solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con sopravvenuti principî o norme fondamentali della legge statale può infatti determinare l’abrogazione delle prime”. La Corte ha precisato che “la ragione giustificativa di tale orientamento si è, se possibile, rafforzata con la nuova formulazione dell’art. 117, sesto comma, Costituzione, secondo il quale la potestà regolamentare è dello Stato, salva delega alle Regioni, nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia è delle Regioni”. In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza 22); e neppure “i principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario” (sentenza 303, nonché sentenza 329).
4.4.10. Il potere estero (art. 117, comma 9)
La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi anche sul potere estero delle regioni, disciplinato dall’art.117, comma 9, Costituzione, secondo il quale “nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. Essa ha ritenuto che tale disposizione non sia stata violata dalla legge del Friuli-Venezia Giulia che attribuisce al presidente della regione la competenza a stipulare intese con l’Austria e la Slovenia in materia di difesa del suolo. La legge regionale impugnata, secondo la Corte, “si limita soltanto ad attribuire la competenza in materia al Presidente della Regione, senza in alcun modo incidere sui limiti costituzionali”. La sentenza ha anche affermato che la regione non deve attendere la legge statale di attuazione (che tra l’altro, sopravvenuta nelle more del giudizio, nulla dice sul punto) per stabilire qual è l’organo regionale competente a stipulare l’intesa (sentenza 242).
4.4.11. Le funzioni amministrative
Quanto alla distribuzione delle funzioni amministrative, di cui all’art. 118 Costituzione, la Corte ha individuato nel secondo comma un riserva di legge per la loro allocazione e distribuzione tra i diversi livelli di governo, riserva che non può ritenersi soddisfatta da una legge regionale che si limita ad autorizzare l’esercizio, in via “suppletiva”, del potere regolamentare, senza delimitarlo o indirizzarlo in alcun modo (sentenza 324).
Riguardo al principio di sussidiarietà, la già più volte richiamata sentenza 303 afferma che la funzione che l’art. 118 assegna a tale principio “si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale. Enunciato nella legge 59/1997 come criterio ispiratore della distribuzione legale delle funzioni amministrative fra lo Stato e gli altri enti territoriali e quindi già operante nella sua dimensione meramente statica, come fondamento di un ordine prestabilito di competenze, quel principio, con la sua incorporazione nel testo della Costituzione, ha visto mutare il proprio significato. Accanto alla primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti, attiva una vocazione dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare non più come ratio ispiratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fattore di flessibilità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie”.
Quanto alla sussidiarietà c.d. “orizzontale”, cui si riferisce l’art. 118, comma 4, Costituzione, la Corte ha affermato che le persone giuridiche private che, come le fondazioni di origine bancaria, operano in tale campo, appartengono alla sfera dei “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” e non delle funzioni pubbliche, sfuggendo quindi alla disciplina regionale (sentenza 300).
In sostanziale continuità con la giurisprudenza relativa al vecchio Titolo V è stata ribadita la centralità del principio di leale collaborazione. Di conseguenza, un decreto ministeriale in materia di competenza concorrente, adottato senza il parere della Conferenza Stato-regioni, previsto dalla legge, è stato ritenuto viziato, indipendentemente dal problema della perdurante utilizzabilità, dopo la riforma, della legge su cui il decreto stesso si fondava: è infatti violato, direttamente, il principio di leale collaborazione (sentenza 88).
Circa la dibattuta questione della sorte della funzione di indirizzo e coordinamento dopo la riforma del Titolo V, la Corte ha affermato che “è da escludere la permanenza in capo allo Stato del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione alla materia de qua, anche alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 8, comma 6, della legge 131/03 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 3/2001), il quale stabilisce che ‘nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 8 della legge 59/1997, e all’art. 4 del D.Lgs 112/98’” (sentenza 329).
4.4.12. L’autonomia finanziaria
Circa l’autonomia finanziaria prevista dall’art. 119, la Corte si è pronunciata sulla nozione di “tributi propri” della regione, di cui al comma 2. Secondo la Corte, entro tale categoria rientrano i “soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale”. Pertanto, una imposta come l’Irap, istituita con legge statale, rispetto alla quale “alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo”, non può considerarsi, nonostante la sua denominazione, “tributo proprio della regione”, con la conseguenza che “la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e)” (sentenza 296). Analogo discorso vale per la tassa automobilistica, in ordine alla quale “alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa” (sentenze 296, 297, 311; sul carattere statale dell’imposta sul reddito, sentenza 370).
Di primario rilievo per l’interpretazione dell’art. 119 è la sentenza 370. Con essa la Corte dichiara incostituzionale la disposizione che prevede un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato per funzioni (relative agli asili nido) proprie delle regioni e degli enti locali. “Il nuovo art. 119 della Costituzione – afferma la Corte – prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere ‘integralmente’ finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell’ente interessato, di cui al secondo comma, nonché con quote del ‘fondo perequativo senza vincoli di destinazione’, di cui al terzo comma. Gli altri possibili finanziamenti da parte dello Stato, previsti dal quinto comma, sono costituiti solo da risorse eventuali ed aggiuntive ‘per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio’ delle funzioni, ed erogati in favore ‘di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni’. Pertanto, nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all’art. 119, terzo comma, della Costituzione”. In tale decisione è contenuto anche un deciso richiamo al legislatore: “appare evidente che la attuazione dell’art. 119 Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l’art. 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali”.
4.4.13. Il potere sostitutivo
Quanto al potere sostitutivo dell’art. 120, la Corte ha escluso che ad esso debba farsi ricorso per quelle funzioni amministrative che lo Stato, per ragioni di sussidiarietà e adeguatezza, abbia assunto ed organizzato con legge. Queste debbono essere distinte da quelle che “spettano alle Regioni e per le quali lo Stato, non ricorrendo i presupposti per la loro assunzione in sussidiarietà, eserciti poteri in via sostitutiva”. Quando si applichi il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Costituzione, quelle esigenze unitarie “che giustificano l’attrazione della funzione amministrativa per sussidiarietà consentono di conservare in capo allo Stato poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti. In breve, la già avvenuta assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l’intervento sollecitatorio diretto a vincere l’inerzia regionale. Nella fattispecie di cui all’art. 120 Costituzione [potere sostitutivo], invece, l’inerzia della Regione è il presupposto che legittima la sostituzione statale nell’esercizio di una competenza che è e resta propria dell’ente sostituito” (sentenza 303).
Circa la possibilità, per le regioni, di sostituirsi agli organi degli enti locali, la Corte ha affermato che, anche qualora in ipotesi tali poteri, ulteriori rispetto a quelli facenti capo al governo ai sensi dell’art. 120, siano da ammettere, debbono sussistere alcune garanzie,quali: a) essere ascritti a organi di governo della regione; b) l’omissione deve essere un fatto giuridicamente qualificato; c) il procedimento deve essere definito dalla legge e l’ente sostituito deve essere messo in grado di far valere le proprie ragioni e di ovviare all’omissione (sentenza 313).
4.4.14. Le modifiche territoriali
Quanto all’art. 133 Costituzione (norma non toccata dalla riforma costituzionale), la Corte ha ribadito che “è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero ad un altro comune preesistente;…e che, in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l’ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta”. Peraltro, le condizioni che possono giustificare la limitazione del referendum alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale – vale a dire una preesistente individualità della comunità costituente la frazione stessa e l’assenza di significativi interessi coinvolti nella variazione, facenti capo alla restante parte del comune da cui la frazione intende distaccarsi – debbono essere definite dal legislatore regionale, così che se ne possa apprezzare la ragionevolezza, e comunque la loro esistenza deve essere verificata in concreto dall’organo regionale che delibera di far luogo al referendum, con decisione motivata suscettibile di essere controllata in sede giurisdizionale (sentenza 47).