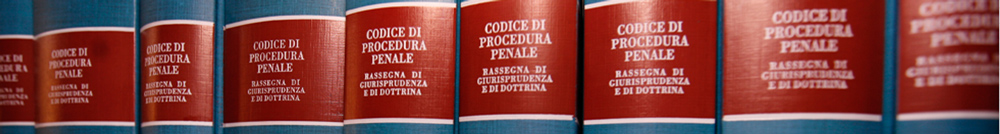Penale
Il procedimento penale è soggetto ad impulso d’ ufficio, quindi la parte civile può a buon titolo lamentarsi della sua eccessiva durata e chiedere il risarcimento ai sensi della legge Pinto.Cassazione Sez. prima civile – sentenza 18 maggio-17 settembre 20
Il procedimento penale è soggetto ad impulso d’ufficio, quindi la parte
civile può a buon titolo lamentarsi della sua eccessiva durata e chiedere il
risarcimento ai sensi della legge Pinto
Cassazione Sez.
prima civile – sentenza 18 maggio-17 settembre 2004, n. 18723
Presidente Olla – Relatore Criscuolo
Pm Carestia – conforme – ricorrente
Conciatore – controricorrente ministero della Giustizia
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ai sensi degli
articoli 2 e ss. della legge 89/2001, Liana Conciatore si rivolse alla Corte di appello di Torino, esponendo che ella si era costituita
parte civile nel procedimento penale a carico di Tiziano Mugnai, iniziato il 14
ottobre 1991 in seguito all’esercizio dell’azione penale promossa dal
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il quale aveva
formulato richiesta di rinvio a giudizio dello stesso Mugnai per i reati di cui
agli articoli 216, comma primo (n. 1 e 2) e comma secondo, 217, comma primo (n.
4), 219, commi primo e secondo, del Rd 267/42 (legge
fallimentare); 11 e 81, comma secondo, 640, 61, n. 2 e 7, 110 Cp; 2621, n. 1, Cc.
La parte ricorrente aggiunse che il
detto procedimento penale era stato definito soltanto il 30 maggio 2001, con
pronuncia della quinta sezione penale di questa Corte che aveva confermato la
pena di anni otto di reclusione, inflitta al Mugnai
dalla Corte di appello di Genova il 12 maggio 1999.
Su tali premesse, l’istante chiese
che fosse determinata a suo favore l’equa riparazione di cui alla citata legge
89/2001, stante la violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. ratificata
ai sensi della legge 848/55 (dora in avanti, Convenzione), sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole conseguente all’eccessiva durata del
menzionato procedimento penale. Ed a sostegno della domanda produsse copia
della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu),
con la quale detta Corte aveva liquidato a titolo di
danno morale la somma di lire 12 milioni ad altro creditore (Venturini Alberto) costituitosi parte civile nel
procedimento penale a carico del Mugnai, perché tale processo si era protratto
oltre termini ragionevoli.
Il ministero della Giustizia si
costituì per resistere alla domanda.
La Corte di appello
di Torino, col decreto indicato in epigrafe, respinse il ricorso e compensò tra
le parti le spese del procedimento, considerando (per quanto qui rileva):
che il menzionato procedimento penale
aveva avuto ad oggetto una vicenda dì notevole complessità, nella quale il
Mugnai (in concorso con altri) aveva spiegato un’ampia attività
d’intermediazione nella raccolta del risparmio nella Liguria di Levante e in
Toscana, irretendo intere famiglie con la prospettiva di ottimi quanto
azzardati guadagni;
che, secondo le risultanze di una
memoria esibita, le indagini giudiziarie avrebbero coinvolto il comparto
bancario locale, nonché gli organi di vigilanza e taluni agenti di cambio di
Milano, e ciò poneva ulteriormente in rilievo la complessità di un procedimento
che aveva visto nel giudizio di primo grado l’audizione di circa settecento
testimoni;
che in questa situazione la parte
ricorrente, proprio per sostenere le ragioni delle sue doglianze, «avrebbe
dovuto specificare passo passo le cadenze dei ritardi
lamentati e argomentare analiticamente in proposito, e non affidarsi ad una
generica enunciazione di decorso del tempo di cui non ha offerto alcuna
specifica chiave di lettura, se non in senso contrario alla propria pretesa
risarcitoria»;
che la parte ricorrente non aveva
ritenuto di avvalersi della facoltà ‑ prevista dall’articolo 3, comma
quinto, della legge 89/2001 ‑ che le consentiva di chiedere
l’acquisizione degli atti e dei documenti del processo Mugnai, sicché la Corte
adita non era stata messa in grado di valutare in concreto (al fine di
stabilire la sussistenza del mancato rispetto del termine ragionevole) gli
elementi contemplati dall’articolo 2, comma secondo, della legge citata, e tale
difetto di prova non poteva essere sanato dal mero richiamo alla sentenza
pronunziata il 25 ottobre 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (nella
causa promossa dal Venturini), costituente un
semplice precedente.
Avverso il suddetto
decreto la parte privata indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico articolato motivo.
Il ministero della Giustizia ha
resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il resistente Ministero ha
eccepito la nullità del ricorso per cassazione, «in quanto sottoscritto da
persona non identificabile e comunque certamente
diversa sia dall’avvocato cui in epigrafe si dichiara il conferimento di
procura speciale, sia da chi ha autenticato la firma della parte nella procura
speciale (dunque, per tale verso la procura è di per sé inefficace)».
L’illegittimità della sottoscrizione
del ricorso (e, nella specie, anche dell’autentica della procura)
determinerebbe la nullità dell’atto.
L’eccezione non è fondata.
Nell’epigrafe del ricorso la parte
ricorrente è rappresentata e difesa dall’avv. Sandra Landi,
“come da procura speciale posta in calce al presente atto”. Il ricorso, poi,
reca in calce la sottoscrizione del difensore (a fianco della data) e tale
firma, apposta in forma contratta, è in realtà poco leggibile. Ma subito dopo si trova la procura speciale conferita al
detto difensore, con l’autentica del medesimo che, ancorché di difficile
lettura (come molte sottoscrizioni), è compatibile col nome ora indicato.
Orbene, il collegio non ignora il
principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il carattere non
leggibile della firma del difensore non rende il ricorso per cassazione
inammissibile, quando però non ne sia contestata la
provenienza. Tuttavia, ritiene che nella specie la contestazione sollevata non
sia idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, perché:
a) sia nell’intestazione dell’atto
sia nella procura speciale il nome completo del difensore è ben specificato; b)
il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso è integrato dalla
sottoscrizione che ha autenticato la procura; c) l’apposizione di entrambe le firme in calce all’atto, recante la precisa
indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza
della sottoscrizione al difensore medesimo e ciò esclude che tale firma possa
essere attribuita a “persona non identificabile”.
Ne deriva il rigetto dell’eccezione.
2. Il resistente ha eccepito,
inoltre, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che sarebbe carente della cosiddetta autosufficienza. La parte
ricorrente, infatti, non avrebbe indicato gli estremi concreti della
fattispecie, in particolare trascurando di chiarire l’esito della domanda
azionata mediante la costituzione di parte civile, il valore di quella domanda,
lo sviluppo del procedimento penale, quanti gradi o fasi abbia
avuto e così via.
L’eccezione non ha fondamento.
Il principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione postula che tale atto debba contenere in sé tutti
gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la
cassazione del provvedimento impugnato, ed altresì a permettere la valutazione
della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di fare rinvio e di accedere
a fonti estranee allo stesso ricorso (ex multis e tra
le più recenti: Cassazione, 12905/02; 12596/02).
Nel caso in esame il ricorso per
cassazione, dopo una sufficiente esposizione in fatto che dà conto dei termini
essenziali della vicenda processuale (pag. 1-4), svolge in modo adeguato le
critiche mosse al decreto impugnato, sia sotto il profilo della violazione o
falsa applicazione delle norme di diritto sia in ordine alla
denunziata insufficienza della motivazione, mentre gli elementi cui il
resistente si richiama attengono in realtà alla fondatezza della domanda e,
quindi, al merito.
3. Con l’unico articolato mezzo di cassazione la parte ricorrente, denunziando violazione e
falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza della Corte
territoriale, in primo luogo, nella parte in cui ha affermato che sarebbe stato
onere della parte medesima «specificare passo passo
le cadenze dei ritardi lamentati e argomentare analiticamente in proposito».
Osserva che, poiché il processo penale è caratterizzato dal principio
dell’impulso d’ufficio, la parte civile non potrebbe apportare alcun contributo
negativo né sarebbe in grado di porre rimedio alle inefficienze della macchina
giudiziaria, mentre (come più volte sottolineato dalla
Corte europea) la Convenzione imporrebbe agli Stati contraenti di organizzare
il proprio apparato giudiziario in guisa da consentire il rispetto degli
obblighi previsti dall’articolo 6, par. 1, della Convenzione medesima, in
particolare in ordine alla durata dei procedimenti.
A parte ciò, la tesi sostenuta dalla
Corte di merito avrebbe forse potuto giustificarsi soltanto riconducendo la
fattispecie nello schema dell’articolo 2043 Cc,
laddove ‑ come già affermato da questa Corte ‑ all’equa riparazione di cui all’articolo 2 della legge 89/2001 andrebbe
riconosciuto natura indennitaria.
A carico dello Stato sarebbe posta
un’obbligazione di risultato (la celebrazione del processo in termini
ragionevoli), con conseguente diritto del cittadino ‑ in caso d’inadempimento ‑ ad un indennizzo liquidato dal
giudice in via equitativa, come sì dovrebbe desumere dagli enunciati contenuti
nel testo normativo.
Pertanto il rilievo della Corte di appello ‑ secondo cui la parte ricorrente
avrebbe dovuto specificare passo per passo le cadenze dei ritardi lamentati e
argomentare analiticamente in proposito ‑non avrebbe fondamento, in quanto
nella domanda di equa riparazione la causa petendi
sarebbe identificata con l’indicazione del carattere irragionevole del tempo
processuale trascorso tra domanda e decisione. Unico onere a carico del
ricorrente sarebbe quello relativo ai danni. E tale onere sarebbe stato assolto perché, essendo stato
chiesto soltanto il ristoro del grave danno morale sofferto dalla parte, la
prova si sarebbe potuta agevolmente raggiungere con criteri presuntivi.
Configurando un onere probatorio nei
termini indicati nel decreto impugnato la Corte territoriale avrebbe disatteso
gli orientamenti della Corte di Strasburgo ed avrebbe travisato la stessa ratio della legge 89/2001. Infatti, non sarebbe
necessario dimostrare la sussistenza di una condotta colposa dell’autorità
giudicante, bastando una valutazione d’inadeguatezza del sistema giudiziario a
rendere giustizia in tempi ragionevoli, come posto in luce dalla Corte europea
che, anche nella sentenza pronunciata a favore di Alberto
Venturini (e relativa alla stessa vicenda processuale
di cui si tratta in questa causa), avrebbe rimarcato l’esistenza in Italia di
una pratica contraria alla Convenzione in ordine al rispetto di termini
ragionevoli nella durata dei processi.
Pertanto, si sarebbe dovuto ritenere
che ogni onere probatorio fosse superato dal deposito della citata sentenza.
La Corte di merito, poi, sarebbe
incorsa in ulteriore violazione della legge 89/2001,
limitandosi ad attribuire alla pronuncia della Corte di Strasburgo carattere di
mero precedente, mentre una interpretazione corretta della citata legge
imporrebbe una lettura di questa conforme agli indirizzi espressi nella
giurisprudenza della Corte europea. Invero, con la ratifica della Convenzione,
l’Italia si sarebbe obbligata al rispetto dei diritti in essa
garantiti e la Corte europea sarebbe stata istituita proprio per assicurare
l’osservanza della Convenzione medesima.
Quanto, poi, all’assunto del decreto
impugnato, secondo cui la parte privata non avrebbe inteso
avvalersi dell’articolo 3, comma quinto, della legge 89/2001, andrebbe rilevato
che la facoltà attribuita alle partì di richiedere l’acquisizione degli atti
relativi al processo a quo non farebbe venir meno i poteri di accertamento
demandati al giudice e discendenti dall’adozione del procedimento in camera di
consiglio (articoli 737 e ss. Cpc), nel corso del
quale il giudice può assumere informazioni.
L’ultima censura riguarda
un’affermazione, che sarebbe contenuta nel decreto impugnato, secondo cui
soltanto con la nuova normativa di cui alla legge 89/2001 per l’istante sarebbe sorto il diritto all’equa riparazione. La parte
privata afferma che, invece, tale diritto sussisteva nell’ordinamento italiano
fin dalla ratifica della Convenzione.
Quest’ultima censura (in sé esatta) è
tuttavia inammissibile, perché il decreto non contiene l’affermazione che gli viene attribuita.
Per il resto, il ricorso è fondato,
nei sensi in prosieguo indicati.
La legge 89/2001, nell’articolo 2
(primo comma) attribuisce il diritto ad un’equa riparazione alla parte, che
abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole dì cui all’articolo 6, par. 1, della
Convenzione medesima.
Il secondo comma di detta norma
stabilisce che, nell’accertare la violazione, il giudice considera la
complessità del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni
altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Il terzo comma detta le regole per
determinare la riparazione a norma dell’articolo 2056 Cc.
Il successivo articolo 3 disciplina il procedimento, che è modellato sul rito dei
procedimenti in camera di consiglio (articoli 737 e ss. Cpc).
Nell’interpretazione di detta
normativa questa Corte ha già chiarito che l’equa riparazione ‑ nella normativa medesima prevista ‑ integra un credito a contenuto indennitario e non risarcitorio. derivante
dall’inosservanza dell’articolo 6, par. 1, della Convenzione, con lesione del
diritto della persona alla definizione della propria causa in un termine
ragionevole (Cassazione, 2148/03; 920/03; 11046/02). In questo quadro, con
l’allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine
mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri
di normalità ed anche alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte
europea, l’istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria
(Cassazione, 1822/03), ed identifica quindi la causa petendi
della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale)
lamentato in conseguenza dell’ addotta violazione. La legge, poi, demanda
all’interprete (e, segnatamente, al giudice) accertare in concreto la
violazione e determinare la riparazione a norma dell’articolo 2056 Cc, in base ai criteri dalla legge stessa dettati. Ciò
emerge con chiarezza dal tenore dell’articolo 2, commi
2° e 3° della legge 89/2001. E, peraltro, è anche coerente con il modello procedimentale adottato, cioè con
il rito camerale (articoli 737 e ss. Cpc),
caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, nonché dal potere
del giudice di assumere informazioni e di decidere in base ad esse (il che
postula necessariamente un minor rigore nella valutazione dei poteri di
allegazione incombenti sulle parti). Nel caso in esame la parte ricorrente
aveva chiesto che si accertasse la violazione dell’articolo 6, par. 1, della
Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole,
adducendo la propria qualità di parte civile costituita nel procedimento penale
di cui in narrativa, iniziato il 14 ottobre 1991 e definito il 30 maggio 2001,
sostenendo di aver subito un danno morale per tale durata, in conseguenza delle
profonde ripercussioni personali, sociali e familiari, e rimarcando che la Cedu, giudicando su un ricorso promosso da altro cittadino
italiano, del pari costituito parte civile nel medesimo procedimento penale,
aveva accertato la responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al
pagamento di lire 12 milioni a titolo di danno morale.
In relazione alla domanda cosi proposta, e nel quadro
dei principi ora enunciati, la pronunzia emessa dalla Corte torinese non è
conforme a diritto.
Infatti il decreto impugnato, pur ponendo
l’accento sul carattere complesso del procedimento penale in questione (che,
nel corso del processo di primo grado, avrebbe visto l’esame di circa
settecento testimoni), non ha poi tratto da tale valutazione alcuna
conseguenza, in particolare trascurando di accertare ‑ secondo i criteri previsti
dall’articolo 2, primo comma, della legge 89/2001 ‑ il termine ragionevole per la
definizione di quel procedimento (nei tre gradi in cui, a quanto si desume
dallo stesso decreto impugnato, esso risulta essersi articolato) e l’eventuale
superamento di detto termine. Esso, invece, ha attribuito alla parte ricorrente
l’onere «di specificare passo passo le cadenze dei
ritardi lamentati e argomentare analiticamente in proposito». Ma, come si è visto, la legge affida l’accertamento della
violazione al giudice. La parte ha senza dubbio un onere di allegazione
e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data
iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui
si è articolato (e tale onere nella specie è stato adempiuto, a quanto è dato
evincere dalla pur scarna esposizione del decreto impugnato). Spetta poi al
giudice ‑ sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente
addotti dalla parte resistente ‑verificare in concreto e con riguardo
alla singola fattispecie se vi sia stata violazione
del termine ragionevole di durata, utilizzando i parametri normativi (articolo
2, comma 2°, legge n. 89 cit.) e quelli elaborati in via d’interpretazione
dalla giurisprudenza (nazionale ed internazionale), nonché valutando eventuali
peculiarità della vicenda idonee a giustificare un prolungamento del termine di
durata della procedura o ad escludere la riferibilità del ritardo a disfunzioni
dell’organizzazione giudiziaria.
Né può condividersi il rilievo della
Corte territoriale secondo cui la parte privata, non avvalendosi della facoltà
riconosciuta dall’articolo 3, comma quinto, della legge 89/2001, avrebbe posto la Corte stessa nell’impossibilità di valutare
gli elementi previsti dall’articolo 2, comma secondo, di detta legge. Si deve
replicare che l’impianto di quest’ultima, adottando
il modello processuale di cui agli articoli 737 e ss. Cpc,
attribuisce al giudice poteri d’iniziativa, i quali si estrinsecano
attraverso l’assunzione d’informazioni che, espressamente prevista
dall’articolo 738 Cpc, non. resta
subordinata all’istanza di parte. Vero è che il giudice non è obbligato ad
esercitare tali poteri, potendo attingere aliunde le
fonti del proprio convincimento. In tal caso, tuttavia, non può limitarsi a
registrare una (asserita) carenza probatoria ma deve
decidere (in senso positivo o negativo) sulla pretesa azionata dalla parte,
perché ‑ nel momento in cui la legge affida al giudice la funzione di
accertare se vi è stata violazione della Convenzione nell’ambito di un
procedimento caratterizzato anche da poteri d’iniziativa d’ufficio ‑ non può essere ascritta alla parte
una carenza probatoria superabile con l’esercizio di quei poteri.
La Corte torinese, dunque, ha
trascurato di compiere il menzionato accertamento, limitandosi ad una
valutazione della fattispecie astratta ed avulsa da ogni riferimento alle
circostanze del caso concreto.
Così operando, essa è incorsa in
violazione dell’articolo 2 (comma 2°) della legge 89/2001 e dello stesso
articolo 6, par. 1, della Convenzione,, la cui
normativa è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la forza di legge
propria dell’atto contenente il relativo ordine di esecuzione (legge 848/55),
onde ha il valore di fonte normativa primaria (Cassazione, 6672/98). Ed altra
violazione della citata normativa (violazione del pari
denunciata dalla parte ricorrente) si rinviene nella circostanza che la
Corte di merito, ad onta della specifica allegazione di detta parte, ha in
sostanza ignorato (limitandosi a definirla, in modo apodittico, un “mero
precedente”) la pronuncia emessa dalla Corte di Strasburgo nella causa promossa
da Alberto Venturini e relativa allo stesso
procedimento penale del quale qui si discute.
Infatti, pur se le sentenze della
Corte di Strasburgo (in tema d’interpretazione dell’articolo 6, par. 1, della
Convenzione) non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice
italiano, esse, nondimeno,, costituiscono la prima e
più importante guida ermeneutica per tale giudice (così Cassazione, 16262/02;
v. anche Cassazione, 11046/02, in motivazione, e da ultimo Cassazione, Su,
1338/04, 1339, 1340), il quale dunque deve farsi carico di quelle decisioni,
eventualmente esponendo i motivi in base ai quali ‑ e in relazione alle circostanze del
caso concreto ‑ ritiene di dover pervenire ad un
risultato ermeneutico diverso.
Nella fattispecie, l’aver trascurato
la sentenza della Cedu vizia il provvedimento
impugnato perché non è stata considerata la rilevanza che quella pronuncia
rivestiva nell’enunciazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. al riguardo, in particolare, Cassazione, Su, 1339/04, in
motivazione).
Quanto agli argomenti svolti nel controricorso dal resistente, secondo cui, “una volta
accertato il superamento del termine ragionevole”, si sarebbe
dovuto accertare il fatto, il danno e il rapporto causale tra il primo e
il secondo, si deve osservare che nel caso in esame è mancato proprio
l’accertamento preliminare (superamento o meno del termine ragionevole), e ciò
è sufficiente a viziare il provvedimento impugnato.
Conclusivamente, ed alla stregua
delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, il decreto
impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra
sezione della Corte di appello di Torino che si
uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
PQM
La
Corte
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra Sezione della
Corte di appello di Torino, anche per le spese del
giudizio di cassazione.