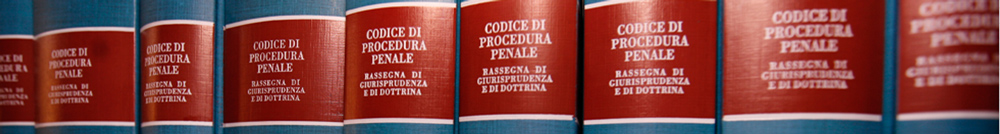Lavoro e Previdenza
E’ legittimo il licenziamento di chi, violando il dovere di fedeltà – art. 2105 c.c. – abbia cagionato un danno all’ immagine dell’ azienda
E legittimo il licenziamento di chi, violando il dovere di fedeltà art. 2105 c.c. abbia cagionato un danno allimmagine dellazienda
Cassazione Sezione lavoro sentenza 11 novembre-14 giugno 2004, n. 11220
Presidente Sciarelli Relatore Stile
ricorrente Di Meo
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice del lavoro di Trani dei 14 luglio 1999, ling. Pietro Di Meo esponeva che con lettera 30 maggio 1988 era stato assunto alle dipendenze dellAmet, svolgendo le funzioni di coordinatore delle problematiche informatiche in azienda (Gruppo A ‑ cat. A/1 del Ccnl).
Aggiungeva che, in seguito a missiva del 19 novembre 1991, gli erano state attribuite dallazienda mansioni dequalificanti di addetto allUfficio commerciale, escludendo quelle relative al sistema informatico, le quali venivano assegnate al capo dellufficio commerciale; che, denunciata tale dequalificazione anche in via giudiziale, con sentenza del 25 ottobre 1996 gli era stato riconosciuto il diritto alle mansioni di assunzione, ‑ che listante e le Associazioni di categoria avevano contestato loperato dellente municipalizzato in ordine al concorso bandito il 21 febbraio1994 per posto di spettanza di specialista polivalente già presente in azienda; ‑ che, invocando infondati addebiti, lAmet dapprima aveva adottato un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, impugnato giudizialmente, e poi con lettera 28 aprile 1994 un atto di licenziamento, dichiarato illegittimo con le conseguenze di legge in via cautelare dal Pretore dei lavoro di Trani con ordinanza del 29 giugno 1994, confermata in sede di reclamo con provvedimento 4 ottobre 1994; ‑ che, pendente il giudizio di merito, in data 4 luglio 1994 cm stato reintegrato nel posto di lavoro, ma di fatto emarginato da qualsiasi attività lavorativa inerente le proprie mansioni, con laffidamento di compiti di archivista e di semplice immettitore di dati nel computer (impiegato di livello BI), ‑ che il 7 aprile 1995 gli era stato finalmente assegnato un compito progettuale completato nel dicembre 1995, epoca dalla quale non gli veniva più affidata alcuna mansione; ‑ che tale inattività, retribuita per ben tre anni e per otto ore al giorno, aveva arrecato pregiudizio alla sua dignità e professionalità e assunto notorietà pubblica anche in conseguenza di una ispezione presso lAmet ordinata dal ministero del Lavoro; ‑ che lazienda il 4 dicembre 1998 gli aveva inviato la seguente missiva disciplinare: «in data 3 dicembre1998 questa Direzione è stata informata dei fatto che Ella ha esposto, al di fuori della porta del Suo ufficio, visibile da tutti i dipendenti e dagli utenti di passaggio, una fotocopia di un articolo giornalistico riportante Sue dichiara ioni lesive della immagine dellazienda e contenenti gravi accuse, anche a valenza penale, nei confronti del Direttore» che, nonostante le giustificazioni fornite il 12 dicembre 1998, con provvedimento 28 gennaio 1999, comunicato il successivo 29 gennaio, lAmet aveva disposto il suo licenziamento in tronco, ritenendo la commessa infrazione lesiva irreparabilmente dei rapporto di fiducia; ‑ che il Giudice del lavoro, adito con ricorso ex articolo700 Cpc, depositava in data 15 giugno 1999 ordinanza di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, rilevando come il comportamento contestato al dipendente non rivestiva il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro; ‑ che, con il ricorso in oggetto, introduttivo dellordinario giudizio di merito, intendeva ribadire lillegittimità dei provvedimento risolutivo impugnato con lettera del 3 febbraio1999, atteso il comportamento vessatorio dellazienda nei suoi riguardi; ‑ che in particolare laffissione di un articolo di giornale alla porta dellufficio non poteva configurare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto anche del suo stato di esasperazione in cm versava da tempo; ‑ che il contenuto dellintervista riportava fedelmente una vicenda reale ed era espressione dellesercizio del diritto di critica nei limiti della correttezza; ‑ che il gesto contestatogli non aveva arrecato alcun eventuale danno allazienda né vi era rapporto di proporzionalità con ladottata sanzione espulsiva; ‑ che il complessivo comportamento aziendale gli aveva cagionato un pregiudizio alla salute, oltre che allimmagine ed alla vita di relazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 28 gennaio 1999, di ordinare alla convenuta azienda la sua reintegra nel posto di lavoro, con ogni conseguenza ex articolo 18 Statuto lavoratori, nonché di condannare la medesima al risarcimento di ogni ulteriore danno anche biologico, coi favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, lAmet con diffuse argomentazioni contestava le deduzioni e le pretese avanzate dal Di Meo, concludendo per lintegrale reiezione dellinfondata domanda e la rifusione delle competenze.
Ladito Giudice del lavoro rigettava la domanda e, per leffetto, revocava il provvedimento durgenza dell11 giugno1999; condannava il Di Meo alla rifusione, in favore dellAmet, delle spese processuali anche per il giudizio cautelare. Avverso detta pronuncia, proponeva appello il Di Meo, il quale, dopo aver prospettato tutte le sue vicende lavorative e giudiziali, deduceva che non era attribuibile a lui lelaborazione giornalistica dellarticolo affisso dietro alla sua porta; che legittimamente era dato al lavoratore lesercizio del diritto di critica sulla base della verità oggettiva degli avvenimenti quando non si sostanziava in una condotta lesiva del decoro dellimpresa suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdite di commesse o di occasioni di lavoro. Assumeva di aver difeso la propria posizione senza aver travalicato con dolo o colpa grave la soglia del rispetto della verità oggettiva.
Precisava che non era stata neanche scossa la fiducia, che sottende al rapporto di lavoro con laffermazione che veniva pagato senza lavorare, concretizzando invece questo un grave pregiudizio alla sua dignità e professionalità. Comunque assumeva che non vi era una proporzionalità tra il fatto addebitato e il licenziamento.
Concludeva per la riforma della gravata sentenza e per laccoglimento della domanda.
Resisteva al gravame lappellata, la quale, deducendone linfondatezza. ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 31 gennaio 2002, ladita Corte dappello di Bari rigettava lappello, rilevando che la condotta del Di Meo, cosi come accertato, mediante lespletata istruttoria, fosse irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, con conseguente legittimità dellintimato licenziamento.
Per la Cassazione di tale decisione ricorre il Di Meo con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 Cpc. Resiste la Amet con controricorso.
Motivi della decisione
Con proposto ricorso, articolato in due motivi strettamente connessi, ling. Pietro Di Meo denuncia violazione degli articoli 21 e 24 Costituzione in relazione allarticolo 2105 Cc, illogica motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla veridicità dei fatti dichiarati, nonché, ancora, omessa e comunque insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia e violazione degli articoli 2106 Cc, 3 legge 604/66 e 2119 Cc.
In particolare, censura liter argomentativo della impugnata decisione, che, nel pervenire alle contestate conclusioni, avrebbe omesso di valutare una serie di circostanze decisive per la stessa qualificazione della fattispecie in relazione agli obblighi del prestatore, non risultando espletato qualsivoglia apprezzamento sui fatti o sugli antefatti, sulle pregresse vicende processuali e sul comportamento ingiusto e inadempiente del datore di lavoro; avrebbe ignorato completamente linadempimento della datrice ai propri obblighi e la perdurante situazione di frustrazione in cui egli versava, nonché lesigenza di tutelare un proprio diritto, leso dallAmet, nonostante la pronuncia giudiziale.
In tale contesto, la stessa decisione, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che 1) la divulgazione, da parte del lavoratore, a mezzo di dichiarazioni alla stampa, di fatti idonei a ledere limmagine dellazienda, gettando discredito sulla dirigenza, costituirebbe mancanza disciplinare idonea «a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro integrando la violazione dei dovere scaturente dallarticolo 2105 Cc» ed idonea, quindi, a costituire giusta causa di licenziamento, «a prescindere dalla verità o falsità della notizia»; 2) il diritto di critica del lavoratore troverebbe un limite nella rilevanza penale del fatto attribuito; 3) tutte le volte in cui il lavoratore, a fronte di comportamenti illeciti del datore di lavoro abbia la possibilità di far valere il proprio diritto in sede giudiziaria, allo stesso non sarebbe consentito denunciare lillegittimo comportamento del datore di lavoro a mezzo della stampa.
Le critiche sono infondate.
Giova, preliminarmente, puntualizzare che la Corte dappello di Bari, dopo avere esposto i termini della vicenda posta a base della vertenza in oggetto, a cominciare dalla nota aziendale dei 4 dicembre 1998, con la quale si comunicavano al Di Meo gli addebiti, di cui essa era venuta a conoscenza («In data 31 dicembre1998 questa direzione è stata informata del fatto che ella ha esposto, al di fuori della porta del suo ufficio, visibile da tutti i dipendenti e dagli utenti di passaggio, una fotocopia di. un articolo giornalistico riportante sue dichiarazioni lesive dellimmagine dellazienda e contenente gravi accuse, anche di valenza penale, nei confronti del direttore. Poiché si ravvisano gli estremi dellapplicazione di adeguato provvedimento disciplinare, fatta salva ogni altra azione [Omissis], vorrà esporre le sue giustificazioni in merito») e dalla nota di risposta del Di Meo, ritenuta dallazienda insoddisfacente, ha proceduto allanalisi sia del comportamento relativo allaffissione dellarticolo giornalistico sia del contenuto dello stesso in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal dipendente allarticolista, osservando che, già le espressioni contenute nellintestazione dellarticolo («Tre casi di mala burocrazia (uno dei tre era il caso Di Meo)» con sottotitolo: «Pagato solo per non lavorare. Amet, azienda speciale elettricità e trasporti di Trani, in provincia di Bari, una storia di ordinaria inefficienza. Vittima un ingegnere, pagato con soldi dei cittadini contribuenti, costretto a non lavorare»), erano da ritenersi offensive dellimmagine dellazienda e «tali da incidere sulla fiducia che deve sottendere ad ogni rapporto di lavoro ed a maggior ragione quando il dipendente è di un certo rango nella struttura, trattandosi di un ingegnere di alto livello di inquadramento».
Né rilevava ‑ ha ancora osservato il Giudice dappello ‑ che dette espressioni non fossero, in ipotesi, emanazione del pensiero del Di Meo, ma una formulazione del giornalista, per far notizia, poiché il fatto stesso della affissione dietro la porta dei suo ufficio, comportava la sua approvazione, facendola propria e condividendo tutto larticolo come formulato; altrimenti, lo stesso Di Meo avrebbe fatto pubblicare la smentita e poi non lo avrebbe affisso sulla porta del suo ufficio.
Proseguendo oltre nellanalisi dellarticolo, la Corte locale ha tenuto altresì ad evidenziare come esso esprimesse uno stato di conflittualità del dipendente con lazienda, che andava risolto in sede giudiziaria e non con una notizia giornalistica da ledere il decoro della datrice di lavoro ponendola in cattiva luce presso la opinione pubblica, a prescindere dalla verità o falsità della notizia, data la sua potenzialità offensiva dellimmagine aziendale. A ciò erano da aggiungersi dichiarazioni accusatorie di rilevanza penale da parte del Di Meo, contenute nel medesimo articolo, per avergli il direttore dellAmet consigliato, senza successo, di acquistare i computers da una ditta specifica.
Orbene ‑ ad avviso del Giudice dappello ‑ tali dichiarazioni, allusive di un tentativo di corruzione ad opera dei direttore nei confronti del ricorrente, per le quali il lavoratore è stato anche denunciato allAutorità giudiziaria per calunnia, andavano ben oltre il diritto di critica del lavoratore, dal momento che di fatto lo stesso si era realizzato in accuse di rilevanza penale da parte del Di Meo in danno della datrice di lavoro; dichiarazioni accusatorie, tali da scuotere irrimediabilmente la fiducia dellimprenditore, essenziale presupposto per la prosecuzione della collaborazione del dipendente.
Così argomentando, il giudice di merito ha ulteriormente ritenuto di specificare che lentità delle accuse mosse dal Di Meo allAmet e ai suoi dirigenti, unitamente allinevitabile discredito sociale patito dallazienda, in conseguenza delle dichiarazioni, costituivano violazione del dettato normativo e contrattuale in materia di rapporto di lavoro subordinato, menomando la stima e la reputazione del datore di lavoro, che non trovava giustificazione neanche il relazione al diritto di critica costituzionalmente tutelato dallarticolo 21 Costituzione
Siffatte considerazioni non meritano le censure avanzate con il ricorso in esame.
Va, in proposito, rammentato che ‑ come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cassazione su 13 045/97) ‑ il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice dei merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed alluopo valutarne le prove, controllarne lattendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza alluno o allaltro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dallordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame dei fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di Cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, lesistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre largomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Nel giudizio di Cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cassazione 5 196/91).
Orbene, la motivazione della sentenza della Corte dappello di Bari appare esauriente, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico.
Il Giudice dappello ha spiegato, con dovizia di argomentazioni, le ragioni che hanno condotto al licenziamento di Meo, vagliando attentamente le risultanze istruttorie e sottoponendo ad accurato esame la condotta che si è tradotta in una lesione dellimmagine della società Amet, ad opera del suo dipendente.
Nel fare ciò, la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha violato alcuna norma giuridica, né per quanto riguarda il principio costituzionale dellarticolo 21 Costituzione, di cui il diritto di critica e di cronaca costituisce significativa espressione, né per quanto attiene ai principi fissati dallarticolo 2105 Cc.
Questa Corte ha statuito che la forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta, di serenità o obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità e di immagine cui ogni persona fisica o giuridica ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza; ciò si riscontra allorquando si ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli di articoli o pubblicazioni, o comunque allartificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, nonché alla vere e proprie insinuazioni (cfr. al riguardo Cassazione 495/982).
Questa Corte ha già evidenziato come il diritto di cronaca debba rispettare il principio della continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della continenza formale (secondo cui lesposizione dei fatti deve avvenire misuratamente), precisando al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza cosiddetta formale, comportante anche losservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate, è attenuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite(cfr. in tali sensi Cassazione 465/96 nonché Cassazione 5947/97, secondo cui per il principio della continenza cd. formale lesposizione dei fatti non deve eccedere lintento informativo e deve risultare corretta ed obiettiva). Se anche ‑ come ha puntualizzato la stessa Corte è necessario andare alla ricerca di un bilanciamento dellinteresse che si assume leso con quello che non siano introdotte limitazione alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantito (cfr. in tali sensi Cassazione 465/96 cit.) ciò però non legittima un esercizio del diritto di critica del tutto libero e del tutto svincolato dal doveroso rispetto della logica e delle fondamentali regole del vivere civile.
Per la natura dellesame e delle indagini da effettuare, le conclusioni cui al loro esito perviene il giudice di merito non sono ‑ come si è già ribadito censurabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua, priva di salti logici, e rispettosa dei principi di continenza sostanziale e formale cui deve sottostare il diritto di critica.
Alla stregua delle considerazioni sinora svolte non merita alcuna censura la decisione impugnata che, esaminando in maniera attenta il contenuto degli addebiti mosse dal Di Meo allazienda, ne ha evidenziato il carattere lesivo e ed ha poi rilevato ‑ con una motivazione esauriente e del tutto corretta sul piano logico-giuridico ‑, che non poteva giustificarsi il suo comportamento con richiamarsi al diritto di critica, per avere violato i limiti che lordinamento pone allesercizio di tale diritto.
Non merita accoglimento neanche laltra censura con la quale il ricorrente lamenta una violazione dellarticolo 2105 Cc.
Questa Corte ha più volte affermato che lobbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare. come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nellobbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti dei datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc. Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dallarticolo 2105 Cc, ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi allinserimento del lavoratore nella struttura e nellorganizzazione dellimpresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dellimpresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso (ex plurimis 11437/95).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è suscettibile di violare il disposto dellarticolo 2105 Cc e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio da parte di questultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si sia tradotto ‑ come è avvenuto nel caso di specie ‑ in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro. Una siffatta lesione del carattere fiduciario del rapporto lavorativo va accertata dal giudice di merito con giudizio sindacabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. E, nella specie, il giudice di merito ha accertato che nel fatto dedotto ed allegato «non erano ravvisabili elementi di discriminazione o di emarginazione del lavoratore, comunque da non giustificare mai laddebito mossogli dallazienda».
Per concludere, la sentenza impugnata, per essere sorretta da una motivazione e o esauriente e corretta sul piano logico e giuridico, anche in ordine alla proporzione del provvedimento risolutivo adottato rispetto alla gravità del comportamento, si sottrae alle critiche che le sono state mosse.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 30,00, oltre euro 2.000,00 per onorari.