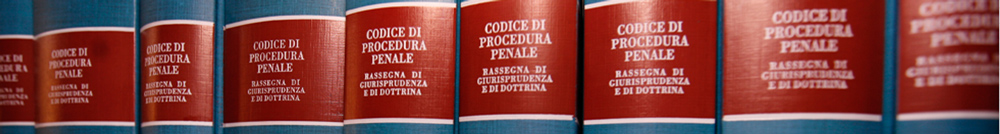Lavoro e Previdenza
Danno esistenziale da licenziamento illegittimo – Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, sentenza depositata il 25 luglio 2003
Danno esistenziale da licenziamento illegittimo
Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, sentenza depositata il 25 luglio 2003
(stralcio)
giudice Francesco Buffa
(&omissis &)
Istruita la causa innanzi a sé, all’esito della discussione delle parti, in accoglimento dei reclami interposto dai ricorrenti, il tribunale in composizione collegiale riteneva fondate le doglianze dei ricorrenti, sia in ordine al fumus boni juris, che in relazione al periculum in mora. In particolare, il tribunale ravvisava il trasferimento di azienda e la violazione dei diritti dei lavoratori in ordine alla continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario. Giudicava altresì fondate le prospettazioni dei ricorrenti in ordine all’attualità e all’irreparabilità del danno che dal mancato riconoscimento dei diritti azionati loro poteva derivare nelle more del giudizio di merito, ritenendo che il mancato esercizio, per un tempo prolungato, dell’attività giornalistica poteva verosimilmente determinare una significativa compromissione della professionalità degli interessati.
Il tribunale, quindi, dichiarava che il rapporto di lavoro tra i reclamanti era proseguito con la s.r.l. A. e ordinava, di conseguenza, a quest’ultima di provvedere alla loro reintegrazione, con la qualifica posseduta alla data del 14/6/98, e al pagamento delle relative retribuzioni, così riformando l’ordinanza impugnata; rimetteva quindi alla decisione in sede di cognizione ordinaria anche ogni provvedimento sulle spese della fase cautelare. (&)
I ricorrenti introducevano quindi, tempestivamente, nel termine di giorni trenta assegnato dal giudice del provvedimento cautelare, il giudizio di merito. (&..)
I ricorrenti S e O chiedevano la conferma del provvedimento di merito reso in loro favore. Deducevano peraltro che il prolungato periodo di mancato esercizio della professione, trattandosi di un’attività di natura intellettuale con sue peculiari caratteristiche, aveva determinato e continuava ad arrecare loro una significativa compromissione della professionalità; infatti, l’inattività che si protraeva da vari mesi, e le stesse ingiuriose modalità con le quali era avvenuto il loro allontanamento dalla redazione in data 6/7/98, avevano arrecato un pregiudizio notevole alla loro immagine ed avevano compromesso la continuità dei rapporti con le fonti dirette di informazione, con gli investigatori, i politici, gli amministratori locali i rappresentati della associazioni sindacali, ordini professionali ecc., ciò che consentiva loro di redigere quotidianamente gli articoli della cronaca di Brindisi, ad un livello professionale tale da arricchire e qualificare il giornale presso un vasto numero di lettori. L’ulteriore danno professionale deriva dalla impossibilità di utilizzare 1’archivio personale (costituito da numerosissimi documenti contenenti articoli, interviste, ricerche, dati cronologici di avvenimenti significativi della cronaca locale e nazionale) immagazzinato nella memoria del sistema informatico del giornale (ora cancellato, a cui era possibile accedere con il rispettivo codice segreto). Tale compromissione del bagaglio professionale acquisito in un lungo periodo di esercizio della professione giornalistica aveva determinato in entrambi un danno patrimoniale che si chiedeva fosse liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cc. e dell’art 432 c.p.c. Il trauma derivante dalla forzata inattività e dalle modalità di allontanamento dalla redazione aveva altresì arrecato ai ricorrenti un danno biologico ed alla salute che espressamente i ricorrenti detti riservavano di richiedere in un separato giudizio.
Chiedevano quindi:
dichiararsi e riconoscersi che il contratto ed il rapporto di lavoro in corso tra i ricorrenti e la E. srl alla data del 14/06/98 prosegue con l’A. srl. alle medesime condizioni in essere a tale data, con tutti gli ulteriori diritti conseguenti all’applicazione dell’art. 2112 c.c., dichiarando, ove occorra, nullo, invalido e comunque illegittimo ed inefficace il licenziamento verbale in data 04/07/98 ed ogni altro atto conseguente;
per l’effetto, confermare l’ordine di reintegrazione dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro, con la qualifica e le mansioni svolte presso la redazione di Brindisi, a cui erano addetti alla stessa data del 14/06/98, dichiarando nulla, invalida, inefficace e comunque illegittima la decurtazione della retribuzione comunicata con lettera del 23/07/98;
condannare l’A. s.r.l. al pagamento, in loro favore, delle retribuzioni , nella misura corrispondente alla paga globale di fatto alla data del 14/06/98, maturate e maturande fino alla data dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, da determinarsi occorrendo con CTU, ed al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, con gli interessi e l’eventuale indennizzo da svalutazione monetaria come per legge, ed all’accantonamento della somma corrispondente al T.F.R. maturato dalla data dell’originaria assunzione, ai sensi dell’an. 2120 c.c., nella misura risultante dai prospetti paga prodotti o comunque da determinarsi con CTU;
dichiararsi e riconoscersi il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno derivante dalla mancata puntuale erogazione delle retribuzioni nella misura da determinarsi con CTU, ed all’ulteriore risarcimento del danno conseguente al pregiudizio della professionalità acquisita derivante dal lungo periodo di inattività, da determinarsi in via equitativa anche ai sensi dell’art.1226 cc. e dell’art. 432 c.p.c., e condannarsi per l’effetto l’A. Editoriale s.r.l. al pagamento in loro favore delle somme come innanzi determinate e che si riterranno eque e di giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannarsi l’A. s.r.l. e la E. s.r.l. , in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti, onorari, rimborso spese forfettario, C.A.P. ed I.V.A., relative al procedimento cautelare, innanzi al pretore ed al tribunale di Lecce, ed a quelle del presente giudizio di merito, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
(&omissis&.).
Con ricorso del 28.12.99, la ricorrente M. esponeva che aveva collaborato continuativamente con la E., realizzando inchieste e servizi di cronaca locale ed in alcune occasioni anche nazionale, frequentando la redazione assiduamente, occupandosi della pagina del quotidiano (&) per la quale disegnava i menabò, sceglieva gli argomenti da trattare, scriveva la maggior parte degli articoli che vi comparivano (commissionando gli altri a corrispondenti e collaboratori), possedendo le chiavi di ingresso della redazione ove lavorava, avendo a disposizione un computer con password di accesso, un proprio archivio dati ed una scrivania. Deduceva che il proprio era un rapporto di lavoro subordinato, protraendosi oltre le 24 ore settimanali, con orario fisso, soggezione al potere direttivo del datore, continuità del compenso; rilevava che formalmente era stata qualificata pubblicista e collaboratrice occasionale, laddove aveva svolto mansioni corrispondenti a quelle di praticantato dapprima e poi di giornalista professionista; lamentava che in relazione alla promessa di assunzione nel 1992 aveva dato le dimissioni dal proprio impiego presso l’Ufficio tecnico erariale di Brindisi dedicandosi in via esclusiva all’attività di giornalista; rilevava infine che aveva svolto tale rapporto per anni e che all’esito della cessione dell’azienda alla A, aveva continuato il proprio rapporto formalmente qualificato di collaborazione occasionale- anche con la A.. Tanto premesso, invocava il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con versamento dei contributi previdenziali presso l’INPGI; produceva conteggi specifici dai quali risultava un credito di oltre £. 267 milioni, dei quali chiedeva la condanna delle convenute in solido; chiedeva poi la condanna ulteriore dell’A. al pagamento della somma di oltre £. 44 milioni, quale equo compenso per l’attività prestata direttamente in concreto alle sue dipendenze, ovvero in via subordinata al pagamento della retribuzione globale di fatto in essere alla data del 14.6.98 fino alla effettiva reintegra nel posto di lavoro; chiedeva altresì l’accertamento del passaggio del rapporto alla A a seguito della cessione di azienda, con le medesime qualifica e mansioni spettante di diritto o almeno in essere alla data del 14.6.98, con conseguente ordine alla resistente A di reintegrarla presso la redazione di Brindisi. Chiedeva infine il risarcimento del danno alla professionalità subito per il periodo di inattività a decorrere dal febbraio 1999, danno da liquidarsi equitativamente.
Con memorie di costituzione, la società A (&omissis&) escludeva esservi stato un trasferimento di azienda e chiedeva il rigetto delle domande sul punto. Aggiungeva inoltre che, all’esito del provvedimento cautelare disposto dal tribunale in sede di reclamo ed in riforma della ordinanza pretoriale, aveva comunque reintegrato nella qualifica e nella retribuzione i ricorrenti, provvedendo altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali a decorrere dalla data di notizia del provvedimento giudiziario predetto, sicché non via poteva essere diritto ulteriore economico per il periodo successivo; quanto al periodo precedente ed alla relativa di richiesta di risarcimento danni, rilevava sul tema economico che essa era tenuta ad applicare solo i contratti collettivi nazionali di categoria e non anche i contratti collettivi aziendali, sicché non erano dovuti eventuali maggiori somme da questi ultimi previsti in favore dei ricorrenti al momento in cui essi si trovavano alle dipendenze della E.. Chiedeva il rigetto pieno dei ricorsi per tutte le domande spiegate ed in considerazione delle ragioni sopra indicate.
Con riferimento alle domande di S ed O di impugnazione del recesso datoriale orale, deduceva che nessun licenziamento era stato posto in essere per non essere mai stati i ricorrenti dipendenti della A, ma solo della E, dalla quale avevano percepito la retribuzione. Contestava che i ricorrenti avessero chiesto di fornire prova dei danni subiti (in specie la mancata rinegoziazione del mutuo per l’acquisto della casa di abitazione ovvero la contrazione di prestiti per il proprio sostentamento); infine, deduceva che infondata era la domanda relativa al danno professionale, poiché da un lato i contatti che i ricorrenti avevano non erano personali ma per conto del giornale, quindi erano patrimonio dei ricorrenti ma della società datrice di lavoro, e dall’altro lato la professionalità del giornalista consiste non nel bagaglio di contatti personali acquisiti, ma nella capacità di elaborare in articoli e servizi secondo la linea politico culturale del giornale le notizie che di volta in volta vengono a lui affidate, capacità che non viene meno per una eventuale interruzione del rapporto; concludeva rilevando che anche tali domande risarcitorie erano sfornite di ogni prova e pertanto andavano rigettate nel merito. &(omissis&) .
Con particolare riferimento alla domanda della ricorrente M., la resistente A ribadiva le eccezioni ora riportate ed inoltre rilevava che:
la ricorrente non era iscritta né nel registro dei praticanti giornalisti né nell’albo dei giornalisti professionisti all’epoca della nascita del rapporto;
la successiva iscrizione da parte del Consiglio dell’ordine era invalida in quanto non poteva retrodatare l’iscrizione ed inoltre, quale fatto sopravvenuto e sconosciuto all’asserito datore, non era allo stesso opponibile;
la richiesta economica era infondata in quanto riferita al trattamento economico e normativo previsto per il giornalista professionista redattore ordinario, qualifica che la ricorrente non aveva né poteva avere;
la domanda era comunque in parte prescritta, sino a 5 anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo della lite ex artt. 2947 e 2948 c.c.;
la richiesta di condanna alla ricostruzione della propria posizione previdenziale presso l’INPGI era infondata del pari in quanto la ricorrente, quand’anche avesse dimostrato la continuatività del proprio rapporto, non era iscritta all’albo dei giornalisti elenco professionisti, sicché al più poteva competere una posizione contributiva presso l’INPS;
la domanda risarcitoria del danno alla professionalità era del tutto priva dell’allegazione di elementi che potessero costituire un riferimento pur minimo ed indiziario all’an del danno, tanto più che il danno alla professionalità postula un lavoro di giornalista professionista nella specie mancante.
(& omissis&)
Il risarcimento dei danni da inattività.
I ricorrenti S e O, oltre a chiedere la conferma del provvedimento cautelare reso in loro favore, hanno dedotto peraltro che il prolungato periodo di mancato esercizio della professione, trattandosi di un’attività di natura intellettuale con sue peculiari caratteristiche, aveva determinato e continuava ad arrecare loro una significativa compromissione della professionalità; infatti, l’inattività che si protraeva da vari mesi, e le stesse ingiuriose modalità con le quali era avvenuto il loro allontanamento dalla redazione in data 6/7/98, avevano arrecato un pregiudizio notevole alla loro immagine ed avevano compromesso la continuità dei rapporti con le fonti dirette di informazione, con gli investigatori, i politici, gli amministratori locali, i rappresentati della associazioni sindacali, ordini professionali ecc., che consentiva loro di redigere quotidianamente gli articoli della cronaca di Brindisi, ad un livello professionale tale da arricchire e qualificare il giornale presso un vasto numero di lettori. L’ulteriore danno professionale derivava dalla impossibilità di utilizzare 1’archivio personale (costituito da numerosissimi documenti contenenti articoli, interviste, ricerche, dati cronologici di avvenimenti significativi della cronaca locale e nazionale) immagazzinato nella memoria del sistema informatico del giornale (ora cancellato, a cui era possibile accedere con il rispettivo codice segreto). Tale compromissione del bagaglio professionale acquisito in un lungo periodo di esercizio della professione giornalistica aveva determinato in entrambi un danno patrimoniale che si chiedeva fosse liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cc. e dell’art 432 c.p.c.
Chiedevano quindi sul punto dichiararsi e riconoscersi il loro diritto al risarcimento del danno conseguente al pregiudizio della professionalità acquisita derivante dal lungo periodo di inattività, da determinarsi in via equitativa anche ai sensi dell’art.1226 cc. e dell’art. 432 c.p.c., e condannarsi per l’effetto l’A s.r.l. al pagamento in loro favore delle somme ritenute eque e di giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria; riservavano invece azione separata in ordine ai danni biologici ed alla salute causati dal trauma derivante dalla forzata inattività e dalle modalità di allontanamento dalla redazione.
Anche la ricorrente M, nel ricorso ordinario dalla stessa proposto, chiedeva il risarcimento del danno alla professionalità subito per il periodo di inattività a decorrere dal febbraio 1999, danno da liquidarsi equitativamente.
Con riferimento ai ricorrenti S e O, va rilevato che è pacifico che gli stessi si siano presentati al giornale dopo la reintegra cautelare e sono stati cacciati via sul presupposto nella non costituzione del rapporto. In proposito, non ri ritiene che si tratti di recesso orale, come opinato dai ricorrenti, ma si tratta solo dell’attuazione del rifiuto datoriale di riconoscimento della prosecuzione del rapporto di lavoro e di esecuzione dell’ordine di riammissione in servizio giudizialmente (ancorché cautelarmente e dunque in via provvisoria) ottenuto dai ricorrenti.
Non vi è dubbio peraltro che da tale mancata riammissione al lavoro dei dipendenti sia derivato loro un danno.
Nell’ambito del rapporto di lavoro, occorre così considerare che, se rilevano le lesioni dei diritti soggettivi del lavoratore, non è invece in sé risarcibile qualunque difficoltà o qualunque disagio che attiene all’espletamento del rapporto di lavoro: non bisogna infatti dimenticare la natura del rapporto di lavoro subordinato, un rapporto nel quale, come è noto, vi è una parte che economicamente e giuridicamente in posizioni di debolezza e di inferiorità, e un’altra parte, più forte, alla quale l’ordinamento attribuisce una serie di poteri unilaterali di gestione del rapporto. I datori di lavoro hanno poteri unilaterali di organizzazione dell’azienda e poteri di organizzazione del lavoro: si tratta del potere, in generale, di conformare la prestazione lavorativa. Il lavoratore non ha un potere di determinazione né di incidenza sulle determinazioni dell’imprenditore: non può incidere sulle scelte organizzative aziendali, né sulle scelte del datore di lavoro di organizzazione del lavoro, ma subisce, passivamente, queste scelte: correlativamente, i danni che al lavoratore possono derivare dalla attuazione di determinate scelte aziendali sono danni che, nel nostro ordinamento, non sempre vengono configurati come danni ingiusti e quindi idonei a legittimare una azione risarcitoria.
Il lavoratore, però, ha una posizione soggettiva di fondamentale importanza che è l’interesse inquadrabile nella categoria degli interessi legittimi, ma di tipo privatistico- ad un corretto esercizio da parte del datore di lavoro dei poteri unilaterali di gestione; a questo interesse, che è alla base di una funzione di controllo che può espletare il lavoratore sulla posizione del datore di lavoro, corrisponde quello che è il generale obbligo di buona fede e di correttezza del datore di lavoro: questo è certo un ambito della responsabilità del datore di lavoro nella quale può trovare applicazione il danno esistenziale. Così, la violazione da parte del datore di lavoro di questi obblighi di correttezza e di buona fede si ha, innanzitutto, quando il datore di lavoro abusa dei propri poteri, cioè, giuridicamente, fa un uso dei propri poteri dirigendoli a fini diversi da quelli previsti dalla norma che assegna il potere unilaterale al datore di lavoro. Si pensi così al datore di lavoro che, abusando dei suoi poteri unilaterali di organizzazione del lavoro, mantenga il dipendente in uno stato di inattività forzata, preferendo magari pagargli la retribuzione e tenerlo a casa piuttosto che farlo lavorare.
Ora, l’assegnazione delle mansioni ai dipendenti è disciplinata in modo rigoroso dall’art. 2103 c.c. (come modificato dall’art. 13 stat.lav.), che nello stabilire che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, pone non solo il divieto di dequalificazione (ossia di assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di assunzione) ed il divieto di demansionamento (ossia di assegnazione di mansioni inferiorii a quelle ultime effettivamente svolte), ma impone al datore di lavoro l’adibizione effettiva del dipendente al lavoro, ed è è dunque espressione del diritto del lavoratore a lavorare concretamente.
In proposito, non bisogna dimenticare che l’art. 2103 nel testo attuale è stato introdotto dall’art. 13 stat.lav., e dunque si inserisce nella legge 20 maggio 1970, n. 300 diretta a garantire la libertà e dignità dei lavoratori, nei luoghi di lavoro: ciò impone una lettura della norma come volta ad apprestare una efficace e pregnante tutela del patrimonio professionale del lavoratore.
In altri termini, la norma è volta a tutelare il diritto del lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisita nella fase pregressa del rapporto, da un lato mantenendo il grado di autonomia e discrezionalità nell’esercizio delle mansioni e la posizione del dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro, dall’altro lato impedendo una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate sino a quel momento o anche solo una sottoutilizzazione qualitativa o anche solo quantitativa- del patrimonio professionale del lavoratore (Cass., 4 ottobre 1995, n. 10405, in Foro it. 1995, I, 3133; Cass.13 novembre 1991, n. 12088, in Not. giurisp. lav. 1991, 830; Cass., 10 febbraio 1988, n. 1437; Cass., 6 giugno 1985, n. 3372, in Not. giurisp. lav. 1985,648; Cass., 15 giugno 1983, n. 4106, ibidem 1983, 451), ed (cfr. Cass., 4 ottobre 1995, n. 10405, cit.; Cass., 14 luglio 1993, n. 7789, in Not. giurisp. lav. 1993, 808).
Come acutamente si è detto in dottrina, in contrasto con irridenti opinioni correnti a connotazione negativa fondate sull’esaltazione gratificante dell’ozio, la violazione dell’art. 2103 c.c. assume dimensioni intollerabili ove il dipendente, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione, sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti: infatti, il lavoro non è solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità dei soggetto, tutelato come tale dalla Costituzione (art. 1, 2 e 4 Cost., soprattutto).
La forma più grave di dequalificazione e demansionamento è senza dubbio l’inattività forzata del lavoratore, come avviene nell’ipotesi in cui lo stesso sia di fatto privato delle mansioni (c.d. svuotamento delle mansioni, che si verifica quando la mansione è privata dei suoi aspetti principali e più significativi, come nel caso della assegnazione del redattore a mera attività di cucina redazionale o come nel c.d. calo di firma), sia lasciato effettivamente senza alcun compito (inattività vera e propria: il lavoratore è privato di ogni mansione), non sia accolto affatto nei locali aziendali (ipotesi questa che trova espressione proprio nel caso di licenziamenti annullati giudizialmente intimati da datori di lavoro insensibili all’ordine giudiziale, nonostante le sanzioni penali, quantomeno ex art. 650 cod.pen.: sul tema, Cass. 18 agosto 1991, n. 8835, in Riv.it.dir.lav., 1992, II, 954).
Proprio con riferimento alla inattività forzosa del lavoratore, trib. Milano 26 aprile 2000, in Riv.critica dir.lav. 2000, 750, ha ritenuto che costituisce illegittima dequalificazione la sottrazione di tutte le mansioni attribuite al dipendente, tale da determinarne la totale inoperosità e che tale demansionamento lede la professionalità del lavoratore, intesa sia come insieme delle competenze professionali acquisite, sia come identità professionale del lavoratore percepita all’esterno nella società civile.
Secondo trib. Roma 11 gennaio 2001, in Lavoro giur. 2001, 773, è ammissibile la tutela d’urgenza della posizione del lavoratore costretto all’inattività, in quanto la prolungata inattività forzata, specie in presenza di una elevata professionalità, comporta il fondato rischio di pregiudicare irreparabilmente, durante il tempo occorrente per la conclusione del giudizio di merito, il diritto del lavoratore a realizzare la propria personalità attraverso il lavoro.
In materia altresì, sempre nell’ambito del rapporto di lavoro privato, pret. Milano 7 aprile 1998, ibidem, 1998, 702, nonché pret. Milano 11 marzo 1996, ibidem, 1996, 677, che condannano il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore lasciato totalmente inattivo, per scopo o effetto punitivo- nelle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita.
Particolarmente rilevante, in materia, la recente Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, attinente al caso di inattività forzosa pluriennale di un dipendente della RAI, che ha ritenuto che il comportamento del datore di lavoro, che demansiona o lascia in condizione di inattività per lunghissimo tempo un dipendente, non solo viola la norma di cui all’art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.
Del tutto diverso è il problema della individuazione della precisa natura del danno in discorso: infatti, dal demansionamento o dalla forzata inattività del lavoratore non deriva solo un danno inerente il patrimonio del soggetto, ma anche un danno relativo alla sua professionalità, intesa essa sia come lesione al patrimonio professionale del dipendente sia come lesione alla qualità della vita dello stesso, e quindi un danno propriamente esistenziale, che colpisce la persona in quanto tale (per ciò che è non per ciò che ha): si tratta di danni a beni immateriali, non suscettibile di valutazione medico-legale ma liquidabili solo in via equitativa.
Dopo la nota sentenza n. 500/99 della Corte di Cassazione in tema di risarcimento di interessi legittimi, è ormai acquisito che il termine danno nell’ambito della responsabilità rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile contrattuale o aquiliano- correlato alla lesione di un interesse giuridicamente tutelato, sicché dipende dalle scelte di valore operate dall’ordinamento giuridico nella selezione degli interessi protetti e delle conseguenze pregiudizievoli economicamente rilevanti.
In tale ambito, rilevano:
il classico danno patrimoniale, ossia le conseguenze che derivano dall’illecito al patrimonio di un soggetto in termini di danno emergente quantum abest- e lucro cessante quantum lucrari potuit-);
il danno morale, inteso quale complesso di sofferenze fisiche o morali derivanti al danneggiato dall’illecito ovvero il pretium doloris, disciplinato dall’art. 2059 cod civ. che ne limita la risarcibilità nei soli casi previsti dalla legge (allo stato, i casi di illecito cosituente reato: art. 185 cod.pen.; art. 2 della legge 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, della legge 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, del d.lgs. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 della legge 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo);
il danno biologico, riconosciuto dalla sentenza Corte Costituzionale 14 luglio1986, n. 184, come danno riguardante la salute in sé considerata, a prescindere dalle conseguenze che dalla menomazione derivano sul piano patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il demansionamento professionale dà luogo ad un pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, violando non solo lo specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c., ma costituendo anche offesa alla dignità professionale del prestatore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi di lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro.
Con particolare riferimento al danno alla professionalità, Cass. sez. lav. 1 giugno 2002, n. 7967, ha ritenuto così che il danno da dequalificazione professionale puó assumere aspetti diversi, in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione (Cass.14.11.2001, n. 14199; Cass.6.11.2000, n. 14443; Cass. 18.10.1999, n. 11727).
Da tale ambito di responsabilità restano fuori però tutta una serie di danni alla persona che sono danni di carattere non patrimoniale e che attingono a beni ed interessi costituzionalmente tutelati, inerenti l’esistenza dei singoli e la qualità della vita: la lesione di vari beni immateriali (professionalità, vita di relazione, riservatezza, identità personale, reputazione, immagine, autodeterminazione sessuale): infatti, mentre i riflessi patrimoniali delle lesioni arrecate a tali beni sono senza dubbio risarcibili secondo i tradizionali principi ex art. 2043 c.c., la lesione in sé considerata di tali beni configura un danno non patrimoniale, in sé non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2059 cod. civ., tradizionalmente inteso, se non nei casi di legge.
La domanda dei ricorrenti O, S e M di risarcimento del danno alla professionalità comprendono diversi aspetti (non esplicitati dai ricorrenti, ma certo ricompresi nella loro unica generale domanda risarcitoria del danno da inattività, che esclude solo danni morali e biologici espressamente): un aspetto strettamente patrimoniale, uno relativo alla diminuita professionalità derivante dall’inattività, uno relativo alla diversa qualità della vita connessa con l’inattività forzata.
I ricorrenti G, A e L, invece, hanno chiesto espressamente solo il risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità.
Il danno alla professionalità come danno patrimoniale può riguardare ogni caso di inattività forzata del lavoratore, ma deve essere provato dal lavoratore, in relazione ad esempio alla ridotta capacità professionale valutabili sul mercato del lavoro, tenuto conto della specifica professionalità conseguita presso l’azienda editoriale e delle altre attività eventualmente svolte ciò che nel caso nessun ricorrente ha specificamente fatto, neppure fornendo presunzioni.
Infatti, in tema di onere della prova del danno, va rilevato in linea generale che la prova del danno deve essere in genere data dal lavoratore (Cass. 11.8.1998, n. 7905; Cass.19.4.1996 n. 3696), e può essere articolata in relazione al tipo di danno preteso, e quindi data anche mediante la prova presuntiva (Cass. 2.11.2001 n. 13580), sufficiente di per sé sola a sorreggere la decisione (Cass. 18.1.2000 n. 491: Cass. 3.2.1999 n. 914). Così, se per il danno biologico è necessaria la prova della lesione dell’integrità psico-fisica, nella quale si sostanzia il danno (Corte cost. sent. 372/1994; Cass. 11.1.2001 n. 333), per la perdita della capacità concorrenziale sul mercato del lavoro può essere sufficiente la allegazione e la prova di circostanze di fatto gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) dalle quali il giudice del merito possa dedurre l’esistenza di tale danno patrimoniale.
Nel caso in questione, i ricorrenti suddetti hanno lamentato un danno alla professionalità considerata nei suoi aspetti patrimoniali ed hanno pure allegato una serie di elementi in grado -se provati- di confermare tale danno patrimoniale; nessuna prova specifica, tuttavia, neppure per presunzioni concrete, essi hanno poi fornito nel giudizio di merito in ordine a tali componenti patrimoniali della danno alla professionalità, sicché le domande risarcitorie del danno alla professionalità non possono trovare accoglimento alcuno in questo giudizio per tali aspetti patrimoniali, effetto di lesione del patrimonio professionale dei lavoratori.
Diverso discorso invece va fatto in ordine agli aspetti esistenziali del danno alla professionalità (il cui risarcimento può ritenersi richiesto solo dai ricorrenti O, S e M, che, nella domanda risarcitoria del danno da inattività professionale, non hanno limitato la pretesa al danno patrimoniale): qui infatti va rilevato che il regime probatorio è più agevole, essendo configurabili come si sirà meglio di seguito- automatismi (il danno è in re ipsa) in relazione alla lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Sotto il profilo dogmatico, si è contestata a lungo la risarcibilità del danno esistenziale, accedendo da taluni ad una concezione di danno non patrimoniale, quale enunciata dall’art. 2059 c.c., in cui vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi, quei danni arrecanti un dolore morale alla vittima ed in nessun modo riguardanti il patrimonio, escludendosi così a priori la distinzione fra danno morale e danno non patrimoniale.
Oggi, peraltro, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità che costituzionale, si è orientata verso una nozione ampia, costituzionalmente orientata, del danno non patrimoniale, esorbitante non solo da una visione penalistica (i casi di legge ormai riguardano in via maggioritaria fattispecie extrapenali), ma anche da una impostazione limitativa del risarcimento ai casi previsti dalla legge: nel perdurante vigore dell’art. 2059 c.c., si è ritenuto che, allorquando vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge (tanto più se correlata all’art. 185 c.p.), e si è affermato che ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, in quanto una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
Se, così, si supera l’equazione danno non patrimoniale-danno morale, sottolineandosi la maggiore latitudine da attribuire al primo, si può propendere per una configurazione di danno che sia comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, bensì di riparazione.
Come rilevato dalla miglior dottrina, il danno esistenziale non ha nulla a che vedere con le lacrime, le sofferenze, i dolori, i patemi d’animo: il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, cioè un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente.
Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato ma che costituisce pur sempre un interesse direttamente protetto dall’ordinamento ed in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati. Le conseguenze sono da considerarsi nella loro valenza economica anche se l’interesse leso, costituente il danno-evento, è di natura immateriale e non patrimoniale, spostandosi il baricentro della tutela risarcitoria dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione.
Il danno esistenziale risarcibile consiste, in altri termini, nella perdita o nella compromissione di una o più attività realizzatrici della persona salvaguardate sempre dall’art. 2 Cost., nella rinuncia del lavoratore alla quotidianità e nella compromissione della propria sfera di esplicazione personale, secondo le espressioni giurisprudenziali.
Anche nella giurisprudenza, del resto, può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’articolo 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo, essendo stata prospettata, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In proposito va ricordato che nel caso sopra richiamato dell’inattività totale pluriennale del dipendente RAI, Cass. 10 gennaio 202, n. 10, ha ritenuto che il giudice di appello aveva enunciato un concetto di lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, ed aveva ritenuto che tale lesione avesse prodotto automaticamente un danno (non economico ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), anche se determinabile necessariamente solo in via equitativa. La Cassazione nel caso ha confermato la pronuncia impugnata, sottolineando come il demansionamento non solo viola lo specifico divieto di cui all’articolo 2103 cod.civ, ma ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 11727/99, 14443/00). L’affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera e integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 7905/98, 1026/97, 3686/96 e 8835/91). Prova, viceversa, che, secondo le ricordate pronunce, rimane necessaria per quanto riguarda l’eventuale danno materiale, il pregiudizio economico cioè subito dal lavoratore anche in termini di guadagno non conseguito per effetto della perdita di concreti vantaggi necessariamente legati allo svolgimento delle mansioni negate.
Non qualsiasi perdita esistenziale potrà costituire un danno risarcibile: ed in questo caso l’interprete avrà il compito certo, non sempre agevole – di individuare il selettore, cioè il criterio in base al quale discernere le perdite esistenziali meritevoli di tutela risarcitoria da quelle non risarcibili. Nella difficile opera di selezione degli interessi, si è detto in dottrina che un punto di riferimento potrà essere dato dal quadro dei valori costituzionali, più precisamente il progetto di vita che ogni individuo insegue dovrà essere filtrato attraverso quei valori su cui si fonda la Costituzione: solo attraverso questa strada si possono selezionare le attività realizzatrici della persona che reclamano tutela, la natura del bene che la condotta del convenuto ha violato, le ripercussioni sofferte dalla vittima.
Una responsabilità risarcitoria incentrata sull’alterazione della quotidianità del danneggiato richiede, a ragione, una prova rigorosa a seconda della normalità o meno delle conseguenze prospettate. Ove siano lesi diritti costituzionalmente tutelati, il regime probatorio sarà più agevole, risultando in re ipsa il danno esistenziale. Quanto più invece si apre la responsabilità risarcitoria del danno esistenziale ad altre attività realizzatrici dell’uomo ritenute meritevoli d’interesse, tanto più difficile sarà la prova richiesta al danneggiato, dovendosi dimostrare la meritevolezza delle attività svolte ed loro regolare svolgimento.
In ordine all’onere della prova, in dottrina si è così rilevato che particolari interessi meritevoli di tutela, oggetto di diritti costituzionalmente tutelati perché trovano un riconoscimento espresso nella Carta Costituzionale (il diritto alla salute o il diritto alla dignità della persona) oppure perché connessi a posizioni di libertà (il diritto di manifestare il proprio pensiero) e così via, se violati, indefettibilmente, comporteranno un danno esistenziale in capo alla vittima, sicché la prova che deve offrire il danneggiante può anche ridursi alla prova della sola lesione; diversamente, se più che la lesione in quanto tale rilevano le conseguenti alterazioni della quotidianità, sarà opportuno distinguere, fra le alterazioni normali ossia quelle ipotesi in cui il torto subito impedisce al danneggiato di esplicare tutte quelle attività attraverso le quali, prima dell’evento lesivo, svolgeva la proprio personalità e che realizzavano il suo benessere complessivo- le alterazioni specifiche legate ad una lesione strettamente connessa alla particolare condizione di vita della vittima (essendo già accertata in astratto la meritevolezza della attività limitata); in questo caso quindi sarà il soggetto danneggiato a dover dare una prova molto puntuale del danno subito, proprio perché quelle conseguenze non si ricollegano da un punto di vista della valutazione sociale normalmente a quel fatto lesivo.
Così, la mera illegittimità di un licenziamento è prevista già dalla legge (che vi appronta una tutela risarcitoria dei danni derivanti al lavoratore dal recesso datoriale illegittimo) e può ritenersi situazione in sé insufficiente per richiedere un intervento risarcitorio del danno esistenziale insito nell’inattività, in quanto conseguenza in sé normale del recesso illegittimo. Ben diversa è invece la situazione in cui al licenziamento si contrappone un ordine giudiziale di reintegra o di riammissione al lavoro, sicché l’inattività forzata da un lato assume caratteri di illiceità particolarmente pregnanti e, dall’altro lato, riguarda un rapporto di lavoro del tutto in essere, sicché il lavoratore non è in condizioni di trovare un altro impiego, facendo affidamento proprio sull’esecuzione della decisione giudiziale. In tali casi, del resto, si ha non solo la lesione dell’interesse già giudizialmente riconosciuto (ancorché in via cautelare)- del lavoratore a lavorare effettivamente, ma anche della lesione della dignità del lavoratore (art. 2 Cost.) e dell’interesse del pari costituzionalmente protetto- alla effettività della tutela giurisdizionale dei propri interessi riconosciuti dall’ordinamento (art. 24 Cost.): in tali casi, infatti, il comportamento del datore che non esegue effettivamente l’ordine giudiziale si rivela, a cagione dell’incoercibilità dell’ordine di reintegra in relazione alle obbligazioni infungibili di facere del datore, particolarmente lesivo degli interessi del lavoratore ed offensivo della sua dignità, e la posizione di quest’ultimo risulta del tutto mortificante.
Ciò è particolarmente vero non già nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi in genere (ove si potrebbe dire che il lavoratore che impugna il recesso datoriale mette in conto l’inattività fino alla decisione giudiziale e questa, d’altra parte, risarcisce i danni connessi in applicazione della tutela ordinaria legislativamente prevista avverso i recessi datoriali illegittimi) ma in quello in cui al licenziamento si contrappone un ordine giudiziale di reintegra o di riammissione al lavoro, sicché l’inattività forzata da un lato assume caratteri di illiceità particolarmente pregnanti e, dall’altro lato, riguarda un rapporto di lavoro del tutto in essere, sicché il lavoratore non è in condizioni di trovare un altro impiego, facendo affidamento proprio sull’esecuzione della decisione giudiziale.
In tale contesto, l’ordine di reintegrazione o equivalenti può costituire il presupposto di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dall’inosservanza dell’ordine contenuto nella sentenza, eventualmente anche di rilievo penale (Cass. 17 luglio 1992, n. 8721; Trib. Roma 3 gennaio 1996, in Riv. Critica dir.lav., 1997, 117; Trib. Roma 6 febbraio 2001, inedita; afferma la pronunciabilità di un ordine di reintegrazione nelle mansioni di provenienza, trib. Milano 25 ottobre 1995, in Riv.critica dir.lav. 1996, 152; pret. Genova 15 maggio 1998, ibidem, 1998, 987): in particolare, l’inosservanza dell’ordine di reintegrazione espone il datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni subiti dal lavoratore connessi all’inattività forzata., incluso il danno esistenzaziale.
La mancata ottemperanza all’ordine di reintegrazione o analoghi importa un danno esistenziale al lavoratore: in tal caso, infatti, il diritto all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa ha tutela specifica in quanto avallata dall’intervento del giudice (sicché l’ordine giudiziale consente certamente di superare le resistenze della dottrina e giurisprudenza tanto prevalenti quanto non condivisibili- nel ravvisare nella carta costituzionale un diritto all’effettività del lavoro in sé considerato) e va incluso nell’ambito dei diritti inviolabili; correlativamente, la mancata adibizione del lavoratore al lavoro nonostante ordine giudiziale risulta offensiva della dignità del lavoratore che ha scelto di tutelare i propri interessi attraverso le vie giurisdizionali.
In giurisprudenza, si è così ritenuto che la mancata ottemperanza da parte datoriale alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all’ulteriore risarcimento del danno alla professionalità subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattività (pret. Milano 20.7.99, in Riv.critica dir.lav., 1999, 885). L’abuso dell’iniziativa privata, esplicitata attraverso l’inattuazione dell’obbligo di reintegra disposto con sentenza, è idoneo ad offendere la dignità del lavoratore e la sua professionalità in senso soggettivo, ed assumono anche valore patrimoniale (trib. Firenze 15.4.98, in Lav. giur. 1998, 7, 580). In senso contrario, invece, la più risalente Cass. 24.3.98, n. 3131, che prima del riconoscimento del giudice di legittimità della categoria del danno esistenziale- ha affermato che nell’ipotesi in cui il lavoratore illegittimamente licenziato chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione dell’ordine di reintegrazione e poi dalla riammissione in servizio con mansioni inferiori a quelle spettanti, la responsabilità risarcitoria -collegata ad una lesione della personalità morale del lavoratore e della sua immagine- non può estendersi, in assenza del presupposto di cui all’art. 2059 c.c., al danno non patrimoniale).
In altri termini, l’esigenza di limitare il risarcimento del danno esistenziale alle situazioni di antigiuridicità più evidenti importa il riconoscimento della tutela non a tutti i casi di inattività conseguenti al licenziamento del lavoratore (essendo peraltro tipizzate le conseguenze dell’annullamento del recesso e del risarcimento dei danni) o addirittura in costanza di rapporto di lavoro (come nel caso di sottrazione di tutte le mansioni o della parte principale di essa), ma solo ai casi in cui l’inattività riguarda licenziamenti già dichiarati illegittimi ed ai quali si è accompagnato un ordine giudiziale di reintegrazione o di riammissione al lavoro: in tali casi, infatti, normalmente il lavoratore fa affidamento sulla esecuzione dell’ordine giudiziale e non ricerca altro lavoro, sicché l’inattività eventuale cui il lavoratore sia costretto dal lavoratore risulta essere particolarmente frustrante e lesiva per il lavoratore, configurando un vero e proprio comportamento ingiurioso del datore di lavoro ed all’evidenza ritorsivo per la perdita del giudizio reintegratorio (nel caso cautelare), e correlandosi ad un rapporto di lavoro giuridicamente in essere.
Nel caso di specie, tale situazione ha riguardato i lavoratori S e O (già beneficiari di un ordine cautelare di reintegra nel lavoro) e non invece M, che si è trovata solo nella mera situazione di una lavoratrice dipendente di un datore di lavoro inadempiente alle proprie obbligazioni.
In entrambi i casi di inattività è ravvisabile un danno alla professionalità del lavoratore, ma solo nel caso di S ed O il pregiudizio in discorso, inquadrabile nella categoria del danno esistenziale, è automaticamente risarcibile.
Infatti, con riferimento al danno esistenziale, ove siano lesi diritti costituzionalmente tutelati, il regime probatorio è più agevole, risultando in re ipsa il danno esistenziale. Ciò è particolarmente evidente nel caso della mancata attuazione della reintegra disposta, per la lesione dell’interesse del lavoratore giudizialemente riconosciuto- all’effettività del proprio lavoro (il lavoratore non lavora e non può ricercare altro lavoro avendone uno già formalmente pendente e soprattutto ha il diritto giudizialmente riconosciuto all’esecuzione della prestazione lavorativa negata) sia per la lesione della sua dignità (il quale avendo subito un torto, civilmente non si è fatto giustizia da sé, si è rivolto al giudice che gli ha dato ragione, ma ha visto il datore di lavoro rimanere con protervia e noncuranza- insensibile all’ordine giudiziale).
Nel caso invece della mera inattività forzata del dipendente, come pure nel caso del mero licenziamento illegittimo, non si ha una immediata lesione di un interesse non patrimoniale costituzionalmente protetto, sicché il lavoratore deve dimostrare che dall’inadempimento datoriale sia derivata l’impossibilità di svolgimento di attività realizzatrici della persona o che comunque sia derivata, per le modalità concrete del fatto o per la durata dell’inattività, una lesione della sua dignità e personalità; in difetto di ciò infatti, le conseguenze dell’illecito datoriale per così dire ordinario sono tipizzate dal legislatore con il conferimento di tutele diverse, che non prevedono il risarcimento del danno esistenziale, ma solo altre misure risarcitorie o indennitarie.
Ciò non importa che ijn tali casi non possa ravvisarsi un danno esistenziale, ma richiede come si è detto una prova specifica del lavoratore in ordine alla lesione della dignità della persona o di altri suoi diritti della prersonalità costituzionalmente tutelati e dunque alla particolare forza lesiva dell’illegittimo comportamento datoriale che dia ragione del risarcimento anche del danno non patrimoniale (contra, App. Roma 16.02, in MGL, 2003, 1,72, secondo la quale invece il bene della professionalità costituisce una componente dell’identità personale ed è tutelato dall’art. 2103 c.c. e 2 Cost., sicché la sua lesione è risarcibile di per sé, indipendentemente dagli ulteriori effetti lesivi eventualmente prodotti dall’iandempimento datoriale sul piano patrimoniale o dell’integrità psicofisica). Nel caso della ricorrente M, tale prova non risulta essere stata fornita, neppure per presunzioni, non risultando oltre la mero inadempimento datoriale- alcun elemento che possa dar conto di quel quid pluris in grado di recare il danno esistenziale tutelabile.
I criteri di liquidazione del danno esistenziale saranno diversi da quelli ordinariamente utilizzati per la liquidazione del danno biologico, anche se sempre affidati alla ricostruzione equitativa del giudice (art. 1226 c.c.).
Questo giudice è consapevole del fatto che nel caso l’evento dannoso si produce su beni immateriali (la professionalità, la dignità del lavoratore) e prescinde da riferimenti economico patrimoniali, sicché la liquidazione del danno non deve necessariamente limitarsi ad una quota della retribuzione destinata a compensare la professionalità in senso stretto, ma può pervenire nella liquidazione del danno cagionato a beni costituzionalmente protetti ad una determinazione che si basi, come per il danno biologico, su parametri egualitari diversi dalla retribuzione.
Nel caso, tuttavia, in difetto di qualsivoglia allegazione della parte in ordine a tali diversi criteri non può che farsi riferimento al solo dato retributivo, conformemente alle pronunce giuriosprudenzaiali in tema più diffuse.
Nella giurisprudenza di merito, il danno alla professionalità viene solitamente individuato in una percentuale variabile della retribuzione mensile (Cass. 10/4/96 n. 3341 la quale ha ritenuto la congruità di tale criterio di liquidazione del danno) anche se vi è grande diversità di opinioni in ordine alla misura di quella percentuale: e così v’è chi lo individua nel circa 100% della retribuzione percepita (Pret. Milano 26 gennaio 1999, in Orient.giur.lav., 2000, 77, che ha quantificato il risarcimento del danno equitativamente nella misura del 100% della retribuzione percepita nel periodo di dequalificazione; così pure pret. Milano 7 gennaio 1997), nel 50% (Pret. Milano 31/7/97 e 14/2/96), nel 40% (Pret. Milano 26 agosto 1996; pret. Milano 1 marzo 1999, ibidem, 88), nel 30% (cfr. Trib. Roma 12/10/98), nel 25% (pret. Milano 26 giungo 1999, ibidem 352), nel 15% (Trib. Milano 9/11/96), in un terzo della retribuzione (Trib. Milano 30/11/96).
In particolare, pret. Milano 26 agosto 1996, in Orientam. Giur.lav., 1996, 825, ha ritenuto che la determinazione del danno, in mancanza di specifiche allegazioni da parte del lavoratore, deve essere effettuata in via equitativa con riferimento alla retribuzione globale netta, dalla quale va sottratta la quota destinata compensare gli altri elementi della prestazione lavorativa, quali il tempo di lavoro, la penosità fisica di esso, lo sforzo intellettuale, potendosi in tal modo terminare lo specifico danno alla professionalità nella misura del 40% della retribuzione globale netta, moltiplicata per il tempo per il quale è perdurata la dequalificazione.
Altro orientamento ancora applica una percentuale non fissa ma variabile delle retribuzione per liquidare il danno alla professionalità, in relazione alle circostanze concrete che possono mutare nel corso del tempo: così, in un caso in cui al demansionamento era seguito un vero e proprio trasferimento, con correlativa mobbizzazione del lavoratore, trib. Forlì 15 marzo 2001, in Orient.giur.lav. , 2001, 411. In proposito, Cass. 835/01 ha ritenuto non automatico il parametro della retribuzione mensile, potendo tener conto di diversi livelli di qualificazione; ha pure ritenuto che la perdita del valore della professionalità aumenti col passare del tempo di esposizione al demansionamento pret. Milano 9 dicembre 1997, in Riv.critica dir.lav., 1998, 421 che ha fissato in 1/4 della retribuzione per i primi 4 mesi, in 1/3 per i successivi 5 mesi, nel 50% per i successivi 6, in 2/3 nei successivi 3 e infine nel 100% da quella data in poi). Cassazione 5 marzo 2002 n. 3 ha poi ritenuto che l’entità del danno alla professionalità sia quantificabile in misura percentuale della retribuzione mensile (40% e poi 70%), variabile nel corso del tempo in relazione all’aggravarsi della lesione.
In applicazione di questi criteri, nel caso, in difetto di allegazione e prova di specifici concreti elementi che consentano di ravvisare un danno crescente nel tempo ovvero di ancorare il danno a parametri di riferimento non patrimoniali, si ritiene congrua la liquidazione del danno esistenziale subiti dai ricorrenti S ed O nella misura di ¼ della retribuzione globale di fatto per ciascun mese di inattività, a decorrere dalla data di comunicazione o notifica dell’ordinanza cautelare collegiale fino alla data della riammissione in servizio.
p.q.m.
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro
definitivamente pronunciando nella causa r.g. 326/99 ed altre riunite, promosse da M ed altri contro A s.r.l., così provvede:
respinta ogni altra richiesta, accoglie le domande dei ricorrenti come limitate negli atti di riassunzione e, per l’effetto, accerta che i rapporti di lavoro dei ricorrenti con la E sono proseguiti con A dal giorno della cessione della testata Q e, per l’effetto, ordina l’immediata riammissione dei ricorrenti nel posto di lavoro (con la retribuzione già in godimento, e diritto ai successivi scatti di anzianità, con la qualifica, le mansioni e la sede di lavoro già assegnate) e condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione globale di fatto in godimento prima della sospensione del rapporto di lavoro in essere con E -oltre scatti di anzianità maturati dopo tale momento- con decorrenza dalla data di tale sospensione fino al soddisfo (detratto quanto già corrisposto allo stesso titolo), oltre rivalutazione ed interessi sulle somme v4ia via rivalutate con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti S ed O di ¼ della suddetta retribuzione per ciascun mese di inattività a decorrere dalla data di comunicazione o notifica dell’ordinanza cautelare collegiale fino alla data della riammissione in servizio;
(&)