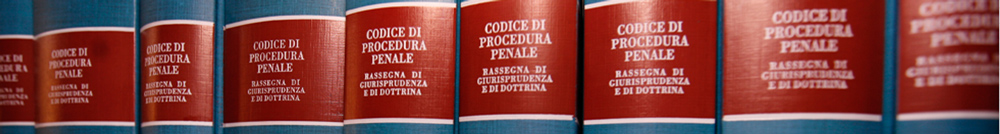Banca Dati
Colpevolezza e responsabilità oggettiva
La responsabilità penale è di carattere “personale“, secondo la – quasi ermetica – dizione della Carta Costituzionale (art. 27 comma primo Cost.).
Se infatti la pena è innanzitutto stigma individuale, deve fondarsi, coerentemente, sulla rimproverabilità soggettiva del fatto tipico all’autore dell’illecito, individuato prima facie in base al criterio oggettivo-causale.
Per colpevolezza si intende, dunque, secondo le più recenti impostazioni dottrinali, il complesso di requisiti da cui dipende la possibilità di muovere un rimprovero all’agente per il compimento di un fatto tipico, antigiuridico.
Costituisce il terzo elemento della dogmatica del reato: l’antidoverosità della volontà dell’agente (la colpevolezza, appunto) rileva solo in quanto esteriorizzata tramite comportamenti socialmente offensivi e contra ius.
La valutazione di colpevolezza riguarda quindi il fatto in correlazione con il suo autore materiale. Si è tuttavia emancipata da un inquadramento psicologico, secondo il quale essa denotava la relazione psichica tra l’agente ed il fatto (esaurendola impropriamente nel dolo e nella colpa cosciente). Concezione questa incapace, ad esempio, di spiegare la colpa incosciente, cui sono estranee interazioni tra la sfera mentale dell’autore ed il fatto rimproveratogli.
Al contrario, l’impostazione normativa – cui si riferisce la definizione poco sopra riportata – inquadra l’istituto entro un orizzonte assiologico. In tale prospettiva la colpevolezza rappresenta, infatti, una qualificazione di rimproverabilità derivante un giudizio complesso, sviluppato dall’ordinamento secondo diversi criteri: il dolo, la colpa, o il dolo misto a colpa (art. 42 ss. c.p.); la conoscenza o conoscibilità della norma penale violata (art. 5 c.p., secondo l’interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988); la capacità di intendere o volere (artt. 85 ss. c.p.); la normalità delle circostanze concomitanti al fatto di reato (assenza di scusanti).
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente, pena l’impossibilità di formulare quel giudizio di rimprovero soggettivo sotteso alla categoria in esame.
Il principio di colpevolezza è vero e proprio caposaldo del diritto penale moderno, sviluppatosi in seno al pensiero illuminista-liberale, tra la fine del Settecento e i primi del Novecento.
Da un lato esso presuppone (ed esprime a livello giuridico) l’esperienza della (condizionata) libertà umana: il comportamento di un uomo-automa, deterministicamente programmato, non gli sarebbe riproverabile soggettivamente. Non sarebbe infatti anche solo concepibile una condotta alternativa a quella meccanicamente ‘causata’.
D’altra parte – nell’ottica più positiva – il principio di colpevolezza rappresenta una fondamentale garanzia costituzionale, vincolo in primis per la discrezionalità legislativa nelle scelte di criminalizzazione.
Il principio esclude innanzitutto l’ipotetica previsione di forme di responsabilità penale per fatti di terzi. In secondo luogo, impone che il fatto concreto, corrispondente al modello di tipicità, sia imputabile all’autore, come mimimo, a titolo di colpa (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 364/1988, ma per una formulazione più rigorosa Corte Costituzionale, sentenza 1085/1988).
La ratio dell’art. 27, comma primo, Cost. è pienamente compresa alla luce di una lettura sistematica con altre due disposizioni costituzionali: l’art. 27, comma terzo, Cost. e l’art. 25, comma secondo, Cost.
Ai sensi dell’art. 27, comma terzo, della Costituzione “le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato“. Come pretendere dunque la rieducazione di un soggetto che, per l’ordinamento, non è soggettivamente rimproverabile? Si tratterebbe di una contraddizione intollerabile, ancor più considerato il contenuto inevitabilmente afflittivo della pena. Quest’ultima piomberebbe sulla vita dell’individuo, quale accadimento soggettivamente imponderabile e quindi incomprensibile.
In senso convergente vale la considerazione dell’art. 25, comma secondo, Cost., cui è ricondotto il principio di legalità (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso“). Com’è noto, la norma esprime l’esigenza di una predeterminazione astratta degli illeciti penali, tale da garantire al singolo la conoscibilità delle conseguenze penali delle proprie azioni. Ciò per preservare uno spazio di autodeterminazione soggettiva rispetto al fatto di reato.
Suddetto schema verrebbe inevitabilmente inficiato ammettendo una responsabilità svincolata dalla colpevolezza. Il fatto sarebbe imputato oggettivamente al singolo, per la mera causazione dello stesso, senza che alla persona potesse essere rimproverata quella ‘autodeterminazione criminale‘, paradossalmente garantita dallo stesso principio di legalità.
Le considerazioni appena svolte rendono evidentemente incompatibili forme di responsabilità oggettiva con il portato dell’art. 27, comma 1, Cost. che esige una responsabilità per fatto proprio colpevole.
Il codice penale del 1930 ammette tuttavia diversi casi di responsabilità oggettiva, ovvero di ipotesi in cui l’intero fatto di reato o un elemento dello stesso viene addebitato all’agente senza l’accertamento del dolo, della colpa o in assenza della capacità di intendere o volere.
Tra le più significative si ricordino: l’omicidio preterintenzionale (584 c.p.) e l’aborto preterintenzionale (art. 18 comma secondo L. 194/1978); il mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti (art. 117 c.p.); le finzioni legali di imputabilità (art. 92 c.p.)
Esse trovano alveo positivo nell’art. 42, comma terzo, c.p.: nei casi tassativamente indicati dal Legislatore l’agente risponde del fatto per criteri di imputazione diversi dal dolo, dalla colpa.
Gli interventi della Corte Costituzionale in materia sono stati inizialmente piuttosto timidi. Si pensi alla sentenza n. 364 del 1988: essa esclude – incidenter tantum – un tassativo divieto costituzionale di responsabilità oggettiva, distinguendo in maniera opinabile tra “elementi più significativi della fattispecie” (necessariamente coperti almeno da colpa), ed altri elementi, non meglio identificati, che sarebbero svincolati dall’elemento soggettivo.
Più rigorosa e significativa per il tema esaminato è la sentenza della Corte Costituzionale n. 1085 del 1988, relativa all’attenuante del c.d. ‘furto d’uso’ ex art. 626, comma primo, n. 1, c.p. La pronuncia supera le ultime incertezze sulla configurazione costituzionale del principio di colpevolezza; esige infatti che “tutti e ciascuno” degli elementi che contrassegnano il disvalore del fatto addebitato all’agente (in altri termini, tutti gli elementi costitutivi come declinati nel caso concreto) siano coperti almeno da colpa.
Da segnalare infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2007. Essa sviluppa ulteriormente la portata precettiva del principio, declinandolo sul piano ermeneutico. La rimproverabilità soggettiva degli elementi costitutivi del fatto-reato, oltre a configurare un limite invalicabile per la politica criminale del Legislatore, deve rappresentare un criterio interpretativo guida per il giudice nell’applicazione delle fattispecie positive.
Nonostante gli interventi della Corte e qualche riforma legislativa (in primis la Legge del 1990 che ha introdotto il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti), la disciplina codicistica è ancora lontana da un pieno allineamento con il principio di colpevolezza.
Spetta dunque innanzitutto all’interprete – in particolare giurisdizionale – muoversi secondo le coordinate tracciate dalla pronuncia n. 322/2007 del Giudice Costituzionale, al fine di attuare l’ordinamento penale entro la logica costituzionale.
In tal senso, si sono mosse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento all’art. 586 c.p. (“morte o lesioni quali conseguenze di altro delitto“). Forse proprio nell’ipotesi più dubbia di responsabilità oggettiva (stante i rinvii della disposizione alle ipotesi colpose di cui agli artt. 83, 589, 590 c.p.), la Suprema Corte ha compiutamente attuato le indicazioni del Giudice delle Leggi attraverso un’interpretazione adeguatrice della succitata fattispecie. Ciò esigendo che la morte o la lesione causata dal delitto doloso fosse addebitabile all’agente per colpa in concreto: quando cioè un uomo medio e razionale, posto nella medesima situazione dell’agente, avrebbe previsto l’evento dannoso ulteriore rispetto al delitto originario.
Ammette dunque la discussa configurabilità della colpa nell’ambito di attività illecite: una soluzione diversa, infatti, urterebbe col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), imponendo l’irragionevole parità di trattamento tra situazioni il cui l’evento ulteriore era concretamente prevedibile e casi in cui, al contrario, era imponderabile per l’agente.
La rilevanza della pronuncia travalica dunque il reato specifico, poiché offre spunti interpretativi applicabili in altre ipotesi di responsabilità oggettiva, come l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e l’addebito di reato diverso da quello voluto da uno dei concorrenti (art. 116 c.p.).
Ai sensi dell’art. 584 c.p. “chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni“.
La fattispecie d’evento contempla la volizione di un fatto di reato (percosse o lesioni) e la realizzazione di un fatto più grave (l’omicidio). Essa esige il dolo rispetto al reato ‘minore’; lo esclude invece con riferimento all’evento più grave (la morte del soggetto passivo). Quest’ultimo viene infatti addebitato in ragione della mera rappresentazione-volizione del fatto meno grave.
Lo schema esposto riguarda, più in generale, i delitti preterintenzionali, categoria disciplinata dall’art. 43, comma primo, c.p., cui è riconducibile – oltre alla fattispecie in esame – quella di aborto preterintezionale (art. 18, comma secondo, L. 194/1978).
La preterintezione codicistica – stando alla collocazione sistematica nell’art. 43 c.p. – contempla un criterio di imputazione intermedio tra dolo e colpa, che apparirebbe distinto anche da quello meramente oggettivo, ricondotto all’art. 43, comma terzo, c.p.
Si tratta invero di un inquadramento poco convincente, tant’è che la dottrina ha cercato di approfondire la struttura dei delitti preterintenzionali, giungendo essenzialmente a due esiti, diversamente conciliabili con il principio di colpevolezza descritto in premessa.
Secondo un primo orientamento la preterintenzione è riconducibile ad una combinazione di dolo e responsabilità oggettiva. Nel caso specifico dell’omicidio, dunque, è possibile distinguere due segmenti nell’ambito della condotta causalmente tipica. Il primo, consistente nella realizzazione della condotta di lesioni o percosse, è imputato all’agente sulla base del criterio della rappresentazione-volizione (il dolo di lesioni o percosse).
Il secondo viene invece imputato per il mero legame eziologico con l’evento; anche qualora la morte fosse concretamente imprevedibile al momento della condotta di lesioni o percosse.
L’autorevole orientamento urta però frontalmente con le indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2007: prescinde dal vincolo di colpevolezza nell’interpretazione del secondo segmento della condotta tipica.
Secondo una diversa impostazione dottrinale, la preterintenzione implicherebbe una combinazione di dolo e colpa (c.d. ‘dolo misto a colpa’). Tale lettura risulta congruente con il primo orientamento se ci si riferisce al segmento iniziale della condotta; diverge invece nell’identificazione del criterio di addebito – non meramente oggettivo – dell’evento-morte. Quest’ultimo sarebbe infatti imputabile all’agente solo se causato per colpa, ovvero se prevedibile ed evitabile in concreto da un uomo medio, ragionevole, posto nelle medesime condizioni dell’agente.
Evidentemente, tale approccio appare il più coerente con l’impianto costituzionale ed, in particolare con l’art. 27, comma primo, Cost., così come precisato dalle pronunce costituzionali sopra analizzate. Si inserisce inoltre nel solco argomentativo della sentenza a Sezioni Unite del 2009, già citata.
Nonostante le considerazioni appena svolte, le interpretazioni giurisprudenziali dell’art. 584 c.p. appaiono – più o meno direttamente – riconducibili al primo degli orientamenti dottrinali descritti. L’accertamento viene infatti limitato alla sussistenza del dolo con riferimento alle lesioni o percosse ed al nesso eziologico tra queste ultime e la morte; senza indagini circa l’effettiva prevedibilità ed evitabilità concreta dell’evento non voluto.
Una parte della giurisprudenza di legittimità, dunque, aderisce in maniera franca all’orientamento della combinazione dolo-responsabilità oggettiva, facendo leva su assunti, variamente valorizzati nelle pronunce: il dato letterale dell’art. 584 c.p.(in cui è assente ogni riferimento alla colpa); la ritenuta inconfigurabilità della colpa nell’ambito di attività illecite; la tutela rafforzata dell’integrità fisica rispetto a dinamiche di c.d. ‘progressione criminosa’.
Con riferimento critico ai primi due profili, possono agevolmente richiamarsi gli approdi cui è giunta l’autorevole pronuncia di legittimità del 2009, sopra richiamata, legittimata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2007 che non solo ammette, ma – anzi – esige interpretazioni integratrici, in senso garantistico, della lettera codicistica.
Con riferimento alla progressione criminosa, la giurisprudenza ritiene che l’omicidio preterintenzionale rilevi autonomamente per tutelare in maniera rafforzata le ipotesi in cui la morte rilevi quale degenerazione di condotte ab origine finalizzate a ledere l’integrità fisica della vittima. In sintesi, l’omogeneità dei beni giuridici in gioco (integrità fisica e vita) e – in un certo senso – la prevedibilità astratta dell’evento letale, giustificherebbero l’addebito oggettivo.
Sul punto occorre però rilevare come l’ipotesi di una progressione criminosa sia tanto più convincente, quanto più appaia prevedibile in concreto l’esito letale dell’azione originaria e, dunque, quanto più sia colposa la condotta illecita dell’agente.
In secondo luogo appare a dir poco dubbio che esigenze di tutela possano essere raggiunte obliterando un principio cardine del diritto penale, che presuppone l’evitabilità concreta degli eventi addebitati (sul punto anche Corte Costituzionale, sentenza n. 322/2007).
Altre pronunce di legittimità, pur riconoscendo formalmente il principio di colpevolezza, giungono a svuotarlo del suo significato precettivo. Ciò in quanto la colpa per l’evento-morte, viene identificata nella violazione dei precetti ex artt. 581 o 582 c.p., esaurendosi in re ipsa (tesi della preterintezione come ‘dolo misto a colpa per inosservanza di leggi’). Viene così estromessa qualsiasi valutazione circa la prevedibilità dell’evento, addebitato – in ultima analisi – oggettivamente.
L’orientamento dottrinale del dolo misto a colpa emerge quindi, solo timidamente, in qualche pronuncia di legittimità e non sempre è declinato con dovuto rigore.
Problemi analoghi riguardano l’ipotesi di cui all’art. 116 c.p. (“qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se questo è conseguenza della sua azione od omissione“).
La disposizione, in ossequio al principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, addebita al concorrente tutte le conseguenze eziologicamente riconducibili alla condotta partecipativa, prescindendo dalla prevedibilità delle stesse.
Secondo l’interpretazione più rigidamente ancorata al dato codicistico, quindi, risponde a titolo di concorso doloso chi, volendo contribuire alla realizzazione di un determinato reato, fornisca invece il proprio contributo ad un reato che, per decisione di un altro compartecipe, è diverso da quello da lui voluto. Si tratta di un caso in cui – addirittura – è l’intero reato (e non un solo elemento della fattispecie) ad essere svincolato dal dolo o dalla colpa.
Ad oggi, tuttavia, la dottrina prevalente propone un’interpretazione adeguatrice della disposizione. In quest’ottica, il reato diverso da quello voluto sarebbe imputabile soggettivamente solo se colposamente cagionato. Ciò impone – a rigore – una verifica circa la concreta prevedibilità del reato diverso.
Proprio sui connotati della prevedibilità emergono le maggiori ambiguità giurisprudenziali nell’applicazione dell’art. 116 c.p. in senso costituzionalmente orientato.
Del resto, l’esigenza della prevedibilità del reato diverso – quale coefficiente di colpevolezza – era già stata espressa con una sentenza della Corte Costituzionale del 1965. Essa però evitava di chiarire la natura di tale requisito, garantendo così uno spazio di legittimità a quell’orientamento giurisprudenziale incentrato sul carattere astratto della prevedibilità esaminata.
Secondo numerose pronunce della Suprema Corte, infatti, sarebbe sufficiente ravvisare un nesso di derivabilità logica tra tipi di reato per affermare la prevedibilità di quello non voluto. Questa prossimità astratta tra fattispecie legherebbe, ad esempio, la rapina e l’omicidio: il dolo inerente la prima ‘assorbirebbe’ sempre la morte non voluta, nonostante nel caso concreto quella specifica rapina non lasciasse presagire l’evento letale.
A ben guardare, il modello argomentativo adottato da quest’orientamento, ricorda le considerazioni sopra svolte circa la (opinabile) rilevanza di progressioni criminose standardizzate.
Richiamando dunque le considerazioni critiche svolte con riferimento all’art. 584 c.p., occorre sottolineare come l’approccio esaminato non permetta un superamento effettivo della responsabilità oggettiva.
La prognosi di prevedibilità non può esaurirsi in un raffronto tra tipi astratti, ma deve basarsi su quanto un uomo ragionevole – considerate le circostanze concrete conosciute o conoscibili – poteva prevedere. Solo così il giudizio di colpevolezza può davvero rappresentare la rimproverabilità dell’autore specifico e concreto per il fatto cagionato, garantendo peraltro il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
In tal senso si esprime un secondo orientamento della Cassazione, sviluppatosi in particolare negli ultimi anni. Esso, valorizzando la giurisprudenza costituzionale del 1988 e del 2007, esige un accertamento della prevedibilità ancorato alla situazione concreta, permeando così l’art. 116 c.p. della colpa richiesta costituzionalmente.
L’esigenza vitale di qualsiasi ordinamento è la coerenza complessiva, a partire da quei principi – enucleati dalla Costituzione – che innervano e limitano la potestà punitiva espressa dal diritto penale. Appaiono dunque preferibili quegli orientamenti interpretativi che – sia con riferimento all’art. 584 c.p., che con riferimento all’art. 116 c.p. – adeguano il significato letterale delle disposizioni al principio di colpevolezza ex art. 27, comma primo, Cost.
La questione non appare però complessivamente risolvibile senza una compiuta revisione del dato positivo.
Il codice del 1930, infatti, denota – soprattutto in tema di responsabilità oggettiva – un’ampia (e storicamente inevitabile) cesura rispetto all’impianto costituzionale, del quale – al contrario – dovrebbe essere derivazione logico-giuridica.
Solo una riforma legislativa in materia potrebbe quindi garantire quella convergenza di fondo tra dato positivo e principi costituzionali, essenziale per la tenuta – formale e sostanziale – del sistema penale. Allineamento questo, solo indirettamente raggiungibile tramite eventuali pronunce di incostituzionalità, inevitabilmente episodiche.
Tale esigenza risulta ancor più evidente in considerazione di un ulteriore aspetto. Anche le interpretazioni giurisprudenziali più strettamente adeguatrici non sono capaci di garantire un rispetto integrale del principio di colpevolezza. Ciò con particolare riferimento alla corrispondenza tra misura della pena e grado di rimproverabilità del fatto.
In particolare, nel caso di cui all’art. 584 c.p., il trattamento sanzionatorio risulta di gran lunga più gravoso rispetto a quello previsto per un fatto di lesioni dolose seguite da un omicidio colposo, secondo la disciplina del concorso formale di reati (quella corrispondente alla struttura del c.d. ‘dolo misto a colpa’).
Nell’ipotesi dell’art. 116 c.p., poi, l’imputazione colposa del reato diverso non esclude la punizione dello stesso secondo le norme previste per il delitto doloso. Unico temperamento è la circostanza attenuante prevista dal comma secondo dell’art. 116 c.p., che può condurre ad una diminuzione massima di un terzo della pena.
(Avv. Anna Marcoli)