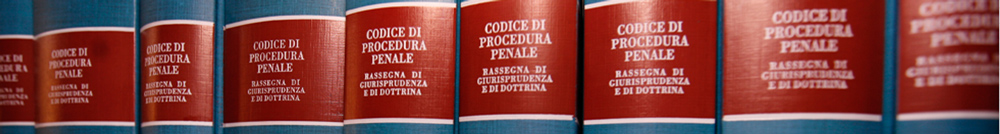Civile
Colpa medica e nesso causale in ambito civilistico
Colpa medica e nesso causale in
ambito civilistico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 16 ottobre 2007, n.
21619
Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell’11
giugno 1984, P.A. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Chiavari, l’USL
…omissis… della regione Liguria e il dott. C.L.,
esponendo:
– che il 28 novembre 1979, a seguito di una immersione in mare nei pressi di …omissis… con
apparecchio di respirazione, giunto alla profondità di 52 metri, era stato
costretto ad una rapida emersione a causa di un guasto al dispositivo di
riserva dell’aria;
– che, risalito in barca, aveva
accusato un intenso dolore al centro della schiena, accompagnato da nausea e
parestesia agli arti inferiori;
– che, fatto rientro al porto di
…omissis…, era stato trasportato in ambulanza
presso il locale ospedale;
– che, condotto in pronto
soccorso, era stato assistito dal medico di guardia dott. C., al quale aveva
manifestato il proprio timore circa le conseguenze di un’embolia gassosa;
– che il sanitario, dopo averlo
fatto sdraiare, gli aveva somministrato ossigeno per circa 10 minuti,
tranquillizzandolo e invitandolo a far ritorno a casa;
– che, pur avendo prospettato
l’opportunità di un ricovero presso l’ospedale di Genova per un trattamento in
camera iperbarica, era stato rassicurato dal C., che si era dichiarato esperto
in materia;
– che, tornato a piedi al porto
ed effettuate le operazioni di ormeggio della sua imbarcazione, aveva fatto
ritorno a casa dove, intorno all’una della notte, si era ridestato in
condizioni di tetraparesi;
– che, trasportato in ambulanza
al pronto soccorso dell’ospedale di …omissis… e visitato alle ore 1.25, era
stato immediatamente trasferito all’ospedale …omissis… e sottoposto (erano
ormai le ore 3.05) a trattamento in camera iperbarica;
– che il 22 dicembre era stato
dimesso da quel nosocomio con diagnosi di paraparesi da malattia da decompressione;
– che, nuovamente ricoverato
presso lo stesso ospedale dal 7 gennaio al 16 febbraio 1980, era stato
definitivamente dimesso, con prescrizione di trattamento terapeutico e
riabilitativo a seguito di una invalidità
quantificabile intorno al 60%.
Tanto premesso, l’attore,
contestata una grave colpa professionale al C. – che, pur avendo diagnosticato
una sospetta embolia gassosa, aveva omesso di avviarlo immediatamente al più
vicino centro iperbarico, ciò che avrebbe consentito una cura della malattia
tale da impedire i gravi esiti compromissivi della sua salute – ne chiese la
condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il giudice di primo grado
respinse la domanda, valorizzando la deposizione resa dalla teste T.
(infermiera presente al momento del ricovero dell’attore in pronto soccorso,
secondo la quale il P., quantunque insistentemente invitato dal medico a
sottoporsi al ricovero in adeguata struttura ospedaliera, lo aveva rifiutato),
e ritenendo che la decisione del C. di barrare, sul referto, la casella
"si dimette", anzichè quella "rifiuta il ricovero" fosse
stata in realtà consone alla vicenda, per avere il paziente rifiutato non il
ricovero ma il trasferimento in altra struttura ospedaliera: avendo, per
l’effetto, escluso ogni profilo di colpa in capo al sanitario, il giudice di
primo grado non aveva preso in esame le risultanze delle due perizie d’ufficio
quanto al profilo del nesso causale.
La corte di appello di Genova,
investita dell’impugnazione del P., ne accolse il gravame, osservando, per
quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
– che il giudice di primo grado,
nell’escludere la colpa del C. sulla base della deposizione della teste T., non
aveva conseguentemente considerato in alcun modo la questione relativa al nesso
causale;
– che la questione andava
viceversa esaminata funditus, dovendosi in limine rilevare, nel comportamento
del sanitario, gli estremi di un comportamento connotato da grave imperizia e
imprudenza;
– che la valutazione
dell’elemento soggettivo dell’illecito attribuito al medico risultava, tra
l’altro, dalla perizia collegiale eseguita in grado di appello, ove era detto
che "il comportamento del dott. C…. è da considerarsi francamente
imprudente:
poichè
l’estrema variabilità sintomatologia della MDD dovrebbe rientrare nel
patrimonio delle comuni conoscenze di un medico di pronto soccorso, la
remissione dei sintomi comparsi subito dopo l’emersione non poteva
tranquillizzare nè esimere dalla messa in atto di provvedimenti tempestivi… la
condotta da seguire sarebbe stata quella di mettersi in contatto con il più
vicino centro di medicina iperbarica (Genova) e accordarsi per l’immediato
invio del subacqueo a mezzo ambulanza… nell’ipotesi che questi avesse
insistito per essere dimesso… sarebbe rimasto onere del medico di soddisfare
la procedura di rifiuto del ricovero e di adempiere all’ulteriore dovere di
informativa circa la natura dei sintomi premonitori dell’insorgenza di
paresi";
– che,
all’esito del raffronto tra le contrastanti (ma entrambe inattendibili, a
giudizio della corte) dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale
dall’infermiera T. e dalla moglie del P. (secondo la quale, nonostante le sue
insistenze per l’immediato avvio del marito in camera iperbarica, il sanitario
ne aveva reiteratamente esclusa la necessità) e alla luce di quanto emerso
dalle CTU, la colpa professionale del C. ben poteva dirsi provata sia sotto il
profilo dell’omissione delle necessarie precauzioni imposte dal caso di specie
(somministrazione di ossigeno soltanto al 30-40%, anzichè puro; mancato
contatto telefonico immediato con il centro iperbarico di Genova; protrarsi del
ricovero in pronto soccorso per circa un’ora; mancata prescrizione del pur
necessario riposo assoluto; mancata refertazione delle dimissioni del paziente
contro la volontà del medico);
– che la questione del nesso
causale tra la condotta del sanitario e l’evento di danno lamentato
dall’appellante, avendo ricevuto discordanti soluzioni dalle consulenze
espletate in primo e secondo grado (il CTU nominato dal tribunale, difatti, in
una prima consulenza, aveva sostenuto che l’intervallo di tempo tra la comparsa
dei sintomi e l’inizio del trattamento in camera iperbarica era da ritenersi
irrilevante, con conseguente esclusione di qualsivoglia nesso causale tra il
comportamento del sanitario e la grave compromissione permanente delle
condizioni fisiche del P.; in un secondo elaborato, redatto all’esito di una
consulenza di parte, egli aveva modificato tali conclusioni ritenendo ragionevole
la presunzione probabilistica – anche se non quantificabile in termini
percentuali – che un più tempestivo intervento terapeutico avrebbe potuto in
qualche maniera modificare il decorso della malattia; i consulenti nominati in
secondo grado avevano a loro volta condiviso le conclusioni di questa seconda
perizia, precisando – con il supporto di dati statistici da essi stessi
definiti, peraltro, "disaggregati" – che il ritardo nel trattamento
corrispondeva comunque ad una perdita di chance (senza che in concreto l’entità
di tale perdita fosse nella specie quantificabile) andava risolto nel senso
della sua esistenza, sub specie della predicabilità di un esito diverso nell’an
e nel quantum della malattia in caso di un corretto trattamento sanitario (in
concreto non eseguito);
– che, pertanto, la violazione da
parte del medico delle regole tecniche da applicarsi nel caso di specie aveva
sicuramente compromesso consistenti aspettative di guarigione o di esiti
permanenti meno gravi per il danneggiato, anche se il risultato favorevole
dell’appropriata terapia sarebbe stato possibile, ma non certo;
– che, in sede di quantificazione
del danno, tali premesse imponevano l’individuazione di un coefficiente di
riduzione del quantum risarcitorio, da fissarsi equitativamente nella misura
del 50%.
Avverso tale
sentenza, C.L. ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto da due
motivi di gravame.
Si è costituita in questa sede,
con atto definito "controricorso" (in realtà, avente piuttosto natura
di ricorso incidentale adesivo alle censure svolte dal ricorrente principale), la ASL
n. …omissis… (già USL …omissis… della regione …omissis…),
condannata in solido con l’odierno ricorrente al risarcimento dei danni così
come liquidati dalla corte genovese.
Ha resistito con controricorso
P.A..
Sono depositate agli atti memorie difensive di entrambi i controricorrenti.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e il
controricorso dell’azienda sanitaria sono infondati, e la sentenza di secondo
grado va, pertanto, confermata, sia pur nei limiti e con le precisazioni in
diritto che di qui a breve seguiranno.
Va in limine osservato che i
motivi di censura contenuti nel controricorso ricalcano nella sostanza quelli
esposti nel ricorso principale, e ne consentono, pertanto, un esame congiunto.
Con il primo motivo, si duole il
ricorrente principale della violazione e falsa applicazione della norma di cui
all’art. 2697 c.c. e dei principi che regolano l’attribuzione dell’onere
probatorio; della carente, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia.
Nella esposizione del motivo, si
censura la sentenza impugnata nella parte in cui, esclusa l’attendibilità di
entrambi i testi escussi (l’infermiera e la moglie del P.), anzichè trarre da
tale carenza probatoria, la reciproca elisione delle deposizioni, la
conseguenza dell’assoluta mancanza di prova della colpa professionale del C.,
se ne sarebbe viceversa affermata erroneamente l’esistenza; e ancora, nella
parte in cui non era stato attribuito il necessario rilievo a quella parte di
CTU disposta in secondo grado, secondo la quale "l’indicazione di sottoporre
a ricompressione in camera iperbarica subacquei reduci da un episodio di
decompressione "anomala" ma asintomatici o non più sintomatici – come
nella specie – è stata a lungo controversa e non è del tutto pacifica…
all’epoca dei fatti non erano ancora state ufficialmente proposte le tabelle
ricompressive in ossigeno cd. "conservative" per soggetti
asintomatici… tuttavia non si può dire che vi aia accordo universale sulla
loro effettiva utilità" (i passi della CTU sono puntualmente riportati in
seno al motivo, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso).
Le censure non hanno pregio.
Con esse,
nella sostanza, si chiede a questa Corte di procedere ad un nuovo esame di
fatto delle risultanze processuali, onde pervenire alla conclusione (speculare
rispetto a quella adottata dal giudice del merito) della assoluta
impredicabilità di qualsivoglia elemento di colpevolezza in capo al ricorrente,
sub specie della imprudenza e imperizia grave a lui contestata in sede di
appello. Ma il motivo, sì come articolato, pur lamentando formalmente vizi
tanto di violazione di legge quanto di difetto di motivazione, si risolve, in
realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e
circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente,
difatti, lungi dal prospettare un vizio della sentenza gravata rilevante sotto
il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5,
nella parte in cui, ha ritenuto provato l’aspetto colposo del fatto ascritto al
C., si volge in realtà ad invocare una diversa lettura delle risultanze
procedimentali così come accertate e ricostruite dalla corte di merito,
muovendo così censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle
risultanze probatorie (non meno che il giudizio sull’attendibilità dei testi e
sulla credibilità di alcuni invece che di altri), così come la scelta, fra
esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il
quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una
ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e
ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello (ampiamente
osservato nella specie) di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza
processuale ovvero a confutare ogni e qual-siasi deduzione difensiva. E’ principio
di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360
c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di
Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal
giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione
delle fonti del proprio convincimento, valutando le prove, controllandone
l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla
dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi
di prove cd. legali, tassativamente previste dal
sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur
denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di
secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti
morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova
valutazione delle (ormai cristallizzate quoad effectum) risultanze fattuali del
processo – segnatamente con riguardo alle risultanze degli elaborati peritali
d’ufficio quanto ai ritenuti profili di colpa del C., nonchè alla decisiva
circostanza del referto di dimissioni del paziente non seguito dalla
annotazione del contrario avviso del sanitario, correttamente valorizzate dal
giudice di merito – ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente
il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente
tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità
maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto
ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciòsolo
censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata, quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse
ancora legittimamente invocabile in seno al giudizio di Cassazione.
Con il secondo motivo, lamenta
ancora il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41
c.p. e dei principi civilistici in materia di nesso causale; la carente,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.
La sentenza del giudice di
appello – si sostiene – sarebbe erronea altresì nella parte in cui si è
ritenuto esistente un nesso di causalità tra l’ipotetica condotta colposa
omissiva ascritta al C. e l’evento di danno, così disattendendo il principio di
diritto enunciato, con particolare autorevolezza, dalle sezioni unite penali di
questa stessa Corte regolatrice con la pronuncia 10.7.2002 (nota come sentenza
F.) in tema di reati omissivi.
Nella specie – si soggiunge –
occorreva accertare se il tempestivo inizio della terapia (dopo due ore e mezzo
anzichè nove) avrebbe evitato o, almeno, attenuato le
conseguenze lesive riportate dal P.; viceversa dalle stesse conclusioni dei CTU
di primo e secondo grado, alla luce delle espressioni usate, non poteva che
inferirsi l’inesistenza di un qualsiasi nesso causale tra l’ipotizzato ritardo
del trattamento terapeutico e gli eventi lesivi, giusta le conclusioni
predicate in punto di diritto, in subiecta materia, dalla citata sentenza a
sezioni unite di questa Corte.
In conclusione, essendosi i
consulenti espressi in termini meramente "possibilistici", senza
percentualizzare la eventuale miglior riuscita del
trattamento omesso, la corte di merito avrebbe dovuto trarre l’agevole
conclusione della insussistenza del nesso causale tra l’ipotizzata condotta omissiva
del sanitario e gli eventi lesivi e non anche "ridurre in via di equità il
risarcimento del danno subito dal P., fra l’altro nella percentuale, del tutto
immotivata e arbitraria, del 50%." Il motivo non merita accoglimento, ma
il richiamo alla sentenza delle sezioni unite penali e le articolate
argomentazioni in tema di nesso causale in esso svolte
impongono a questa corte una approfondita disamina della relativa questione di
diritto.
Il primo quesito che il motivo di
ricorso pone al collegio è quello della applicabilità, o meno, in sede di
giudizio civile, dei principi affermati dalle sezioni unite penali della Corte
di legittimità con riferimento al reato omissivo cd. improprio.
Impregiudicata, al momento, la
soluzione della questione predetta, occorre preliminarmente sgombrare il campo
da un equivoco nel quale lo stesso ricorrente incorre quando,
testualmente, afferma che il dictum delle sezioni unite penali avrebbe risolto
un contrasto tra due contrapposti orientamenti insorti in seno alle sezioni
semplici della Corte medesima. in realtà, gli
orientamenti espressi nel passato in subiecta materia dal giudice di
legittimità in sede penale risultano essere stati tre: il primo, maggioritario
e oggi disatteso dalle sezioni unite, che riconnetteva al concetto di nesso
causale il criterio delle serie e apprezzabili possibilità di successo della
condotta impeditiva omessa; il secondo, minoritario, fondato sul criterio della
probabilità coincidente o prossima alla certezza; il terzo, infine, fatto
proprio in sede di risoluzione di contrasto, dell’elevato grado di credenza
razionale.
In particolare, le sezioni unite
penali, nella sentenza F., evidenziano come lo schema condizionalistico
disegnato dagli artt. 40 e 41 c.p. vada ad integrarsi con il criterio della
sussunzione sotto leggi scientifiche, onde fornire garanzie di determinatezza
alla fattispecie mercè la ricerca e l’approdo ad un indissolubile legame della
causalità con i dati oggettivi che discendono dalle leggi scientifiche stesse.
Disattesa, così, la ricostruzione della causalità in termini di "serie e
apprezzabili possibilità di successo" (che viene
definita "nozione debole della causalità giuridica"), dacchè una
verifica siffatta verrebbe a sostituire all’oggettivo accertamento del nesso di
causa un mero accertamento dell’aumento del rischio, trasformando i reati
omissivi impropri in reati di pericolo o di mera condotta (e così violando i
principi di legalità, tassatività e tipicità delle fattispecie criminose), e
prese le distanze dall’orientamento della "probabilità prossima alla
certezza" (perchè una spiegazione causale di tipo deterministico e non
induttivo secondo criteri di utopistica certezza assoluta finirebbe con il
frustrare gli scopi preventivo-repressivi del processo penale), le ss.uu.
adottano, nella sostanza, l’orientamento intermedio dell’elevato grado di
credibilità razionale dell’accertamento giudiziale; così tracciando
definitivamente il confine tra probabilità statistica e probabilità logica:
("non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la
validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza
probatoria, disponibile") Premessa la indiscutibile condivisibilità (e
applicabilità tout court) del generalissimo principio che vuole preservato, in
capo al giudice, quel margine irrinunciabile quanto inevitabile di verifica
"logica" del rapporto di causalità al di fuori dei coefficienti
meramente statistici e di altre valutazioni provenienti dagli accertamenti
tecnico-scientifici, il primo interrogativo che il ricorso pone è quello della
applicabilità del principio di causa penalmente rilevante così ricostruito
dalle sezioni unite "anche al distinto settore della responsabilità
civile, a differenza di quanto avviene per il diritto anglosassone e
nordamericano" (come testualmente mostrano di ritenere i giudici di quel
collegio).
Prescindendo dai possibili
rilievi critici (non rilevanti in questa sede) da muoversi a tale ultima
affermazione (come osserva un’attenta dottrina, difatti, il dato comparatistico
porta piuttosto alla conclusione per cui anche nei
sistemi di common law la giurisprudenza civile sia venuta a muoversi su piani
diversi rispetto alle corti penali, avendo sviluppato maggiormente e in modo
decisamente più incisivo teorie quali quella della causalità adeguata e del
rischio evitabile), è lo stesso principio della coincidenza tra concetto di
causalità in sede penale e di causalità in sede civile – sostenuta, in questa
sede, con particolare vis argomentativa dal ricorrente – che non può dirsi
condivisibile.
Come già da tempo una attenta dottrina ha ritenuto di sottolineare, invero, le
esigenze decostruttive e ricostruttive dell’istituto del nesso di causa sottese
al sottosistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte (nè
riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell’illecito aquiliano,
tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l’aspetto
funzionale.
Sotto il profilo morfologico,
difatti, va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina
penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto
verso l’autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa,
l’illecito civile (quantomeno a far data dagli anni ’60) intorno alla figura
del danneggiato; dall’altro, come, alla peculiare tipicità del fatto reato,
faccia da speculare contralto il sistema aperto ed atipico dell’illecito civile
(non è questa la sede per indagare funditus sul concetto di atipicità, se essa,
cioè, sia riferita al fatto inteso come accadimento storico ovvero come evento
di danno – e giammai, comunque, alle conseguenze dannose del fatto -, evento di
danno che, a far data dagli anni ’70, dottrina e giurisprudenza di questa
stessa corte hanno più correttamente evidenziato come vero baricentro
dell’illecito per vulnerare alfine la limitazione dell’art. 2043 c.c. ai soli
diritti soggettivi assoluti).
Sotto il profilo funzionale, in
sintonia con la più attenta dottrina, va considerato:
– da un canto, che la valutazione
del nesso di causa, fondata esclusivamente sul semplice accertamento di un
aumento (o di una speculare, mancata diminuzione) del rischio in conseguenza
della condotta omessa, è criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale,
poichè realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo
improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta), mentre
la stessa preoccupazione non pare esportabile in sede civile, dove l’accento è
posto, ormai, sul concetto di "danno ingiusto";
– dall’altro lato, come ancora
osservato in dottrina, che conseguenza della atipicità dell’illecito è la sua
interazione con altre discipline (economiche e sociali, e non necessariamente
solo scientifiche, funzionali, queste, in sede penale, a svolgere il compito di
"legge di copertura"), onde pervenire al risultato finale di costruire
una credibile teoria della prevenzione efficiente del costo sociale dei danni,
allocando la responsabilità (anche) secondo criteri elastici
che si strutturano (ormai da almeno un trentennio) seguendo una sempre più
notevole ed accurata individuazione (specie in campo medico – professionale)
delle tecniche giuridiche attraverso le quali pervenire ad una più articolata e
complessa distribuzione dei rischi comunque e sempre collegati a tale attività.
Tale evoluzione segue, non a
caso, la parallela evoluzione delle strutture e della natura stessa della
responsabilità civile che, immaginata, all’epoca della codificazione del 1942, in una dimensione
sinergica tra una vera e propria Generalklausel (l’art. 2043 cit.) e le
successive norme esemplificative, secondo una struttura aperta dell’illecito,
ma pur sempre secondo funzionalità di tutela dei (soli) diritti soggettivi
assoluti, viene via via "ripensata" come storia (anche e soprattutto
intellettuale) sempre più raffinata, come un problema di diritto vivente da
rielaborare incessantemente secondo modelli dettati dalle complesse istanze
sociali, in funzione della ricerca di criteri sempre più articolati di
attribuzione di un determinato "costo" sociale, da allocarsi di volta
in volta presso il danneggiato ovvero da trasferire ad altri soggetti (sempre
più spesso, non necessariamente i diretti danneggianti).
Il sottosistema della
responsabilità civile diventa, così, un satellite sperimentale di ingegneria
sociale (che si allontana definitivamente dall’orbita dello speculare
sottosistema penalistico), demandata, quanto a genesi e funzioni, quasi
interamente agli interpreti, il cui compito diviene sempre più lo studio dei
criteri di traslazione del danno. In questo quadro, il sottosistema della
responsabilità medica diviene, in questo quadro, il topos
"disfunzionale" al suo stesso interno rispetto agli schemi classici
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dell’obbligazione di
mezzi e di risultato, dove un tempo "pendolare" segna diacronicamente
tappe non lineari e non armoniche, per produrre nuovi, repentini e talvolta
sorprendenti legami di senso e di struttura tra fatti concreti – l’intervento
del medico – e moduli giuridici – la sua responsabilità – un tempo tra sè
alieni, che officia la mutazione genetica della figura del professionista, un
tempo genius loci ottocentesco, oggi ambita preda risarcitoria).
La disamina che precede conduce,
dunque, ad una prima conclusione, che impone il rigetto, in parte qua, del
motivo di ricorso: il modello di causalità sì come disegnato funditus dalle
sezioni unite penali mal si attaglia a fungere da criterio valido anche in sede
di accertamento della responsabilità civile da illecito omissivo del sanitario.
Resta l’interrogativo sui criteri
idonei a tracciare le linee-guida del corretto accertamento del nesso di causa
in sede di illecito aquiliano da condotta omissiva del sanitario.
Da tempo la dottrina evidenzia
come, in sede civile, l’elaborazione di criteri di individuazione e valutazione
della relazione causale tra il fatto e l’evento (e/o tra l’evento e il danno)
ha sovente condotto ad approdi ermeneutici non certo caratterizzati da coerenza
e univocità.
Questo collegio non può non
rilevare, in limine, come tale inquietante disomogeneità di criteri e di
pensiero si rivelerà come costante proprio di questa stessa giurisprudenza di
legittimità, sovente chiamata a risolvere, in materie sicuramente delicate,
come l’infortunistica o la responsabilità professionale, singole quanto
complesse vicende, umane e processuali, le cui peculiarità specifiche mal si
attagliano ad unitarie e articolate generalizzazioni teoriche.
Di qui, il contrasto, tra
decisioni recenti di questa Corte tuttora non univoche su temi di ampio
respiro, che potrebbero non a torto essere definite "macroaree di
conflitto", quali: 1) il concetto di (e le differenze tra) causalità
materiale e causalità giuridica; 2) il criterio di collegamento da adottare
(alto grado di probabilità, probabilità, seria ed apprezzabile possibilità,
semplice possibilità – con riguardo a quella peculiare fattispecie costituita dalla cd. "perdita di chance" -) tra la condotta e
l’evento di danno;
3) la collocazione del fortuito
nell’area della colpa ovvero nel territorio del nesso causale; 4) la
commistione, ovvero la rigida separazione logica e cronologica, tra gli
elementi strutturali dell’illecito: la colpa, il nesso causale.
Vero è che la natura stessa della
fattispecie del nesso di causa si presenta, come già questa Corte ha avuto modo
di affermare (Cass. 7997/2005) di per sè come un vero e proprio ossimoro fin
dal momento in cui se ne predicano semplici quanto insopprimibili esigenze
gnoseologiche. L’incipit di ogni indagine in tema di nesso causale, difatti, ne
propone ad ogni passo "l’accertamento", ogni scritto sul tema della
causalità anela "all’accertamento del nesso causale", muovendo così,
del tutto inconsapevolmente, su di un terreno già assai scivoloso, se lo stesso
sintagma "accertamento del nesso causale" cela una prima, latente
insidia lessicale, dacchè ogni "accertamento" postula e tende ad una operazione logico-deduttiva o logico-induttiva che
conduca ad una conclusione, appunto, "certa"; mentre un’indagine, per
quanto rigorosa, funzionale a predicarne l’esistenza sul piano del diritto, si
arresta, sovente, quantomeno in sede civile, sulle soglie del giudizio
probabilistico (sia pur connotato da un diverso livello di intensità, dalla
"quasi certezza" alla "seria ed apprezzabile possibilità").
La questione del nesso causale in
seno al sottosistema della responsabilità civile è, dunque, ancora ben lungi dal potersiritenere avviata a soddisfacente soluzione.
Una compiuta indagine
sull’aspetto genetico dell’istituto del nesso causale conduce ad una prima,
significativa rilevazione ermeneutica, quella per cui
nulla di realmente definito parrebbe emergere dalle fonti legislative, penali e
civili, sul tema della causalità in sè considerata: l’art. 40 c.p., rubricato
"rapporto di causalità", stabilisce che "nessuno può essere
punito… se l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza
della sua azione od omissione", fissando il solo principio di equivalenza
fra il non fare ed il cagionare, e discorrendo genericamente di "conseguenze"
al momento di individuare caratteri e peculiarità del nesso tra condotta ed
evento; il successivo art. 41 c.p. si occupa del concorso di cause, per
stabilire poi, in modo apparentemente superfluo, il principio
"dell’interruzione del nesso causale" conseguente all’intervento di
quella causa "sufficiente da sola a determinare l’evento". Gli artt.
1227 e 2043 c.c. strutturano, rispettivamente, il rapporto tra fatto – doloso o
colposo – ed evento – dannoso – in termini di "cagionare", senza
ulteriori specificazioni, mentre l’art. 1223 c.c. si riferisce, come sovente
rilevato in dottrina e da questa stessa giurisprudenza, al nesso di
condizionamento che lega non la condotta all’evento, ma l’evento/inadempimento
ai danni/conseguenza, dei quali predica, a fini risarcitori, il necessario
carattere di "conseguenza immediata e diretta" dell’inadempimento o
del ritardo (in dottrina, si è affermato che l’art. 1223 c.c.,
e ss. dettano regole attraverso le quali il legislatore, presupponendo già
risolto il problema dell’imputazione – e quindi già accertata l’esistenza della
responsabilità – si preoccupa soltanto di determinare l’estensione della
stessa, risolvendo, così, un problema che non è più di causalità, ma di
ammontare del danno risarcibile.
Dal combinato disposto degli
artt. 40 e 41 c.p. deriverebbe, secondo l’orientamento prevalente (ma
autorevolmente contestato) in seno alla dottrina penalistica, un procedimento
bifasico funzionale all’accertamento del nesso causale: dapprima, mediante la
teoria della conditio sine qua non, si procede alla individuazione di tutte le
cause di un determinato evento; successivamente, procedendo lungo la strada che
conduce alla ipotetica interruzione del nesso di causa, si provvede a
circoscrivere ad alcune soltanto, tra le molteplici cause condizionanti di
ciascun evento, la possibile eziogenesi dello stesso.
Proprio questa
seconda fase dell’accertamento è stata e resta oggetto di un vivace
dibattito, che si protrae sin dall’800: la dottrina penalistica, nel tempo,
elaborerà un numero imprecisato di teorie sull’argomento: conditio sine qua
non; causalità adeguata e/o umana; scopo della norma violata; signoria
dell’uomo sul fatto; aumento del rischio.
La giurisprudenza civile, a sua
volta, pur non senza oscillazioni, si attesterà, in prevalenza, sulla linea di
confine ove tutti gli antecedenti causali, in mancanza dei quali non si sarebbe verificato l’evento lesivo, assumono rilievo
eziologico, abbiano essi agito in via diretta o soltanto mediata, salvo il
temperamento normativo della "causa prossima da sola sufficiente a
produrre l’evento".
Nel sistema della responsabilità
civile, la causalità assolve, comunque, alla duplice finalità di fungere da
criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il
successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto
che si traducono in danno risarcibile.
Essa va pertanto scomposta
(secondo l’opinione largamente prevalente) nelle due fasi corrispondenti al
giudizio sull’illecito (nesso condotta/evento) e al giudizio sul danno da
risarcire (nesso evento/danno).
Ed è opinione altrettanto
prevalente, in dottrina come in giurisprudenza, quella secondo la quale, nel
macrosistema civilistico, l’unico profilo dedicato espressamente dal
legislatore del ’42 al nesso eziologico sia quello
ricavabile dall’art. 2043 c.c. dove l’imputazione del "fatto doloso o
colposo" è addebitata a chi "cagiona" ad altri un danno
ingiusto.
Un’analoga disposizione sul danno
ingiusto, e non sul danno da risarcire, non è richiesta in tema di
responsabilità contrattuale o da inadempimento, perchè in tal caso il soggetto
responsabile è, di regola, il contraente o il debitore rimasto inadempiente.
Sicchè questa stessa giurisprudenza di legittimità, partendo dall’ovvio
presupposto di non dover identificare il soggetto responsabile del fatto
dannoso, ha individuato una serie di soluzioni "pratiche", caso per
caso, senza dover optare, in tema di responsabilità ex contractu, per una
precisa scelta di campo onde coniugare il "risarcimento del danno",
cui è dedicato l’art. 1223 c.c., con il rapporto di
causalità.
Il sistema operazionale di
valutazione e determinazione dei danni (anche extracontrattuali, in virtù del
rinvio operato dall’art. 2056 c.c.) appare, nel suo complesso, composto, comunque,
dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (nonchè, limitatamente alla sola
responsabilità contrattuale, dalla peculiare disposizione dell’art. 1225 c.c.: nel plesso costituito da tali norme trova altresì
cittadinanza il principio ricavabile dall’art. 1221 c.c. – effetti della mora
debendi sul rischio da impossibilità sopravvenuta della prestazione -, che si
fonda su di una inferenza di tipo ipotetico/differenziale tra la situazione
quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso e quella effettivamente
realizzatasi, id est il cd. giudizio "controfattuale"). Qui il
giudizio ipotetico assume il valore di criterio idoneo a valutare compiutamente
l’ammontare del danno patrimoniale, criterio dunque di causalità ipotetica, necessario onde non tramutare in (indebito) arricchimento il
(debito) risarcimento spettante al danneggiato.
Le disposizioni del capo 3^ del
libro delle obbligazioni in tema di inadempimento hanno in comune, dunque, la
funzione di adeguare il risarcimento al danno effettivamente subito dal
danneggiato e di allocare presso il responsabile le conseguenze delle
ripercussioni patrimoniali sfavorevoli che il danneggiato non può dover subire.
Sul piano della operatività
concreta, peraltro, le norme hanno una distinta funzione e la disposizione
dell’art. 1223 c.c. si pone, rispetto alle altre, in termini di vero e proprio
ius singultire, poichè con essa l’ordinamento limita
il risarcimento alla perdita subita ed al mancato guadagno (che conseguono
tipicamente, in base all’id quod plerumque accidit, al fatto dannoso del tipo
di quello verificatosi) in quanto conseguenze immediate e dirette
dell’inadempimento o di altro fatto dannoso, così allocando presso il
danneggiante non una qualsiasi ripercussione patrimoniale, ma ciò che
costituisce il danno vero e proprio (id est, il "danno ingiusto"). E
a ciò si giunge attraverso un giudizio ipotetico/differenziale tra condizione
(dannosa) attuale e condizione del danneggiato quale sarebbe
risultata in assenza del fatto dannoso.
Per quanto concerne i rapporti
che intercorrono tra il comportamento antigiuridico del soggetto agente ed il
fatto (o evento), e tra quest’ultimo ed il danno propriamente detto, la loro
identificazione muta a seconda che il danno sia ritenuto un elemento
qualificante il "fatto illecito" (e dunque interno alla stessa
fattispecie sul piano morfologico) ovvero soltanto un effetto dello stesso (e
per ciò stesso, al di fuori di essa, attenendo esso al
piano effettuale).
Va allora ribadito che, secondo
l’opinione assolutamente prevalente, occorre distinguere nettamente: da un lato
sta il nesso, che deve sussistere tra comportamento ed evento perchè possa
configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale"
(Haftungsbegrundende Kausalitat); dall’altro, sta il nesso che, collegando
l’evento al danno, consente l’individuazione delle singole conseguenze dannose,
con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già
accertata) responsabilità risarcitoria (Haftungsausfullende Kausalitat).
Un paradigma normativo della
distinzione, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, è ravvisabile,
rispettivamente, nel primo e nell’art. 1227 c.c.,
comma 2. La prima, partendo della disposizione (se il fatto colposo del
creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo
la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate),
lascia chiaramente intendere che il legislatore ha preso
in esame l’ipotesi in cui il fatto del creditore/danneggiato interviene a
spezzare il legame, a monte, tra comportamento del soggetto agente ed evento,
escludendo così la totale imputabilità del fatto all’agente, e limitando di
conseguenza la responsabilità di quest’ultimo. Il comma 2, al contrario (il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza), chiarisce in che modo il
fatto del creditore possa influire, a valle, sul diverso rapporto evento-danno,
e cioè rendendo non più risarcibili talune delle conseguenze immediate e
dirette dell’evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità
del danneggiante, e sia già stato determinato il risarcimento attraverso il
filtro dell’art. 1223 c.c..
Così, da una lettura sistematica
delle norme del codice civile vigente dettate in tema di risarcimento del
danno, sembra emergere un plesso operativo razionale e coerente, articolato
secondo un criterio di consequenzialità in virtù del quale il legislatore opera
una netta separazione tra il momento (strutturale) dell’accertamento della
responsabilità e quello (funzionale) del contenuto della stessa. Ma, mentre
nella responsabilità contrattuale, l’art. 1218 c.c. è volto unicamente a
sanzionare la condotta del debitore (inadempiente o in ritardo), la cui
identificazione costituisce un prius logico già esistente (che si compie
proprio attraverso il collegamento necessario con l’obbligazione rimasta
inadempiuta), nel territorio della responsabilità aquiliana l’inesistenza di un
titolo, e dunque di un rapporto già in atto tra danneggiante e danneggiato,
giustifica la più articolata disciplina contenuta in quella serie di norme
inserite nella prima parte del titolo 9^ del libro quarto (artt. 2043-2054
c.c.), che postula il previo accertamento del soggetto responsabile.
Risolto il problema della
imputazione del fatto, e dunque della identificazione del soggetto
responsabile, le norme in tema di responsabilità delimitano l’ambito della
risarcibilità delle singole conseguenze dannose attraverso una disciplina
parzialmente difforme nelle due diverse ipotesi di responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, per la limitazione, contenuta nella norma di rinvio
dell’art. 2056 c.c., in base alla quale viene esclusa
l’applicabilità dell’art. 1225 c.c. (prevedibilità del danno) nei casi di
obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito.
Quello che ancora giova
sottolineare, nella dimensione dell’illecito contrattuale, è la relazione
differenziale tra il disposto dell’art. 1223 c.c. in tema di risarcibilità di
danni "conseguenze dirette e immediate" dell’inadempimento, e quello
di cui al successivo art. 1225 c.c. che limita tale risarcimento, in caso di
inadempimento colposo, ai soli "danni prevedibili".
Pur vero che la prima delle due
norme regola il nesso di causa non tra condotta ed evento, ma tra l’evento
(l’inadempimento) e il danno risarcibile (e, come si è avuto modo di
sottolineare in precedenza, secondo una attenta
dottrina non sarebbero neppure funzionali all’accertamento del nesso di
causalità condotta/evento di danno), questo Collegio ritiene che possa non
illegittimamente ipotizzarsi come il concetto di prevedibilità resti comunque
estraneo, in parte qua, alla struttura oggettiva dell’illecito (perchè, in caso
di inadempimento doloso, il debitore risarcirà sì i danni imprevedibili, ma che
siano pur sempre conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento, di talchè
la "diretta immediatezza" della realizzazione del danno non è
destinata ad incidere sulla sua prevedibilità).
Di talchè, come correttamente
mostra di ritenere anche il giudice del merito nella sentenza impugnata, il
nesso di causalità è elemento strutturale dell’illecito, che corre – su di un
piano strettamente oggettivo – tra un comportamento (dell’autore del fatto)
astrattamente considerato (e non ancora qualificabile come generatore di un
damnum iniuria datum), e un evento (dannoso).
Nell’individuazione di tale
relazione primaria tra condotta ed evento si prescinde in prima istanza da ogni
valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata",
da parte dell’autore del fatto, essendo il concetto di prevedibilità/previsione
insito nella fattispecie della colpa (elemento qualificativo del momento
soggettivo dell’illecito, momento di analisi collocato in un ideale posterius
rispetto alla ricostruzione della fattispecie). Solo il positivo accertamento
del nesso di causalità materiale così rettamente inteso consente, allora, la
traslazione, logicamente e cronologicamente conseguente sul piano dimostrativo,
verso la dimensione dell’illecito costituito dal suo elemento soggettivo, e
cioè verso l’analisi della sussistenza o meno della colpa dell’agente (o, se
del caso, del dolo), co-elemento di fattispecie la cui impredicabilità nella
singola vicenda, pur in presenza di unnesso causale
accertato, ben potrebbe escludere l’esistenza dell’illecito secondo criteri
(storicamente "elastici") della prevedibilità ed evitabilità del
fatto. Criteri questi che restano iscritti nell’orbita dell’elemento soggettivo
del fatto dannoso e postulano il positivo oggettivo accertamento del
preesistente nesso causale, elemento strutturale del torto al quale non è
consentito di collegare alcuna inferenza fondata sulla dicotomia
colpevolezza/incolpevolezza, attenendo tale aspetto al successivo momento di
valutazione della colpa.
Se, in altri termini, in tema di
responsabilità medica, il comportamento del sanitario è astrattamente
configurabile in termini di gravissima negligenza, ma il paziente muore (illico
et immediate, e prima che la negligenza possa spiegare i suoi effetti causali
sull’evoluzione del male) per altra patologia, del tutto (o anche solo
"probabilmente") indipendente dal comportamento del sanitario stesso,
l’indagine sulla colpevolezza di questi è preclusa dalla interruzione del nesso
causale tra il suo comportamento (omissivo o erroneamente commissivo) e
l’evento.
La relazione che lega nesso
causale e colpa è, dunque, la stessa che collega la probabilità alla
prevedibilità, concetti afferenti dimensioni diverse di valutazione e di
giudizio, se si consideri che anche ciò che è Improbabile ben può essere
prevedibile.
Deve pertanto concludersi sul
tema del nesso causale, che, in sede civile, esso è destinato inevitabilmente a
risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione
"storica", o, se si vuole, di politica del diritto, che, come si è da
più parti osservato, di volta in volta individuerà i termini dell’astratta
riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo
all’agente, secondo un principio guida che potrebbe essere formulato,
all’incirca, in termini di rispondenza, da parte dell’autore del fatto
illecito, delle conseguenze che "normalmente" discendono dal suo
atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non
ha il dovere o la possibilità di agire (la cd. teoria della regolarità causale
e del novus actus interveniens).
In questo modo, il nesso causale
diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni
riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e
quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma
violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza
comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione
– anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla
previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza
di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l’orbita
soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito.
Non è illegittimo immaginare,
allora, una "scala discendente", così strutturata:
1) in una diversa dimensione di
analisi sovrastrutturale del (medesimo) fatto, la causalità civile
"ordinaria", attestata sul versante della probabilità relativa (o
"variabile"), caratterizzata, specie in ipotesi di reato commissivo
(ndr: forse il riferimento è al reato omissivo), dall’accedere ad una soglia
meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo
modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale,
possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili
possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.), senza che questo
debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, senza che egli
perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente
opportune in un dato momento storico: senza trasformare il processo civile (e
la verifica processuale in ordine all’esistenza del nesso di causa) in una
questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente
tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del
"più probabile che non";
2) in una diversa dimensione,
sempre nell’orbita del sottosistema civilistico, la causalità da perdita di
chance, attestata tout court sul versante della mera possibilità di
conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da intendersi, rettamente,
non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come
sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale aspettativa (la
guarigione da parte del paziente) come "bene", come diritto attuale,
autonomo e diverso rispetto a quello alla salute.
Quasi certezza (ovvero altro
grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità sono,
dunque, in conclusione, le tre categorie concettuali che, oggi, presiedono
all’indagine sul nesso causale nei vari rami dell’ordinamento.
Vere le premesse metodologiche
che precedono, ben s’intende come la sentenza impugnata non meriti censure,
anche se la motivazione adottata dai giudici genovesi necessiti di correzioni
in parte qua.
La corte ligure ha ritenuto,
nella sostanza, di fondare il proprio convincimento in ordine alla concreta
predicabilità, nel caso di specie, della sussistenza del nesso di causa tra la
condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo lamentato dal P. sia sulla
seconda consulenza Ce., ove si discorre di ragionevole
probabilità (ancorchè percentualmente non quantificabile) che un più tempestivo
intervento terapeutico avrebbe potuto modificare il decorso della MDD
presentata dal paziente (folio 19 della sentenza), sia sulla consulenza
collegiale espletata in grado appello (che, premessa l’esistenza di risultati
incoraggianti per terapie ricompressive effettuate entro i primi 30 minuti,
sottolinea peraltro la disomogeneità della casistica in materia, specificando
ulteriormente l’impossibilità di percentualizzare a priori la probabilità di
completa guarigione o di esiti meno gravi in caso di trattamento effettuato
entro 2-3 ore rispetto a quello concretamente avvenuto, dopo 9 ore, che
"presenterebbe comunque un più basso grado di probabilità").
Al di là della
terminologia usata (al folio 21 della sentenza si parla di possibilità e
non di certezza del risultato favorevole dell’appropriata terapia), il giudice
del merito mostra chiaramente di ritenere (e l’apprezzamento non è censurabile
in questa sede, dacchè sorretta da ampia e congrua motivazione) "più
probabile che non" l’esistenza del nesso di causa tra il comportamento
omissivo del sanitario e le lesioni subite dal P., dovendosi a tale proposito
espungere dalla parte motiva della sentenza l’espressione (contenuta al folio
21) relativa alla compromissione di aspettative di guarigione, poichè, in tale
passaggio, il giudice di merito mostra chiaramente di confondere il danno da
lesione alla salute da quello da perdita di chance.
Non è compito di questo collegio
affrontare il tema del criterio risarcitorio adottato in sede di merito, non
avendo, in proposito, svolto censure nè il ricorrente, nè il
"controricorrente" adesivo (al di là di una generica quanto
inammissibile doglianza, non motivata sotto alcun profilo), e non avendo, di
converso, proposto alcuna impugnazione incidentale il danneggiato P..
Il ricorso è pertanto rigettato.
Equi motivi suggeriscono
l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio di cassazione interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 18 maggio
2007.
Depositato in Cancelleria il 16
ottobre 2007.